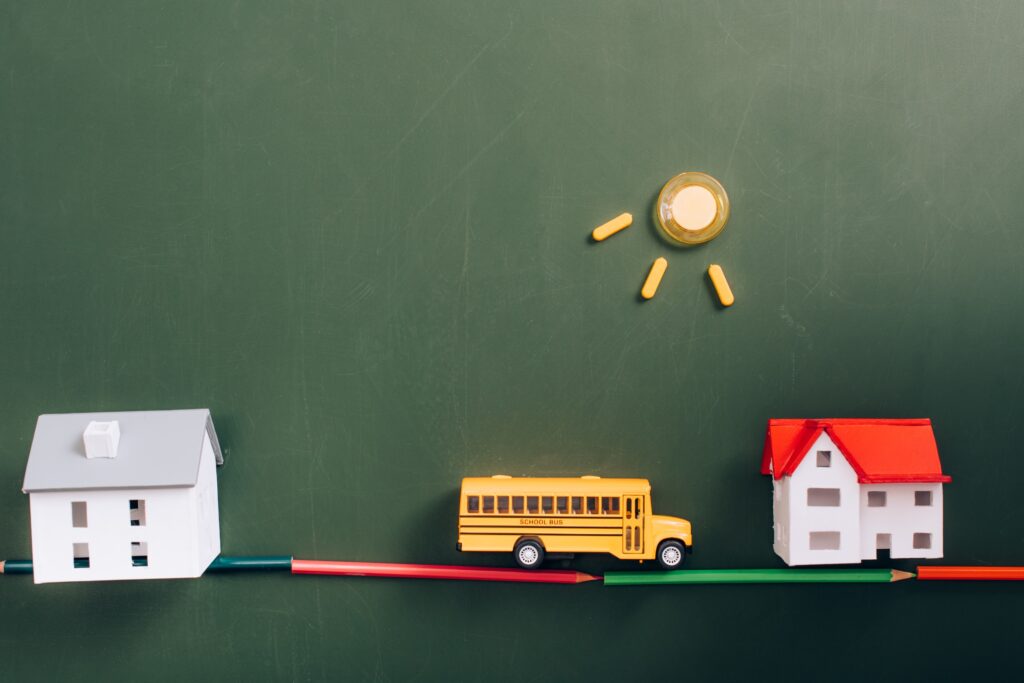Quiet quitting: il distacco emotivo dal lavoro Quiet quitting: cosa significa, cos’è, quando e dove nasce, motivi del disagio e conseguenze aziende e i lavoratori
Che cos’è il quiet quitting
Il quiet quitting è un fenomeno che riguarda il mondo del lavoro. Nello specifico si riferisce a un atteggiamento dei dipendenti, i quali scelgono di svolgere solo le mansioni strettamente previste dal contratto, rifiutando qualsiasi compito extra o disponibilità che esuli dagli orari e dalle responsabilità formali.
Non si tratta di un vero e proprio “licenziamento” (quitting), quanto piuttosto di una ritirata silenziosa dall’idea di lavoro come vocazione o dedizione totale. È una forma di resistenza passiva contro la cultura del lavoro eccessivo.
Origine del termine “quiet quitting”
Il termine quiet quitting non ha un vero e proprio “fondatore”. Il vocabolo è stato portato alla ribalta da un video pubblicato su TikTok nel 2022 da Zaid Khan, un ingegnere statunitense. Nel video, Khan parla della decisione di lavorare nei limiti del proprio ruolo senza sentirsi in dovere di fare di più per ottenere approvazione o promozioni. Le sue affermazioni e idee hanno immediatamente guadagnato popolarità, venendo riprese da milioni di utenti e analizzate da media internazionali e professionisti delle risorse umane.
Il fenomeno però esiste da decenni. Sono numerosi infatti gli psicologi che da tempo invocano ambienti di lavoro di qualità, capaci di stimolare i propri dipendenti, farli sentire realizzati, senza trascurare l’ascolto dei loro bisogni personali.
Quando e dove si è sviluppato
Il quiet quitting ha cominciato a diffondersi quindi con prepotenza nel 2022 negli Stati Uniti, in un contesto segnato dalle conseguenze della pandemia da COVID-19. Lo smart working, l’isolamento sociale e la riflessione collettiva sulla qualità della vita hanno spinto molti lavoratori — soprattutto i millennials e la Generazione Z — a rivalutare il proprio rapporto con il lavoro. Da lì il concetto si è diffuso rapidamente in Europa e in altri Paesi industrializzati, trovando terreno fertile in un’epoca di crescente attenzione al benessere psicologico e all’equilibrio tra la vita privata e quella professionale.
In che cosa consiste il quiet quitting
Il quiet quitting consiste in pratica nel:
- rifiutare straordinari non retribuiti;
- evitare di rispondere a e-mail o messaggi fuori orario;
- non assumersi responsabilità extra non riconosciute formalmente;
- non legare la propria identità al lavoro.
Non significa essere improduttivi o svogliati, ma rispettare i limiti del proprio ruolo professionale, evitando di “vivere per lavorare”. È quindi una forma di dissenso silenzioso verso modelli di carriera basati sul sacrificio personale continuo.
I motivi alla base del quiet quitting
Il fenomeno del quiet quitting non è determinato solo da un diverso modo di concepire il lavoro e da una attenzione maggiore alla salute mentale. Ci sono altre ragioni, più importanti e decisamente più profonde.
Il malessere dei lavoratori è legato infatti a tutta una serie di fattori sui quali è necessario riflettere.
- Il rapporto con il proprio datore di lavoro, spesso distante e fondato su una relazione gerarchica e di potere che ostacola la comunicazione.
- La scarsa attenzione all’adozione di strategie capaci di ridurre lo stress sul lavoro e il bournout.
- Il mancato supporto psicologico attraverso programmi specifici per i lavoratori.
- L’assenza di motivazione, determinata da un ambiente in cui il singolo non viene valorizzato.
- Il mancato riconoscimento del merito e dell’impegno.
- L’assenza di programmi di formazione continua, che impediscono la crescita del lavoratore.
- La paura di cambiare lavoro, soprattutto a una certa età, fobia che porta molti lavoratori a restare dove sono e a cercare un distacco emotivo sempre maggiore dalle mansioni.
- Una scarsa cultura della promozione e valorizzazione del lavoro di gruppo.
Conseguenze del quiet quitting
Le conseguenze del quiet quitting sono complesse e oggetto di dibattito.
Per i lavoratori:
- può portare a un miglior equilibrio vita-lavoro;
- può ridurre lo stress e il burnout;
- ma rischia di limitare le possibilità di avanzamento professionale o di essere percepiti come “disimpegnati”.
Per le aziende:
- può tradursi in cali di produttività, soprattutto se molti dipendenti adottano questo approccio;
- può spingere a rivedere modelli di leadership troppo esigenti o poco inclusivi;
- può aumentare il turnover se non si affrontano le cause profonde (scarsa motivazione, carenza di riconoscimento, cultura aziendale tossica).
Un messaggio alle imprese
È importante precisare che il quiet quitting non è un capriccio generazionale, ma un segnale chiaro di disaffezione verso modelli di lavoro non più sostenibili. E’ necessario che le aziende ascoltino con attenzione le esigenze dei dipendenti. Ignorare questo fenomeno può rivelarsi pericoloso e improduttivo.
Leggi anche gli altri articoli dedicati alle regole del mondo del lavoro