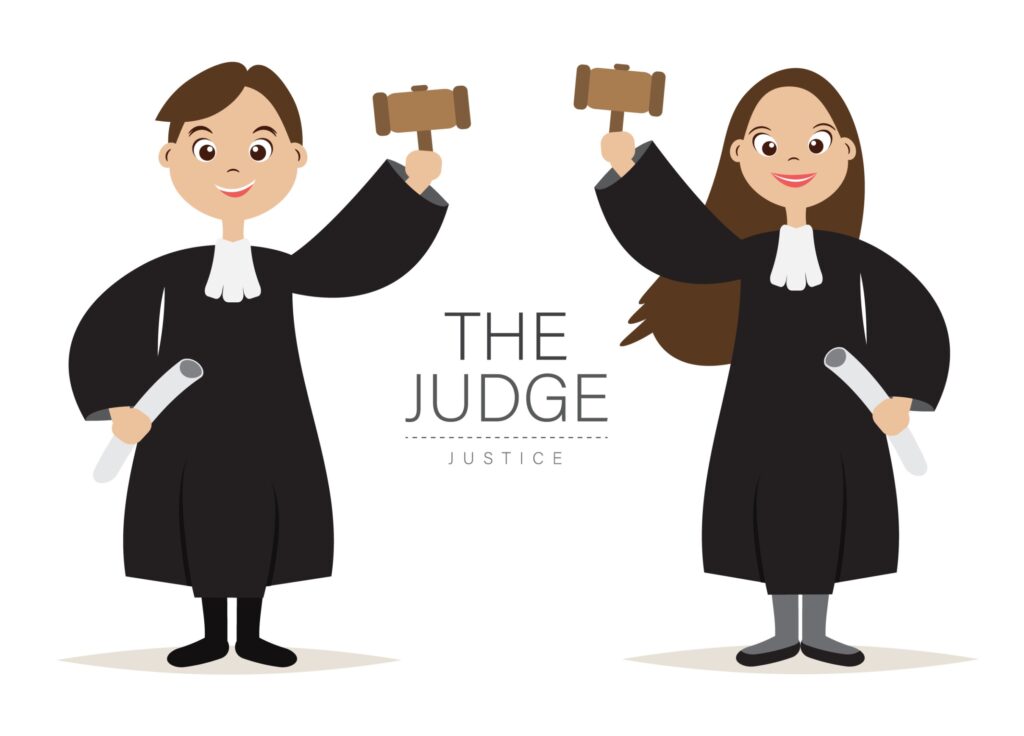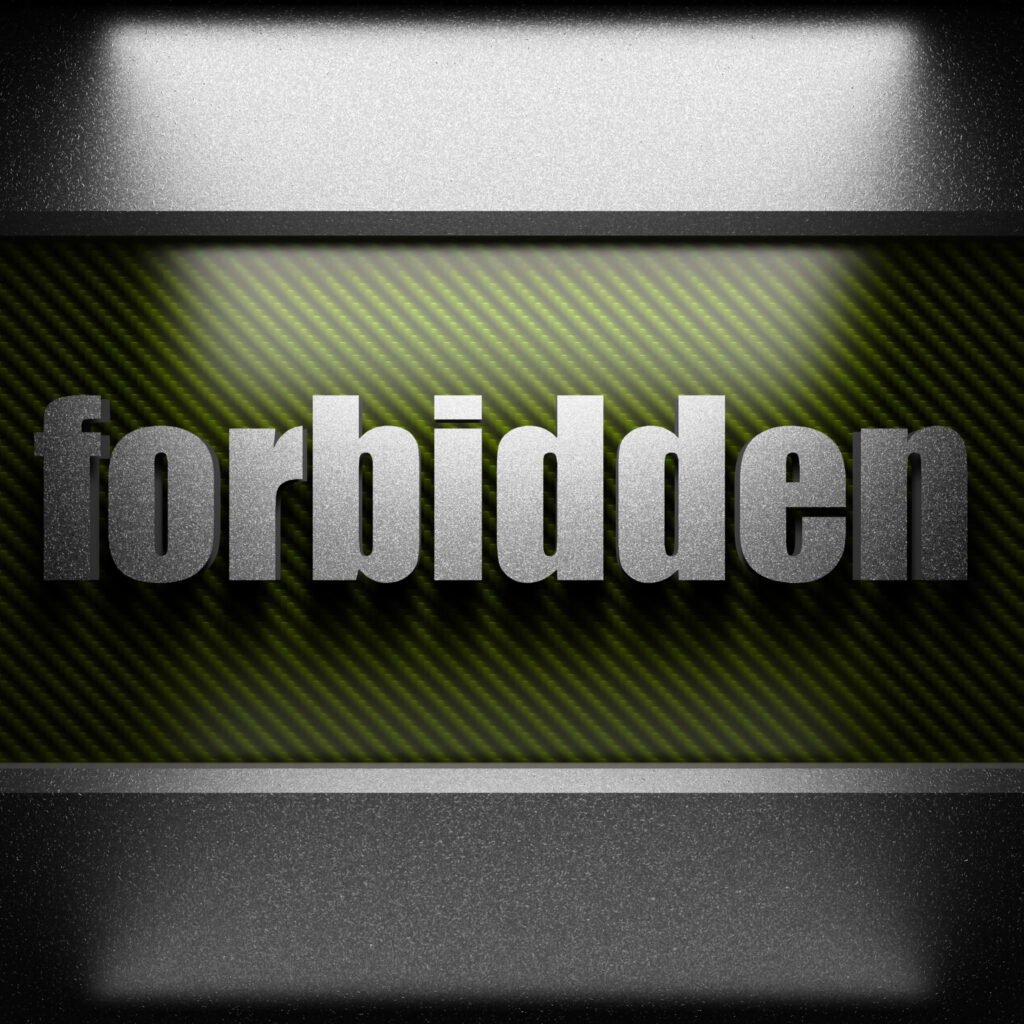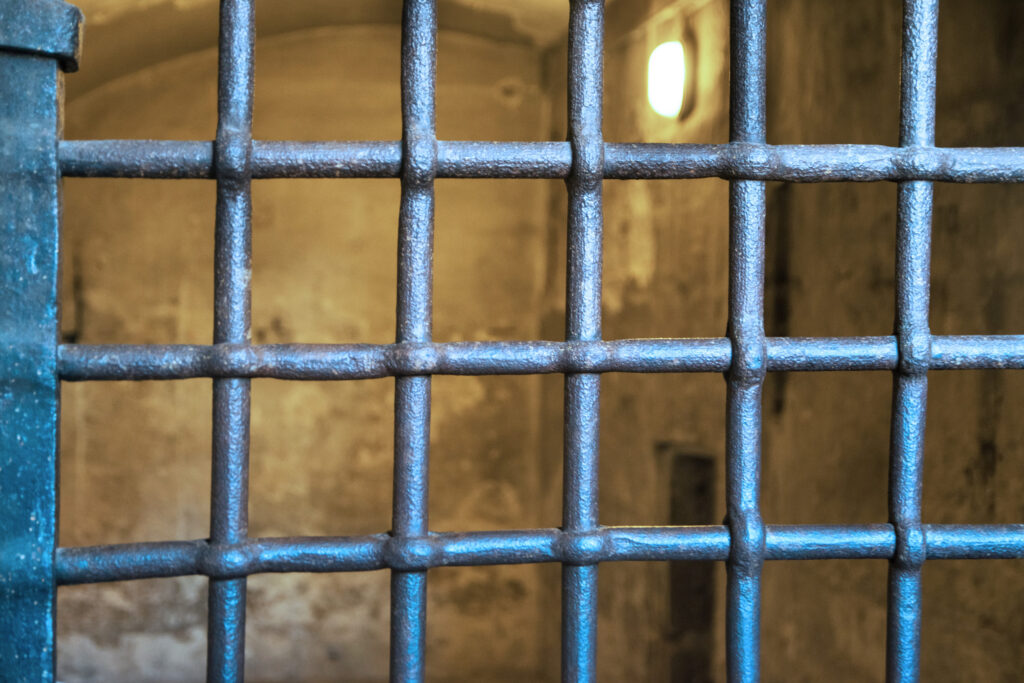Conti correnti: obbligo di apertura e divieto di recesso Conti correnti: ok della Camera alla proposta che prevede il diritto dei cittadini all’apertura del conto e vieta alla banca di recedere
Conti correnti: un diritto del cittadino
Il testo unificato di due proposte di legge (n. 1091 e n. 1240) appena approvato dalla Camera dei deputati all’unanimità (254 sì e nessun no) prevede importanti novità in materia di conti correnti. Le proposte mirano a introdurre l’art. 1857-bis nel codice civile e a modificare l’art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), che si occupa delle clausole vessatorie relative ai contratti intercorrenti tra consumatori e professionisti.
Vediamo in breve in che cosa consiste il provvedimento approvato che ora passa al Senato per il sì definitivo.
Conti correnti: il nuovo articolo 1857-bis c.c.
Il nuovo articolo 1857 bis codice civile prevede per la banca abbia l’obbligo di aprire un conto corrente a chiunque lo richieda. La stessa non potrà rifiutarsi di farlo, a meno che non ci siano motivi specifici legati alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo.
Se la banca dovesse negare l’apertura del conto a causa di queste normative, sarà tenuta a comunicarlo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta, spiegando dettagliatamente il motivo del rifiuto.
Abrogazione comma 3 art. 33 Codice del Consumo
Il secondo comma dell’ articolo che compone il testo unificato prevede invece l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 33 del Codice del Consumo decreto legislativo n. 206/2005, che così dispone: “Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
- recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
- modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.”
Conti correnti: inclusione finanziaria
L’iniziativa legislativa vuole realizzare il principio dell’inclusione finanziaria, garantendo che chiunque possa avere accesso a un conto corrente. Ciò significa che la storia finanziaria personale, come precedenti segnalazioni alla Centrale Rischi, un passato da cattivo pagatore, protesti o insolvenze accertate, non potranno più rappresentare un ostacolo all’apertura del conto. L’unico caso in cui una banca potrà rifiutarsi di aprire un conto, o successivamente di chiuderlo, è la presenza di forti sospetti legati a pratiche di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, in base alle normative vigenti. Sempre nell’ottica dell’inclusione finanziaria la proposta prevede anche il divieto per le banche di recedere dal contratto di conto corrente in via unilaterale, se presenta un saldo attivo.
Leggi anche gli altri articoli in materia di diritto civile