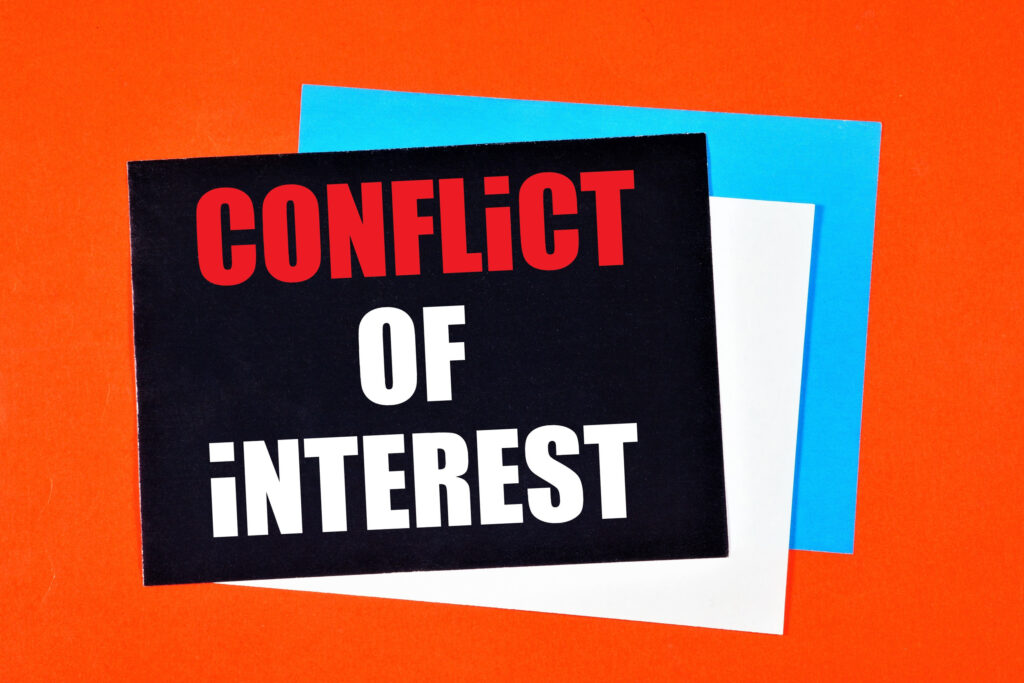Spaccio di lieve entità: sì alla messa alla prova La Corte costituzionale dichiara illegittima l’esclusione del reato di spaccio di lieve entità dalla sospensione con messa alla prova
Spaccio di lieve entità e messa alla prova
Spaccio di lieve entità e messa alla prova: la Corte costituzionale, con sentenza n. 90 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 168-bis del codice penale nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990).
Le questioni di legittimità sollevate
Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dai Tribunali di Padova e Bolzano, i quali hanno censurato, in combinato disposto, l’articolo 168-bis, primo comma, c.p., l’articolo 550, secondo comma, c.p.p. e l’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti, come modificato dal decreto-legge n. 123 del 2023.
Quest’ultimo intervento normativo aveva innalzato la pena detentiva massima per il piccolo spaccio, portandola da quattro a cinque anni di reclusione. Di conseguenza, il reato risultava escluso dall’ambito applicativo della messa alla prova, che prevede un limite massimo edittale inferiore.
Il confronto con l’istigazione all’uso di stupefacenti
Secondo i giudici rimettenti, tale preclusione si traduceva in una violazione del principio di ragionevolezza e del finalismo rieducativo della pena, non consentendo all’imputato di accedere a un programma personalizzato di riparazione e reinserimento sociale.
Inoltre, era evidenziata una disparità di trattamento rispetto al reato di istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, sanzionato con pene più elevate ma comunque compatibile, in astratto, con la sospensione del procedimento e la messa alla prova.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità, richiamando l’articolo 3 della Costituzione. È stato ritenuto irragionevole che il reato di lieve entità, meno grave rispetto all’istigazione, fosse escluso dall’istituto che coniuga finalità deflattive e rieducative.
Secondo la Consulta, la preclusione automatica dell’accesso alla messa alla prova determinava un’inversione della scala di gravità dei reati in materia di stupefacenti e ostacolava la possibilità per l’imputato di intraprendere percorsi risocializzanti.