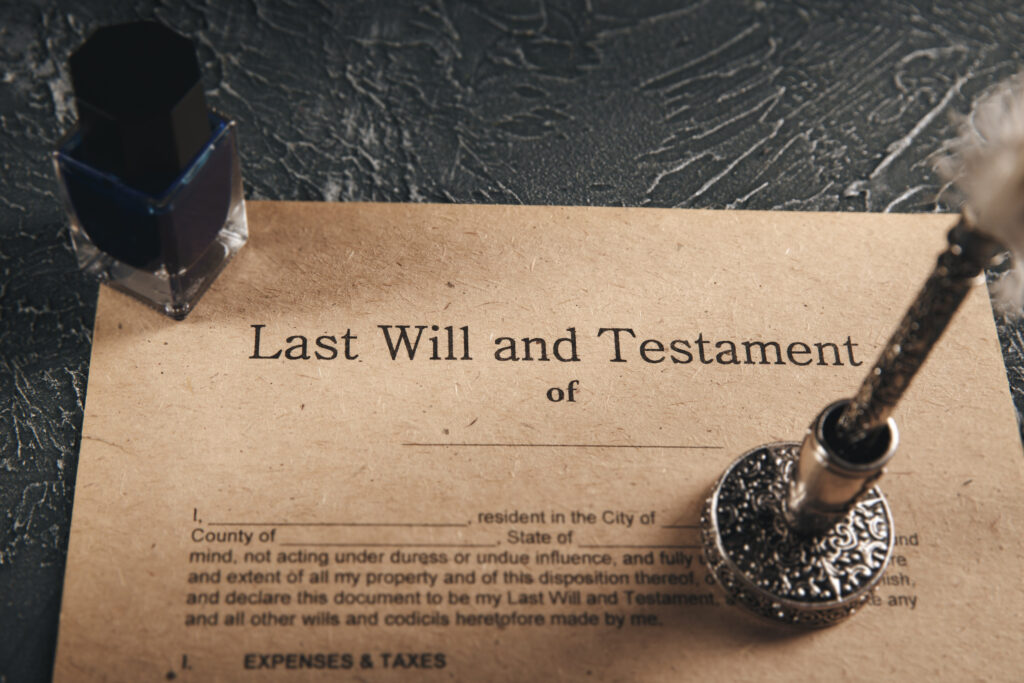Interessi moratori Interessi di mora: cosa sono, l'articolo 1224 c.c., differenze con quelli compensativi e corrispettivi, calcolo e transazioni commerciali
Cosa sono gli interessi moratori
Gli interessi moratori o di mora rappresentano una forma di risarcimento che il debitore deve al creditore quando ritarda nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, ovvero nel pagamento di una somma di denaro. La loro funzione principale è quindi di compensare il creditore per il danno subito a causa del mancato tempestivo incasso, danno che si presume esistere automaticamente con il ritardo.
Normativa di riferimento: l’articolo 1224 c.c.
Il principale riferimento normativo per questi interessi è l’articolo 1224 c.c. Questo articolo stabilisce che, dal giorno in cui il debitore è in ritardo, ossia in mora, con il pagamento di una somma di denaro, sono dovuti gli interessi legali, anche se non erano previsti interessi prima del ritardo. Se, invece, prima della mora erano già dovuti interessi a un tasso superiore a quello legale, gli interessi moratori saranno calcolati su questa misura più alta.
Essi svolgono una funzione risarcitoria automatica. Il creditore infatti non deve dimostrare di aver subito un danno riconducibile al ritardo. E’ sufficiente la condizione di mora a far scattare il diritto agli interessi.
Onere probatorio
Come accennato, questi interessi si applicano dal giorno del ritardo senza che il creditore debba provare di aver subito un danno. Tuttavia, se il creditore ritiene di aver subito un danno maggiore rispetto a quello automaticamente risarcito dagli interessi moratori, ha il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento.
L’articolo 1224 c.c precisa però che questo risarcimento aggiuntivo non spetta se le parti hanno già convenuto la misura degli interessi moratori. La presunzione legale di danno da ritardo soccorre proprio quando le parti non hanno stabilito diversamente.
Interessi moratori: come si calcolano?
Il calcolo di questi interessi dipende da quanto stabilito tra le parti.
- Se non sono stati concordati, gli interessi di mora corrispondono al tasso di interesse legale, che viene aggiornato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Se invece le parti hanno concordato un tasso, questo deve essere applicato, a condizione che non superi i limiti dell’usura.
Transazioni commerciali e interessi moratori
Se il ritardo nel pagamento riguarda le transazioni commerciali (incluse quelle con professionisti o lavoratori autonomi), è previsto un regime speciale (Dlgs 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il diritto a questi interessi viene meno per il creditore solo se il debitore riesce a dimostrare che il ritardo nell’adempimento non è riconducibile a una causa a lui imputabile.
Tasso interessi di mora 2° semestre 2025
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2025 ha reso noto il tasso degli interessi di mora per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Il nuovo tasso di riferimento, valido dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, è fissato al 2,15% (in luogo del 3,15% del 1° semestre).
Interessi moratori, corrispettivi e compensativi: differenze
È importante distinguere infine gli interessi di mora da altre tipologie di interessi:
- interessi corrispettivi: sono dovuti sui crediti liquidi ed esigibili (cioè determinati nel loro ammontare e immediatamente richiedibili). Rappresentano una sorta di “prezzo” per l’utilizzo del denaro altrui e sono un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale;
- interessi compensativi: sono dovuti in caso di “debiti di valore”, ovvero quando l’obbligazione non riguarda direttamente una somma di denaro e servono a compensare il ritardo nella messa a disposizione di tale valore.
Gli interessi di mora, a differenza dei corrispettivi e dei compensativi, nascono invece dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria già determinata.
Leggi anche: Interessi di mora: tasso secondo semestre 2025