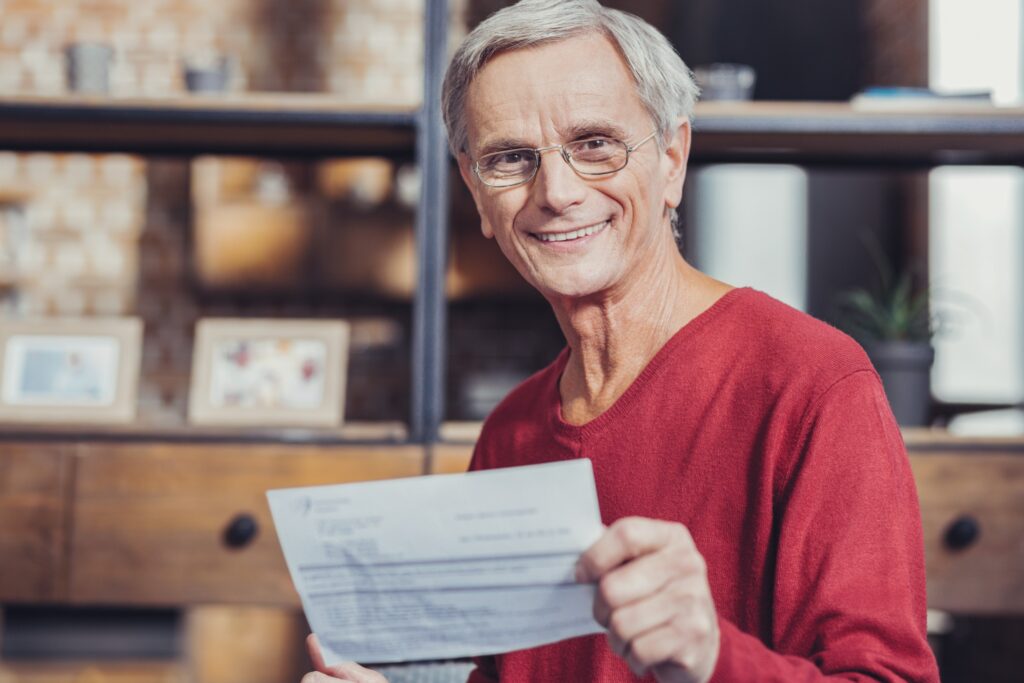Pensioni in contanti fino a mille euro L'INPS conferma il limite ai pagamenti in contanti fino a mille euro per le pensioni e le altre prestazioni assistenziali
Pensioni, limite pagamenti in contanti
Superamento limite
Per cui, laddove venga liquidata, in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, una nuova pensione e/o prestazione assistenziale, occorre verificare, spiega ancora l’istituto, che l’importo netto complessivo delle due o più prestazioni non superi il limite di mille euro mensili.
Conto corrente o carta prepagata
Ove, tale limite venga superato, l’interessato deve aprire, a stretto giro di posta, un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e delle prestazioni assimilate (es. conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN).