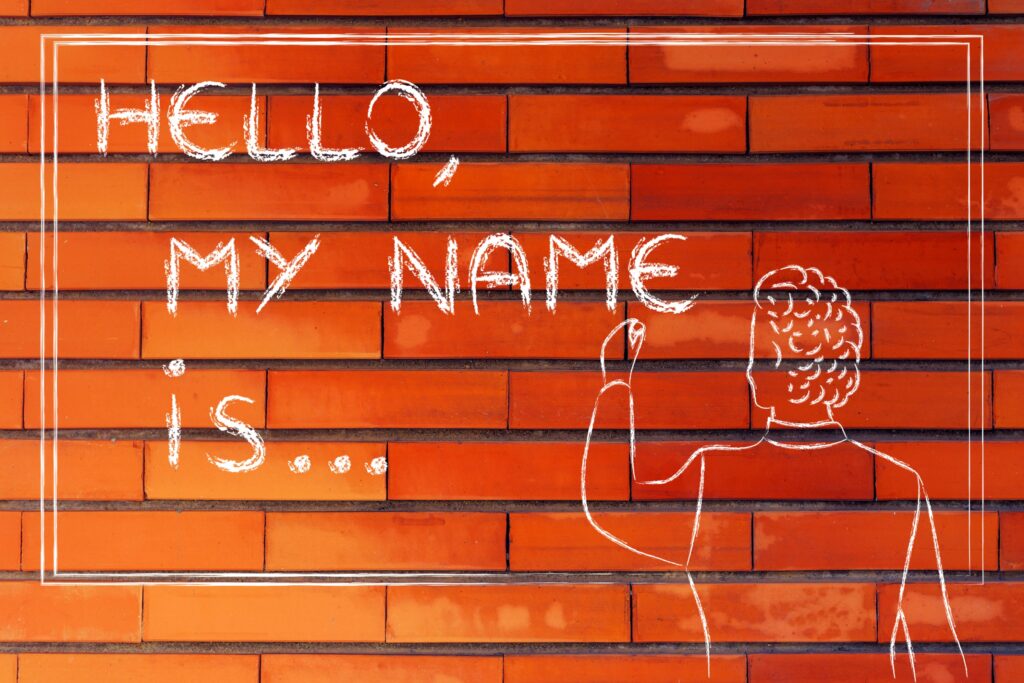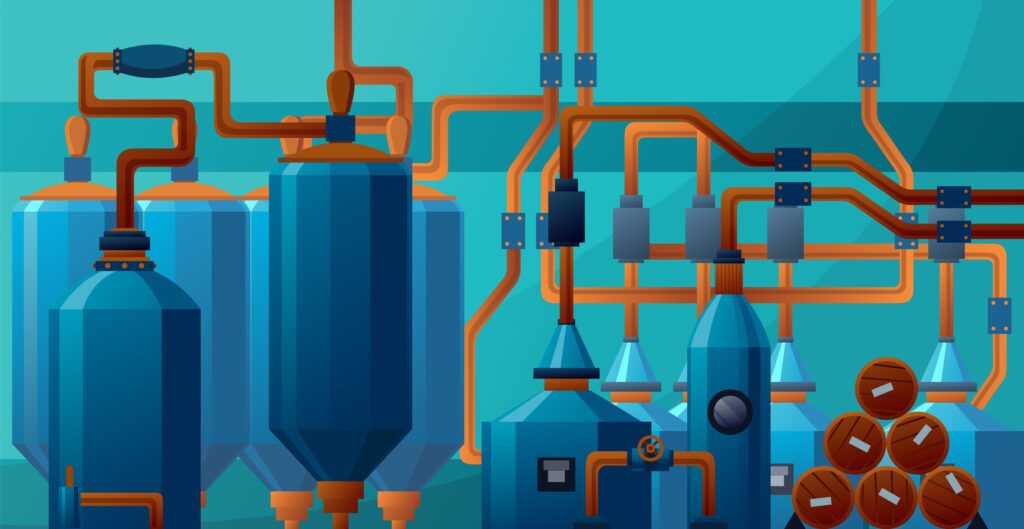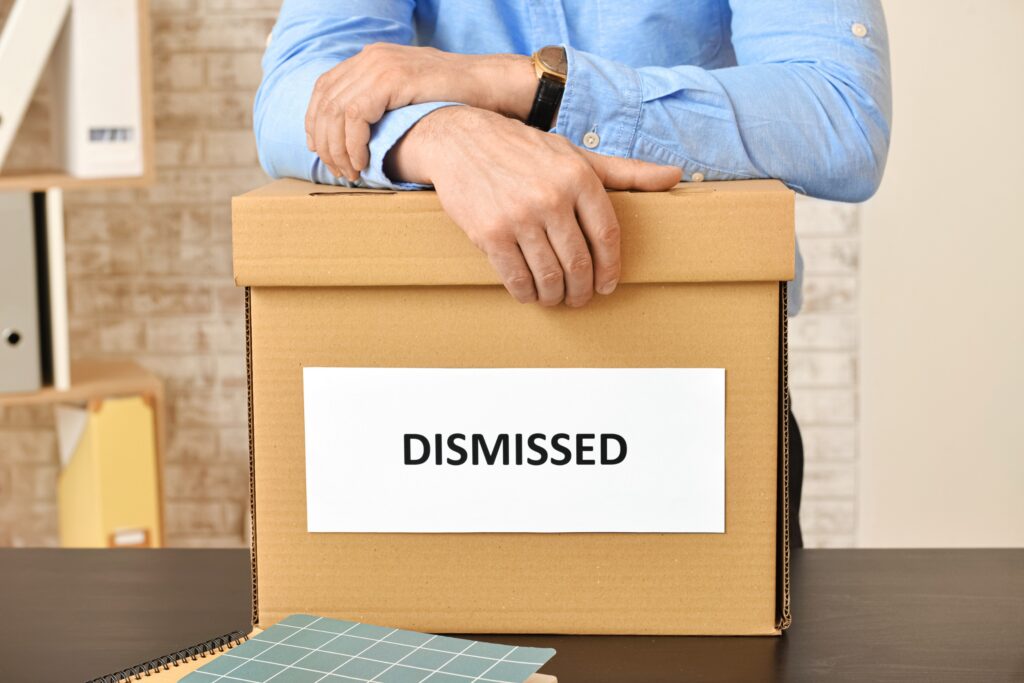Il registro di anagrafe condominiale Cos'è il registro dell’anagrafica condominiale, quali obblighi ha l'amministratore, cosa deve contenere il registro e un fac-simile di scheda da inviare ai condomini
Registro anagrafica condominiale: cos’è
Con l’entrata in vigora della Legge 220/2012, sono sorte per l’Amministratore ulteriori incombenze dovute alla tenuta e custodia di alcuni registri obbligatori per i condomini.
Il Registro dell’anagrafica condominiale è uno dei nuovi documenti che l’Amministratore deve custodire o se mancante, predisporlo (punto 6 dell’Art. 1130 del Cod. Civ.).
Per ottemperare alla costituzione del registro dell’anagrafica condominiale l’Amministratore dovrà inviare, a tutti i condomini, una scheda di richiesta/aggiornamento dati.
Deve informare gli stessi condòmini che ogni variazione dei dati deve essergli comunicata per iscritto entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, per tenere sempre aggiornato il registro di anagrafica condominiale, fermo restando che non è tenuto ad effettuare costanti attività investigative presso i pubblici registri per mantenere aggiornata l’anagrafe condominiale (Sentenza Tribunale di Roma n° 8310/2019).
Qualora un Condòminio dovesse locare la sua unità immobiliare, ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni all’Amministratore i dati del conduttore e dei soggetti aventi diritti reali sulla stessa unità.
In caso di omessa o incompleta comunicazione da parte di tutti i titolari di diritti reali l’Amministratore, per ovviare alla non ottemperanza dei condòmini, deve inviare una lettera di sollecito raccomandata che gli permetta di ottenere i dati mancanti ed aggiornare il registro.
Cosa deve contenere
Decorsi 30 giorni l’Amministratore può acquisire tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento del registro dell’anagrafe condominiale, addebitandone il costo ai responsabili.
La scheda da inviare ai condomini per istituire o aggiornare il registro dell’anagrafica condominiale dovrà contenere:
- le generalità di tutti i condomini, degli usufruttuari, con i relativi codici fiscali;
- la residenza ed il domicilio dei sopraelencati soggetti;
- tutti gli eventuali numeri telefonici, e-mail, ecc.
- se l’unità immobiliare è locata, anche i dati del conduttore;
- in caso di comunione, i riferimenti del rappresentante della comunione;
- i dati catastali di ogni singola unità immobiliare, ecc.
Obblighi dell’amministratore
L’Amministratore periodicamente deve richiedere a tutti i condomini se vi sono state o meno variazioni su ogni singola unità immobiliare, in particolare ad ogni rinnovo del mandato o in caso di lavori che prevedano eventuali sgravi fiscali, ed a chi certificare la detrazione da comunicare poi, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
Senza contare che l’art. 63 Disp. Att. ultimo comma c.c. prevede che : “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”. Meglio sarebbe stato porre a carico del notaio rogante questo ultimo adempimento. Ma tant’è.
Mancato aggiornamento del registro
Non si può ignorare che l’articolo 1130 del Cod. Civ., con il quale si istituisce il registro di anagrafica condominiale, è un articolo derogabile, pertanto, qualora un regolamento condominiale di qualsiasi natura deroghi a tale norma, bisognerà adottare quanto previsto dallo stesso.
L’aggiornamento di detto registro è molto importante tanto che esso può essere grave motivo per la revoca dell’Amministratore (Art. 1129 Cod. Civ.), oltre al fatto che sarà particolarmente utile a gestire eventuali emergenze in occasione di calamità naturali.
Fac-simile di scheda registro anagrafe condominiale
CONDOMINIO: DI VIA ………………………………………………..IN NAPOLI
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 della Riforma del Condominio – Legge 11.12.2012 n°220 (G.U. 293 del 17.12.2012) Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati con * , è obbligatorio e ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta entro 30gg. all’amministratore. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l’amministratore richiederà con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisirà le informazioni necessarie addebitandone il costo ai proprietari.
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE:
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a________________
il_________________ e residente (o sede) in____________________Via ___________________________
n°______codice fiscale:______________________________________tel.:__________________________
cell.:__________________________________ E-mail*__________________________________________
PEC*__________________________________________________________________________________
Recapito alternativo per corrispondenza:_________________________________________________________________________
In qualità di: □ proprietario □ Comproprietario (al ……..%) □ Usufruttuario □ Nudo proprietario
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione anche le convocazioni di assemblea attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati
DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI:
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a________________
il_________________ e residente (o sede) in____________________Via ___________________________
n°______codice fiscale:______________________________________tel.:__________________________
cell.:__________________________________ E-mail*__________________________________________
PEC*__________________________________________________________________________________
Recapito alternativo per corrispondenza:_________________________________________________________________________
In qualità di: □ proprietario □ Comproprietario (al ……..%) □ Usufruttuario □ Nudo proprietario
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione anche le convocazioni di assemblea attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati
UNITA’ IMMOBILIARI – DATI CATASTALI
- a) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno_______________
Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.___
Condotto in locazione? □ SI □ NO
- b) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno____________
Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.___
Condotto in locazione? □ SI □ NO
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE /COMODATO (qualora esistente):
L’unità immobiliare (a;b;c;d) ___________è stata concessa in locazione/comodato dal_________________
al sig./sig.ra/ditta_____________________________codice fiscale_________________________________
Residente a_____________________________Via________________________________________________n. _____
Telefono:_____________________________________cell:_______________________________________
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________
TUTELA DELLA PRIVACY: Vedi informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 – GDPR- qui allegata.
DATA: ____________________ FIRMA DEL DICHIARANTE:______________________________
Oltre ai dati sopra menzionati, il registro dell’anagrafica condominiale si compone di tutti quegli atti inerenti la sicurezza del condominio e quindi, anche di tutta la documentazione riguardante le manutenzioni e verifiche periodiche degli impianti.
Appare ovvio che i dati progettuali dell’edificio e tutti gli elaborati grafici devono essere parte integrante del registro di anagrafica condominiale.