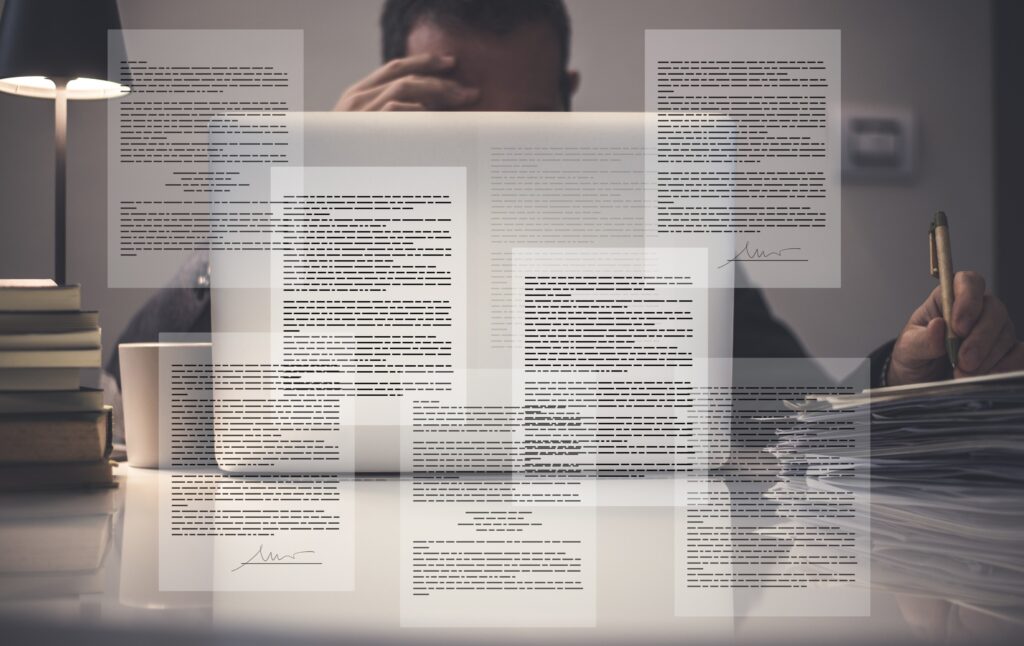It-Wallet: cos’è e a cosa serve Il decreto PNRR del 26 febbraio ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet) disponibile dal 4 dicembre 2024 sull’App IO
It-Wallet: il sistema di portafoglio digitale
Dal 4 dicembre 2024 sull’ IT- Wallet sono digitalmente accessibili documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.
A cosa serve il sistema It-Wallet
Il sistema d’identità digitale è volto a semplificare la fruizione da parte degli utenti di servizi sia “fisici” che online, al fine di rendere più semplice la gestione delle relazioni con la Pubblica amministrazione. L’It-Wallet, il primo portafoglio digitale ad avere valore di legge, raccoglierà i documenti essenziali per il cittadino e, a partire dal 2025, sarà utilizzabile su qualsiasi smartphone.
L’introduzione dell’IT Wallet è finalizzata ad una significativa semplificazione per gli utenti, che possono gestire la propria identità digitale attraverso un unico strumento, aumentando di conseguenza la sicurezza e la trasparenza nell’utilizzo della stessa, efficientando anche i rapporti tra PA e cittadino.
Gli step dell’IT-Wallet
Da settembre 2024 è iniziata la fase di test e l’IT Wallet è stato progressivamente reso disponibile agli utenti.
L’attuazione ufficiale del sistema di portafoglio digitale è prevista per gennaio 2025, data a partire dalla quale i cittadini potranno scaricare l’ultima versione dell’App Io e attivare il l’IT Wallet tramite identificazione digitale (Cie o Spid).
A partire dall’inizio del 2025, dunque, verrà dato avvio al sistema digitale per consentire il progressivo perfezionamento dell’infrastruttura digitale in vista della sua piena operatività anche europea a partire dal 2026.
Da questa data, infatti, i portafogli digitali di diversi paesi europei saranno tra loro connessi tramite un’architettura che consentirà il riconoscimento reciproco delle identità digitali, garantendo un accesso ancora più agevole e sicuro ai servizi transfrontalieri.
Infatti, entro il 2026, dovrebbe prendere avvio anche un sistema di riconoscimento digitale, sul piano europeo, valido per tutti i cittadini europei che, attraverso “Eudi wallet” potranno utilizzare servizi online, condividere documenti digitali o effettuare pagamenti.
Nell’intenzione della Commissione europea, oltre a garantire la semplificazione, lo strumento in questione mira a proteggere la sicurezza dei cittadini dal rischio di truffe, frodi e furti d’identità.
Effetti sul rapporto tra cittadino e PA
Il Wallet si prefigge di trasformare il rapporto tra cittadini e PA, rendendolo più efficiente, sicuro e accessibile rispetto all’attuale situazione.
La capacità di gestione della propria identità digitale consentirà ai cittadini di avere maggiore controllo sulla fiducia nel sistema pubblico e determinerà un aumento della partecipazione dei cittadini ai servizi digitali offerti dalla PA. Il nuovo sistema digitale si prefigge inoltre l’obiettivo di ridurre la burocrazia e di velocizzare i tempi di risposta della PA.
Quali documenti e come caricarli su IT-Wallet
Per il momento i documenti che possono essere conservati nel portafoglio digitale sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Nel 2025, saranno implementati anche servizi online e integrati altri documenti (come la carta d’identità, titoli di appartenenza agli albi, documenti anagrafici, ma anche tessere o abbonamenti vari). Per caricare i documenti, occorre innanzitutto scaricare l’app IO, quindi identificarsi con Spid o Cie. A questo punto si possono caricare i documenti digitali (i cui dati sono resi disponibili dagli stessi enti che emettono i documenti fisici) che resteranno a portata di mano in qualsiasi momento. L’app potrebbe richiedere per ultimare l’operazione una verificare dei documenti caricati, al fine di garantirne l’autenticità.