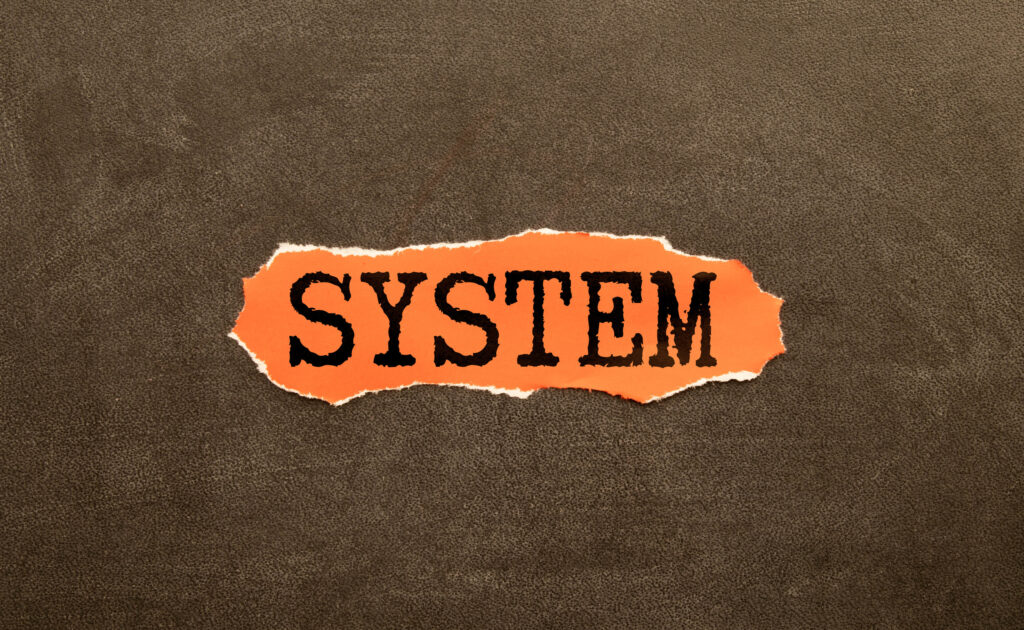Spoils System: la guida Spoils System: che cos’è, normativa di riferimento dell'istituto, cosa dice la giurisprudenza e aspetti critici
Cos’è lo Spoils System?
Lo Spoils System, letteralmente “sistema delle spoglie”, è un meccanismo amministrativo-politico che prevede la sostituzione di funzionari pubblici o dirigenti con soggetti scelti direttamente dal governo in carica. Originariamente nato negli Stati Uniti, lo Spoils System si basa sul principio secondo cui, con il cambio di governo, anche gli incarichi apicali nell’amministrazione pubblica possono essere riassegnati per allineare la gestione alle politiche del nuovo esecutivo. Questo sistema è spesso al centro di dibattiti sul bilanciamento tra autonomia della pubblica amministrazione e influenza politica.
Normativa sullo Spoils System in Italia
In Italia, lo Spoils System ha trovato applicazione con specifiche disposizioni legislative, pur rimanendo limitato rispetto al modello statunitense.
- Legge n. 145/2002: ha introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui alcuni incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione possono cessare anticipatamente in caso di cambio di governo. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di garantire maggiore coerenza tra le scelte politiche del nuovo esecutivo e la direzione amministrativa.
- lgs. n. 165/2001: disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, prevedendo che gli incarichi apicali abbiano una durata definita e possano essere revocati in determinate circostanze, tra cui il cambio di governo.
- lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta): ha ulteriormente regolamentato la dirigenza pubblica, limitando l’applicazione dello Spoils System a incarichi dirigenziali di carattere fiduciario.
Giurisprudenza delle corti superiori
La giurisprudenza italiana si è più volte pronunciata sullo Spoils System, definendo i limiti e le condizioni di applicazione di questo sistema.
- La Corte costituzionale ha stabilito che lo Spoils System non può essere applicato indiscriminatamente, ma solo in relazione a incarichi dirigenziali strettamente collegati alla funzione politica. Sentenze come la 103/2007 hanno ribadito che la revoca degli incarichi deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
- Il Consiglio di Stato nel parere n. 1979/2022 ha chiarito che la cessazione degli incarichi dirigenziali dopo 90 giorni dal voto di fiducia non impedisce al nuovo Governo di revocare l’incarico prima di tale termine, che rappresenta solo un limite massimo. Lo spoils system, applicabile a poche figure apicali per garantire coesione tra politica e amministrazione, non vincola il nuovo esecutivo alle scelte del precedente. L’efficienza dell’azione di governo non impone un’attesa obbligata fino ai 90 giorni, né l’ 19, comma 8, del d.lgs. 165/2001 conferisce un diritto alla permanenza per tale periodo.
- La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15971/2024 ha invece sancito che“Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. spoils system, la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’ 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione. Per superare il dato formale, dal quale, comunque, occorre partire, è necessario verificare non tanto i poteri attribuiti al detto dirigente in concreto, ma se egli sia stato posto a capo di una struttura che, da un punto di vista organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale, in modo da distinguersi e aggiungersi, per la sua totale autonomia, a quelli già esistenti”.
Critiche e implicazioni dello Spoils System
Lo Spoils System è oggetto di critiche per il rischio di politicizzazione della Pubblica Amministrazione e di perdita di competenze tecniche nei ruoli apicali. Tuttavia, i sostenitori sottolineano che esso consente un migliore allineamento tra amministrazione e obiettivi politici del governo in carica.
Leggi anche: Spoil system solo per i dirigenti apicali