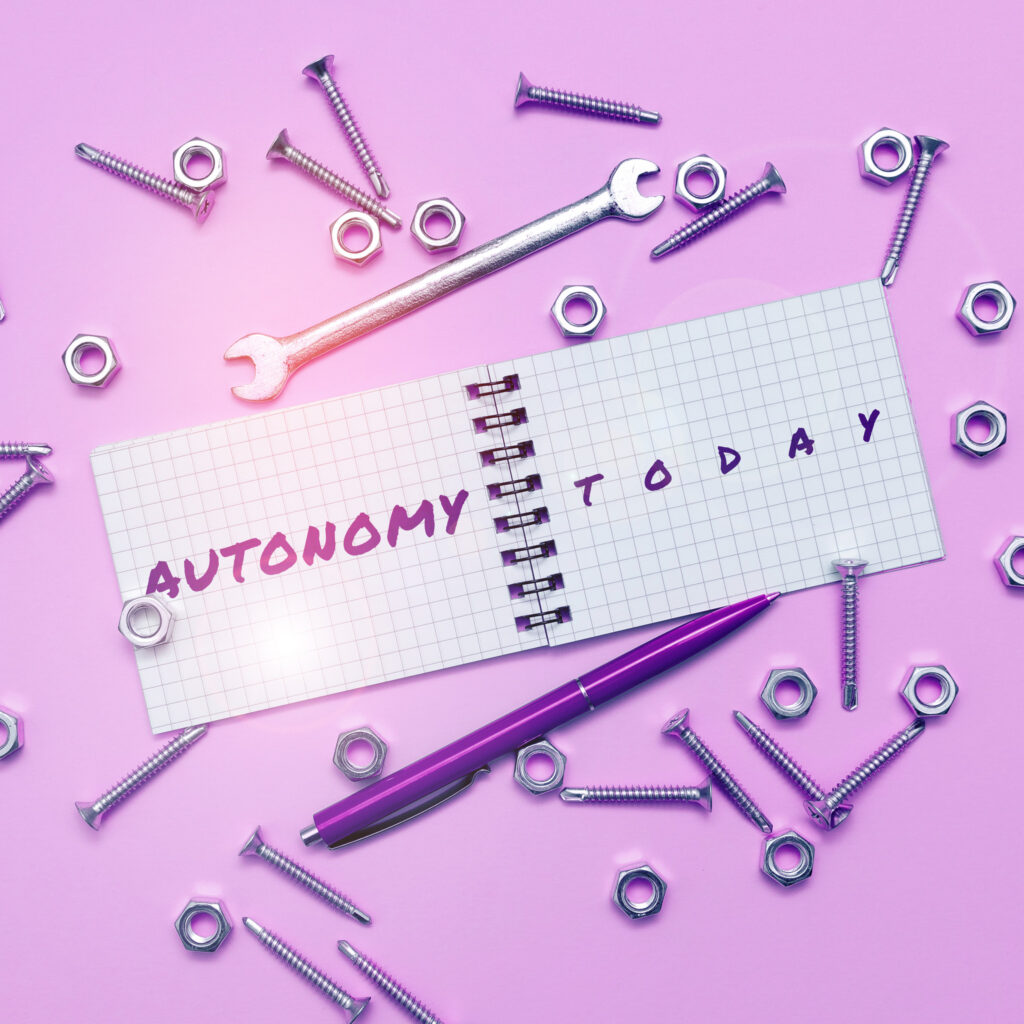Responsabilità extracontrattuale: la guida La responsabilità extracontrattuale si configura quando un soggetto con dolo o colpa cagiona ad altri un danno ingiusto
Cos’è la responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale è uno dei pilastri del diritto civile, che sancisce l’obbligo di risarcire danni causati a terzi in assenza di un contratto preesistente. Questo principio si attiva quando un soggetto provoca un danno ingiusto attraverso un comportamento illecito.
Tipologie di responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale si divide in tre principali categorie:
- Responsabilità da fatto illecito: si basa sul comportamento diretto del soggetto. Per configurare questa responsabilità, devono essere presenti dolo (intenzione consapevole di arrecare danno) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia).
- Responsabilità indiretta: in questo caso un soggetto risponde per il comportamento illecito di un’altra persona. I genitori, ad esempio, sono responsabili per i figli minorenni, i tutori per i tutelati e i datori di lavoro per i dipendenti. La legge impone questa responsabilità sulla base di rapporti di sorveglianza o dipendenza.
- Responsabilità oggettiva: questa categoria invece è più stringente, poiché non richiede dolo o colpa. Conta solo la verificazione del danno. Tuttavia, è possibile liberarsi da questa responsabilità dimostrando di aver fatto il possibile per prevenire il danno o invocando cause di esonero, come il caso fortuito o la forza maggiore. Esempi di responsabilità oggettiva includono danni derivanti da attività pericolose, animali o beni in custodia.
Responsabilità extracontrattuale: elementi costitutivi
L’articolo 2043 del Codice Civile stabilisce che un comportamento doloso o colposo che provoca un danno ingiusto obbliga il responsabile al risarcimento. Per configurare questa responsabilità, devono concorrere alcuni elementi.
- Un fatto imputabile: può trattarsi di un’azione o un’omissione attribuibile a un soggetto specifico.
- Dolo o colpa: il comportamento deve essere intenzionalmente lesivo (dolo) o negligente (colpa).
- Danno ingiusto: il danno deve violare diritti protetti dalla legge.
- Nesso di causalità: deve esserci un collegamento diretto tra il comportamento illecito e il danno subito.
Il danno ingiusto
Il danno è considerato ingiusto quando lede diritti riconosciuti dall’ordinamento. Non tutti i danni subiti però sono risarcibili. L’esercizio di un diritto, ad esempio, non è fonte di responsabilità. Se un nuovo imprenditore apre un’attività economica vicino a una dello stesso tipo e già esistente, causando una riduzione della clientela, il danno economico subito dal primo esercizio non è risarcibile. L’apertura di un’attività commerciale infatti è un legittimo esercizio del diritto d’impresa.
Dolo e colpa nella responsabilità extracontrattuale
Il dolo implica la volontà consapevole di arrecare un danno. La colpa si configura invece quando il danno deriva da imprudenza, negligenza o imperizia.
Il nesso di causalità
Il nesso di causalità è il collegamento tra il comportamento illecito e il danno subito. Esso deve essere diretto e immediato. In alcuni casi complessi, la valutazione del nesso di causalità richiede una ricostruzione accurata degli eventi per stabilire se il danno è una conseguenza inevitabile del comportamento imputato.
Differenza con la responsabilità contrattuale
A differenza della responsabilità contrattuale, basata su un accordo tra le parti, la responsabilità extracontrattuale nasce direttamente dalla legge. Gli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile italiano stabiliscono che chiunque provochi ingiustamente un danno ad altri, mediante dolo o colpa, è tenuto a risarcirlo. Questo tipo di responsabilità si configura anche quando un comportamento rappresenta sia una violazione contrattuale che un fatto illecito, come nel caso del medico che agisce con negligenza nei confronti di un paziente.
Leggi anche: Responsabilità contrattuale: la guida