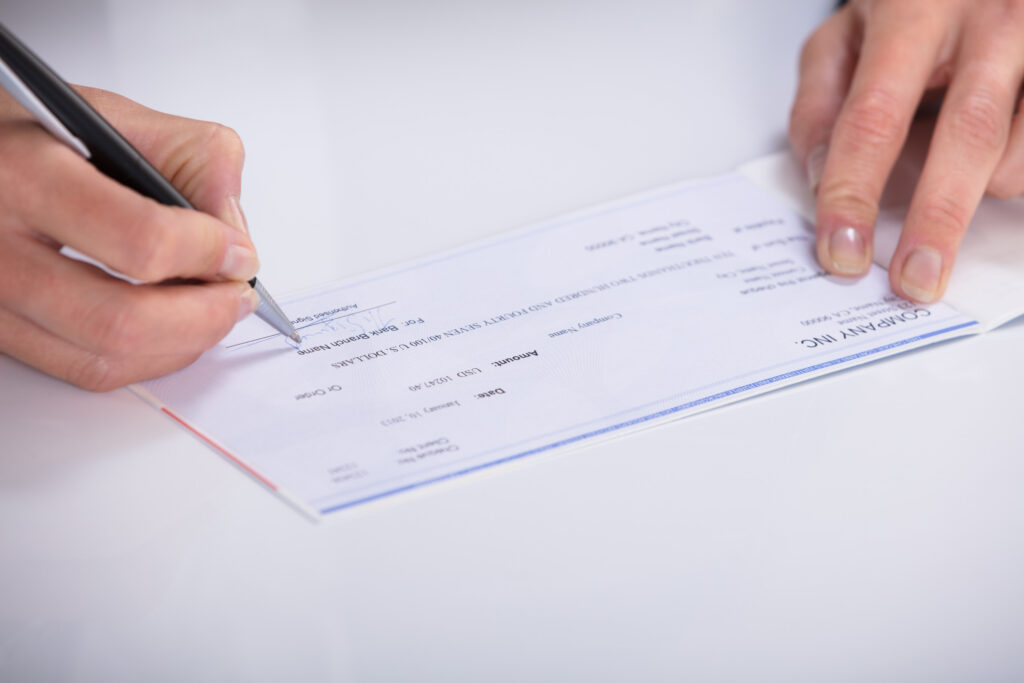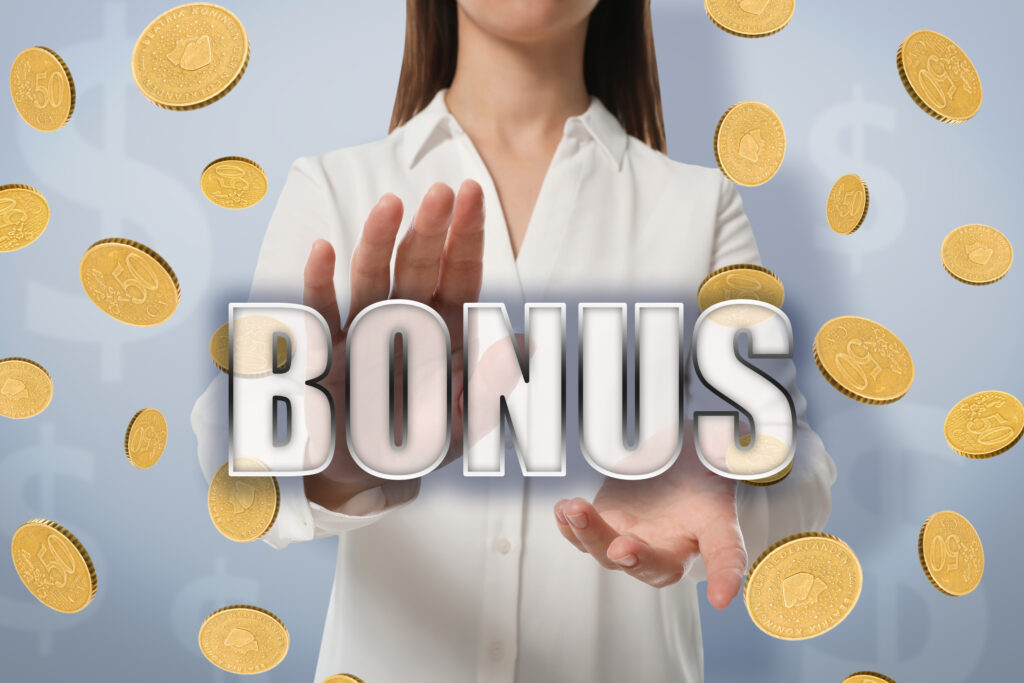Assegno circolare: la guida Assegno circolare: cos'è, normativa, funzionamento e differenze con l'assegno bancario e giurisprudenza rilevante
Cos’è l’assegno circolare
L’assegno circolare è uno strumento di pagamento sicuro e garantito, emesso direttamente da un istituto di credito a favore di un beneficiario. Si tratta di una forma di pagamento particolarmente utilizzata in transazioni rilevanti, come l’acquisto di immobili o veicoli, proprio per l’elevata affidabilità rispetto ad altri strumenti come l’assegno bancario.
L’assegno circolare è un titolo di credito a vista, che comporta l’impegno della banca emittente a pagare una somma determinata al beneficiario indicato. Diversamente dall’assegno bancario, che viene emesso da un correntista e potrebbe essere scoperto, questo assegno offre una garanzia di pagamento, in quanto la banca verifica la disponibilità dei fondi prima di emetterlo.
Caratteristiche principali
Da quanto detto emerge che le principali caratteristiche dell’assegno circolare sono le seguenti:
- sicurezza: perché la banca garantisce il pagamento;
- non trasferibilità: salvo esplicita indicazione, l’assegno circolare non può essere girato a terzi;
- validità: l’articolo 84 del Regio decreto n. 1736/1933 che contiene anche le disposizioni sull’assegno circolare stabilisce che se il possessore non presenta l’assegno per il pagamento entro 30 giorni dalla sue emissione decade dall’azione di regresso. Il termine invece per agire contro l’emittente si prescrive nel termine di 3 anni dalla sua emissione. Decorsi tre anni e fino a 10 il rimborso può essere chiesto esclusivamente al soggetto che ne aveva chiesto l’emissione.
Normativa di riferimento
La disciplina degli assegni circolari è contenuta nel Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (“Legge Assegni”), che regolamenta sia gli assegni bancari che quelli circolari. In particolare:
- 1 e ss. R.D. 1736/1933: definiscono le caratteristiche generali degli assegni.
- 84 R.D. 1736/1933: disciplina i termini dell’azione di regresso e dell’azione contro l’emittente.
- Lgs. n. 231/2007: stabilisce i limiti sull’uso del contante e degli strumenti assimilati, inclusi gli assegni circolari, per la prevenzione del riciclaggio.
Come funziona l’assegno circolare
Il richiedente si reca presso la banca e deposita l’importo da trasferire, ameno che non abbia un contro corrente su cui addebitare l’importo. La banca emette l’assegno intestato al beneficiario indicato, garantendo la copertura.
Il beneficiario a questo punto può:
- presentare l’assegno allo sportello della banca emittente per l’incasso immediato;
- depositare l’assegno sul proprio conto corrente, con tempi di accredito variabili.
Rischi legati all’assegno circolare
Nonostante l’assegno circolare sia considerato uno degli strumenti di pagamento più sicuri, esistono alcuni rischi:
- Assegni falsi o contraffatti: esistono tecniche sofisticate per creare assegni apparentemente autentici. È sempre consigliabile verificarne la validità presso la banca emittente.
- Smarrimento o furto: l’assegno può essere incassato solo dal beneficiario, ma in caso di furto o smarrimento è necessario agire prontamente con una denuncia e richiedere il blocco.
- Frode del doppio incasso: anche se raro, il beneficiario potrebbe tentare di incassare l’assegno presso più istituti. Le banche, però, applicano sistemi di controllo per prevenire queste frodi.
Differenza tra assegno circolare e assegno bancario
| Caratteristica | Assegno Circolare | Assegno Bancario |
| Emittente | Banca | Correntista della banca |
| Garanzia di pagamento | Totale, fondi verificati prima dell’emissione | Nessuna garanzia, possibile scoperto |
| Utilizzo principale | Grandi transazioni (immobili, veicoli) | Pagamenti quotidiani e operazioni ordinarie |
| Tempi di incasso | Immediato o rapido | Variabili, possibile rischio di mancato pagamento |
| Rischi | Contraffazione o smarrimento | Assegno scoperto, firma irregolare, fondi insufficienti |
Giurisprudenza sull’assegno circolare
La giurisprudenza ha chiarito vari aspetti legati all’assegno circolare:
Cassazione SU n. 40256/2018: a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della riformulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità non costituisce più reato, configurandosi come illecito civile.
Cassazione n. 23390/2024: se un assegno circolare non presenta segni evidenti di contraffazione e il documento di identità del presentatore è privo di elementi sospetti che ne mettano in dubbio l’autenticità, il cassiere adempie al proprio dovere di diligenza, in assenza di altre anomalie rilevanti, verificando semplicemente che le generalità anagrafiche riportate nel documento di identità corrispondano esattamente a quelle indicate nell’assegno.
Cassazione n. 21053/2024: il pagamento con assegno circolare estingue l’obbligazione pecuniaria senza necessità di accordo preventivo o quietanza liberatoria, poiché è un mezzo alternativo al contante e garantito dalla provvista.