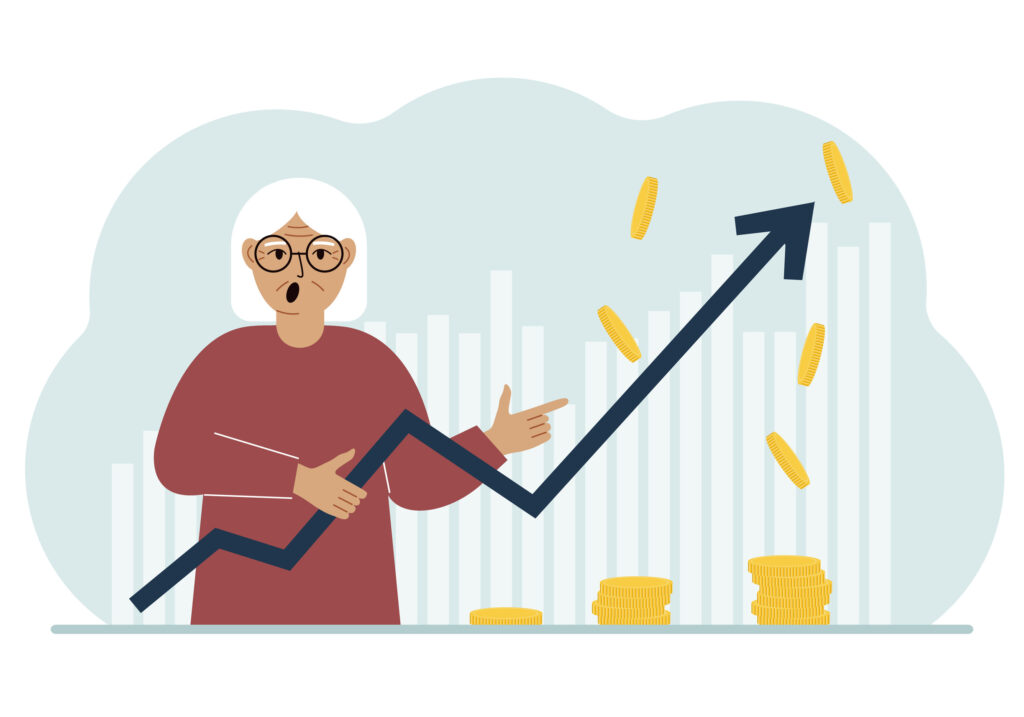Passo carrabile Passo carrabile: guida completa sulla normativa, la richiesta, le voci di costo da sostenere e le sanzioni per chi trasgredisce
Cos’è il passo carrabile
Il passo carrabile, detto anche passo carraio, è un elemento fondamentale della viabilità urbana e privata. La sua regolamentazione è contenuta negli articoli 3 e 22 del Codice della Strada (Decreto legislativo n. 285/1992).
Articoli 3 e 22 del Codice della Strada
Il passo carrabile è l’accesso a un’area privata destinata alla sosta o al transito di veicoli dalla pubblica via. Si tratta di un’area che interrompe il marciapiede o la carreggiata e che richiede un’autorizzazione specifica per impedire la sosta dei veicoli davanti all’accesso.
L’articolo 3 del Codice della Strada lo definisce come “un accesso ad area laterale idonea al transito di veicoli” e l’articolo 22 stabilisce che la sua installazione è soggetta a specifica autorizzazione del Comune.
Come si richiede il passo carrabile e quanto costa
Per ottenerlo è necessario presentare una domanda al Comune di competenza, allegando:
- modulo di richiesta fornito dal Comune;
- planimetria dell’area privata con la posizione dell’accesso;
- documentazione fotografica dello stato attuale;
- dichiarazione di proprietà o consenso del proprietario.
L’autorizzazione è soggetta a valutazione tecnica da parte degli uffici comunali, che verificano la conformità urbanistica e la viabilistica dell’accesso.
Costi per l’autorizzazione
I costi variano in base al Comune e alla tipologia del passo carrabile. Le principali voci di spesa sono rappresentate:
- dai diritti di segreteria, bolli, spese di istruttoria e sopralluogo;
- dagli oneri per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP o COSAP): il costo annuo dipende dalla metratura e dal regolamento comunale, anche se è bene sapere che alcuni Comuni hanno abolito questa tassa;
- dal costo del cartello segnaletico;
- dal costo eventualmente richiesto per la tassa di rinnovo annuale.
Come deve essere il segnale di passo carrabile?
Il cartello è obbligatorio e deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- deve essere di forma rettangolare;
- deve avere lo sfondo bianco con il bordo nero;
- deve contenere la scritta “Passo carrabile” in nero, il numero dell’autorizzazione comunale, il Comune di rilascio e il simbolo del divieto di sosta (circolare con sfondo blu e barra rossa).
Il cartello deve essere ben visibile e posizionato frontalmente all’accesso. La mancanza del segnale rende inefficace il divieto di sosta.
Quali sono le multe per i trasgressori?
Il Codice della Strada all’art. 158, comma 5 prevede per chi parcheggia allo sbocco del passo carrabile;
- multe da 41 a 168 euro (art. 158 CdS) per i ciclomotori e da 87 a 344 per i restanti veicoli;
Se il proprietario di un passo carrabile trova un veicolo in sosta irregolare, può chiamare la Polizia Municipale, che procederà all’irrogazione della sanzione e alla rimozione del mezzo.
Leggi anche: Riforma Codice della strada