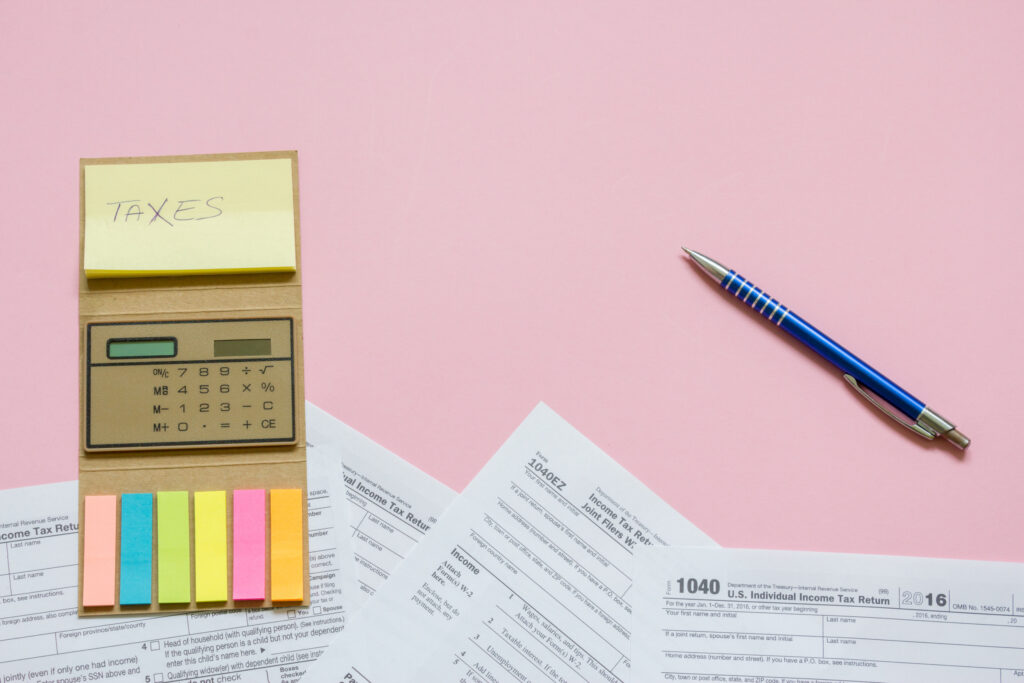Bonus mobili: cos’è e come si ottiene Come funziona il bonus mobili 2025: caratteristiche dei beni, limiti di spesa e requisiti temporali per beneficiare dell’agevolazione
Bonus mobili: cos’è
Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013. La misura è stata prorogata negli anni successivi, subendo alcune modifiche, fino al 2025.
Bonus mobili: come funziona
Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici all’interno di immobili oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione, fruibile in 10 quote annuali di pari importo, viene applicata su una spesa massima di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio.
Negli anni precedenti il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato di 5.000 euro per il 2024 e di 8.000 euro per il 2023.
Opere collegate al bonus mobili
La detrazione è collegata alle seguenti opere:
- interventi in economia di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni degli edifici residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità abitative,
- necessarie alla ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro, risanamento, conservazione e ristrutturazione di fabbricati interi eseguiti da imprese o cooperative edilizie nel rispetto di determinate condizioni.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare dell’agevolazione l’intervento di ristrutturazione non deve essere finalizzato all’acquisto di mobili o elettrodomestici e che lo stesso può avere ad oggetto anche le unità pertinenziali degli immobili.
Beni mobili agevolabili
Beneficiano dell’agevolazione gli acquisti di mobili (letti, cassettiere, armadi, tavoli, divani, materassi, scrivanie, sedie, librerie) o di grandi elettrodomestici, solo se appartenenti a determinate classi energetiche che non devono essere inferiori alle seguenti:
- classe non inferiore alla A per i forni;
- classe non inferiore alla E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie;
- classe F per frigoriferi e congelatori.
Requisiti temporali
Per il 2025, l’agevolazione spetta in relazione agli acquisti che vengono effettuati entro il 31 dicembre 2025 e collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si è provveduto all’acquisto degli arredi o dei grandi elettrodomestici, ossia a partire dal 1° gennaio 2024.
Modalità di pagamento
Per poter beneficiare del bonus mobili i contribuenti devono effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, carte di credito, carte di debito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Vanno pagate nello stesso modo anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni. L’agevolazione spetta pure se i beni vengono acquistati a rate purché il pagamento venga effettuato con mezzi di pagamento tracciabili e il contribuente conservi debitamente la ricevuta di pagamento.
Trasmissione dati all’Enea
Dal 1° gennaio del 2018 i dati relativi agli acquisti di elettrodomestici di classe non inferiore alla F e alla classe A per forni e apparecchiature per le quali è richiesta l’etichetta della classe energetica, devono essere trasmessi in via telematica all’Enea nel termine di 90 gg. dal completamento dei lavori.
L’omessa o tardiva trasmissione dei dati non causa tuttavia la perdita del diritto al bonus mobili.
Documenti da conservare
Ai fini dell’agevolazione è necessario conservare: le ricevute di pagamento effettuate con bonifico, carta di credito o debito, i documenti da cui risulta l’addebito sul conto corrente, le fatture di acquisto di arredi ed elettrodomestici nelle quali deve essere indicata nel dettaglio la quantità, la natura, la qualità dei beni e dei servizi acquistati.
Leggi anche la guida al bonus mobili dell’Agenzia delle Entrate