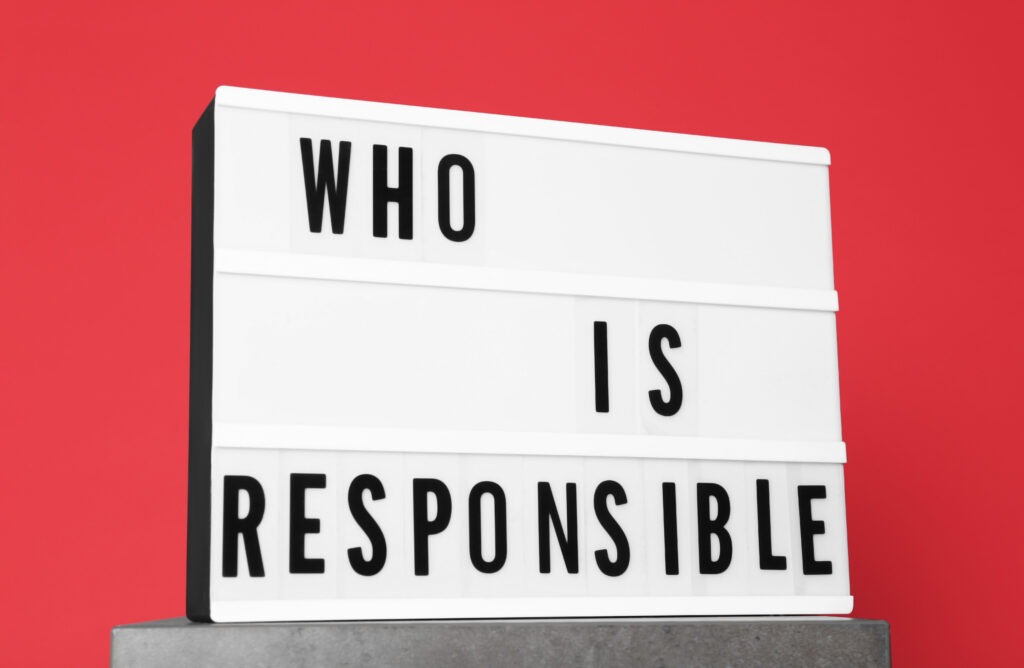Assegno di invalidità: va integrato anche con sistema contributivo La Corte costituzionale ha stabilito che l’assegno di invalidità deve essere integrato al minimo anche se calcolato interamente con il metodo contributivo
Integrazione assegno di invalidità
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha dichiarato illegittima la norma che esclude l’integrazione al minimo per l’assegno di invalidità liquidato con il solo sistema contributivo. La questione di legittimità era stata sollevata dalla sezione lavoro della Cassazione, che aveva denunciato la violazione degli artt. 3 e 38, II comma, Cost.
La disciplina dell’integrazione al minimo e la Riforma Dini
L’art. 1, comma 16, della l. n. 335/1995 (Riforma Dini) ha escluso l’applicazione delle norme sull’integrazione al minimo per tutti i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema contributivo. Tuttavia, la Corte ha ricordato che l’assegno ordinario di invalidità ha sempre avuto una disciplina peculiare e più favorevole rispetto alle altre prestazioni previdenziali.
Sin dalla sua introduzione nel 1984, l’assegno è stato concepito per fronteggiare situazioni di bisogno conseguenti alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Lo stesso prevede un’integrazione finanziata con la fiscalità generale, non con i contributi dei lavoratori.
Le ragioni della particolare tutela dell’assegno di invalidità
La Corte ha evidenziato che l’assegno ordinario di invalidità risponde a esigenze specifiche:
-
può essere necessario molto prima dell’età per accedere all’assegno sociale;
-
tutela soggetti che, per l’invalidità, hanno perso la capacità di generare un montante contributivo adeguato;
-
si rivolge a situazioni di bisogno meritevoli di particolare protezione costituzionale.
In assenza dell’integrazione al minimo, il lavoratore invalido con un assegno di importo ridotto rischia di rimanere per anni privo di un sostegno economico adeguato. Ciò specialmente se non possiede altri requisiti per accedere a prestazioni assistenziali.
La violazione del principio di uguaglianza
Secondo la Consulta, assimilare l’assegno ordinario di invalidità alle pensioni contributive ordinarie e sottrarlo all’integrazione al minimo determina un’irragionevole disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost.
Il trattamento si differenzia per finalità e modalità di finanziamento dalle altre prestazioni previdenziali e non può essere ricondotto alla logica punitiva verso chi esce anticipatamente dal lavoro senza aver maturato un’adeguata anzianità contributiva.
Decorrenza differita degli effetti della sentenza
Pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma, la Corte ha stabilito che gli effetti della decisione decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questa scelta è stata motivata dalla necessità di evitare un improvviso e ingente aggravio finanziario per lo Stato, dovuto al riconoscimento degli arretrati per il periodo anteriore.