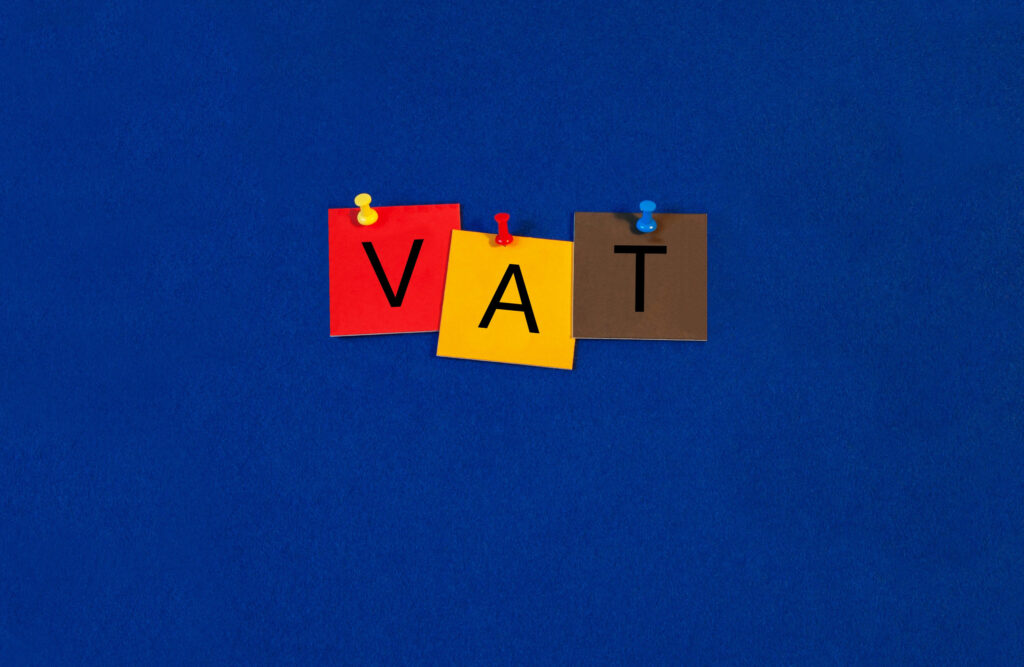Testo base sul fine vita
Sul fine vita, al Senato, è stato redatto il testo base, che riunisce diversi disegni di legge. Il testo unificato, composto da 4 articoli, contiene le disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Analizziamo uno a uno gli articoli del testo, che hanno suscitato critiche e polemiche.
Diritto alla vita: inviolabile e indisponibile
Il comma 1 del primo articolo contiene una disposizione di principio che sancisce il diritto alla vita in quanto presupposto fondamentale di tutti i diritti della persona. Segue poi la disposizione che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare la vita di ogni individuo indiscriminatamente. Non rilevano, infatti, l’età, il sesso, la condizione di salute, personale o sociale. Il comma 2 sanziona, infine, con la nullità tutti gli atti di natura civile o amministrativa che dovessero contrastare con questi principi.
Fine vita: novità per il reato di istigazione o aiuto al suicidio
L’articolo 2 interviene sul secondo comma dell’articolo 580 c.p., che al comma 1 punisce con la reclusione fino a 12 anni la condotta di chi determina altri al suicidio, ne rafforza il proposito o ne agevola l’esecuzione in qualsiasi modo, se il suicidio avviene.
Il nuovo comma 2 della norma, in base al testo base, prevede la non punibilità del soggetto agente, in presenza di circostanze specifiche:
- il proposito del fine vita deve essersi formato in modo libero, autonomo e consapevole;
- il soggetto che intende porre fine alla propria vita deve essere maggiorenne e pienamente capace di intendere e di volere;
- lo stesso deve essere stato inserito in un percorso di cure palliative e tenuto in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali;
- il soggetto deve essere affetto da una malattia irreversibile che gli causa sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili;
- le sue condizioni devono essere state accertate da un apposito Comitato.
Cure palliative: piani di potenziamento
L’articolo 3 si occupa delle cure palliative, modificando il comma 4-bis dell’articolo 5 della legge n. 38/2010. Questa la formulazione potenziale della norma (modifiche in grassetto): “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro l’anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata e di garantire l’integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all’articolo 12, comma 2. Il monitoraggio dell’attuazione del piano è affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Eventuali residui delle somme di cui all’articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge”.
AGENAS: analisi dei piani
Dopo questo comma è previsto l’inserimento di altri tre commi.
Il comma 4-ter prevede che l’AGENAS istituisca un osservatorio per analizzare i piani regionali di potenziamento delle cure palliative (domiciliari e pediatriche). Ogni anno, inoltre, l’AGENAS dovrà inviare una relazione a diverse autorità (Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Presidenti di Senato e Camera) indicando le regioni che non hanno presentato tali piani o non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati l’anno precedente.
Il comma 4-quater, invece, dispone che in caso di mancata presentazione del piano da parte di una regione entro 30 giorni dalla relazione AGENAS, il Governo nomini un commissario ad acta fino al raggiungimento dello standard. Se poi la regione non dovesse raggiungere gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative dell’anno precedente, il Ministro della Salute è tenuto a concedere un termine di massimo sei mesi; se l’inadempimento dovesse persistere, è prevista la nomina governativa di un Commissario.
Il comma 4-quinques chiarisce, infine, che alle novità contenute nei due commi precedenti si debba provvedere senza nuovi o maggiori oneri.
Comitato nazionale di valutazione fine vita
L’articolo 4 del testo base interviene sulla legge n. 833/1978, che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, aggiungendo l’art. 9-bis, che disciplina il Comitato nazionale di valutazione, un organo cruciale che fornisce un parere obbligatorio sulla presenza dei requisiti per l’esclusione della punibilità in casi specifici (riferiti all’articolo 580, terzo comma, del codice penale).
Composizione del comitato
La composizione del Comitato prevede la presenza di sette membri esperti: un giurista, un bioeticista, un medico anestesista-rianimatore specializzato in terapia del dolore, un medico specialista in cure palliative, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Questi professionisti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che designa anche presidente, vicepresidente e segretario. La durata in carica dei membri è di cinque anni, con la possibilità di due rinnovi. L’incarico è gratuito.
Fine vita: verifica requisiti di non punibilità
Qualora un cittadino maggiorenne e capace di intendere e di volere presenti una richiesta di verifica dei requisiti di non punibilità, il Comitato deve acquisire il parere non vincolante di uno specialista della patologia del richiedente. Se la richiesta include l’uso di farmaci “off label”, è necessario anche il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale. Il Comitato ha sessanta giorni di tempo dalla richiesta per esprimersi, potendo disporre possibili proroghe in caso di necessità o di acquisizione dei pareri. Le norme generali sul procedimento amministrativo non si applicano in questo contesto e per svolgere le sue funzioni, il Comitato si avvale delle strutture del Ministero della Salute, senza oneri aggiuntivi. La richiesta presentata al Comitato potrà essere ritirata in qualsiasi momento dall’interessato. Se il Comitato dovesse accertare l’assenza dei requisiti, una nuova richiesta potrebbe essere presentata solo se si dimostra la successiva sussistenza degli stessi, e comunque non prima di centottanta giorni. Il parere rilasciato dal Comitato sarà valutato dall’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione della non punibilità.
Pur riconoscendo le competenze del Comitato, il personale, le strumentazioni e i farmaci del Servizio Sanitario Nazionale non potranno essere impiegati per facilitare l’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 580 del codice penale.
Leggi anche: Suicidio assistito: la Consulta torna sul fine vita