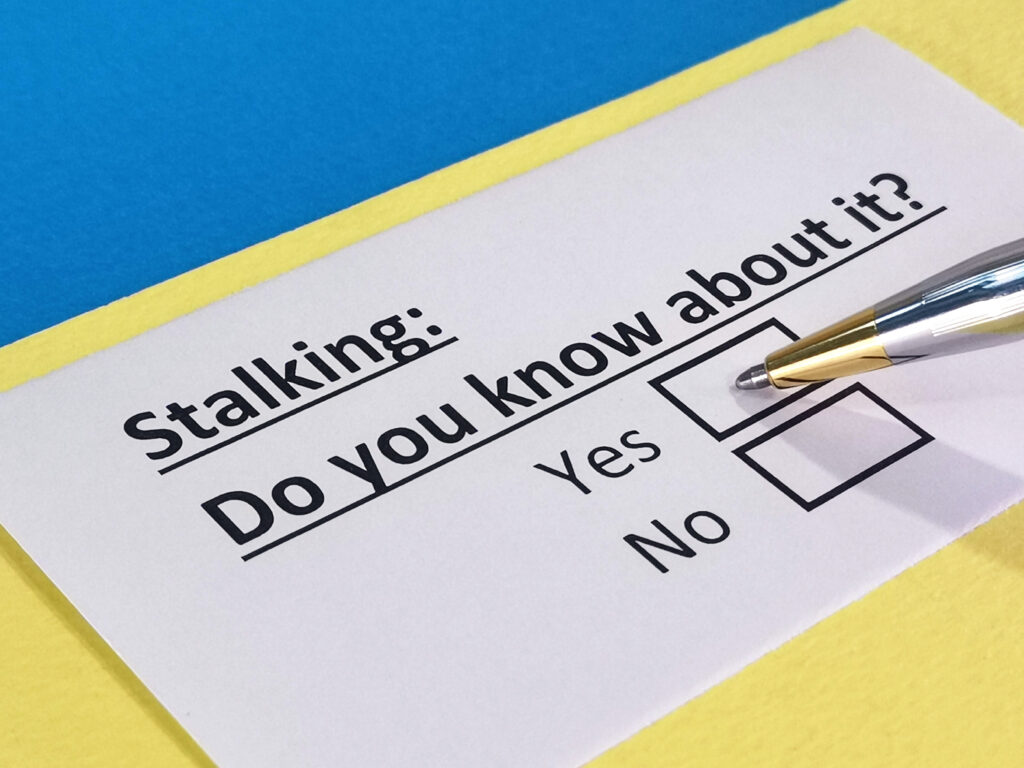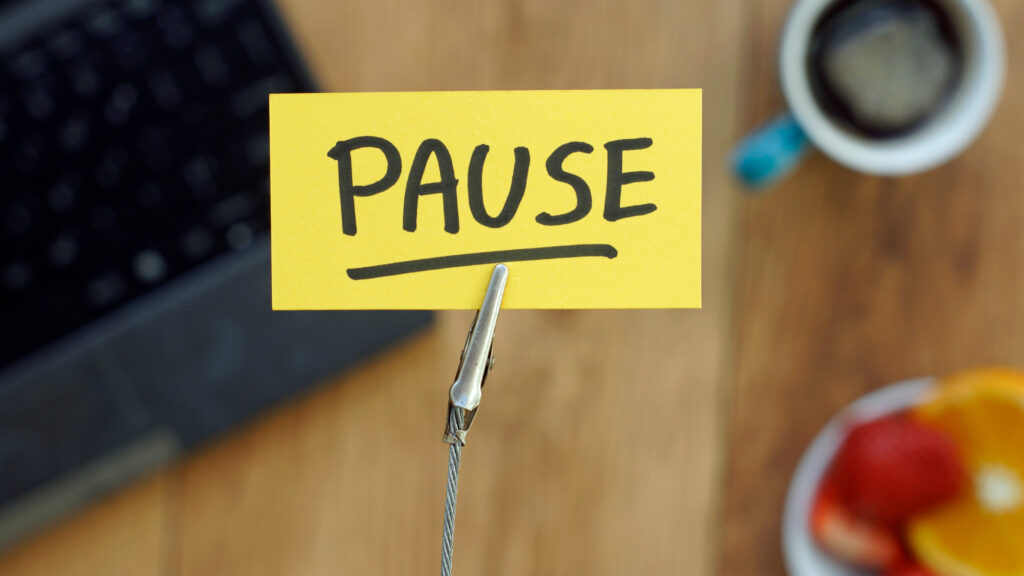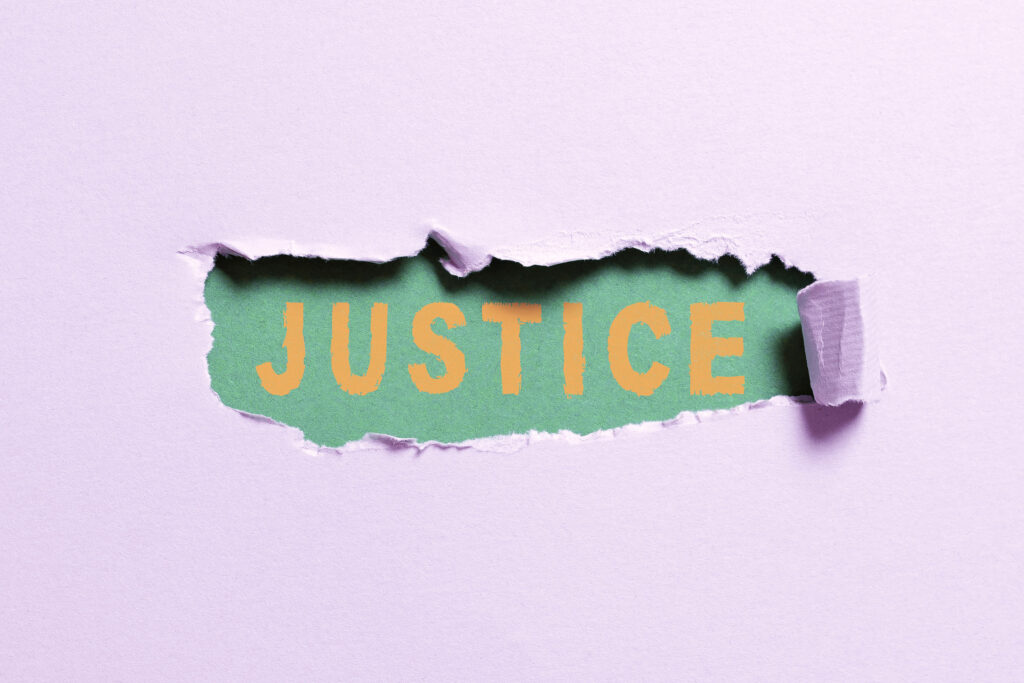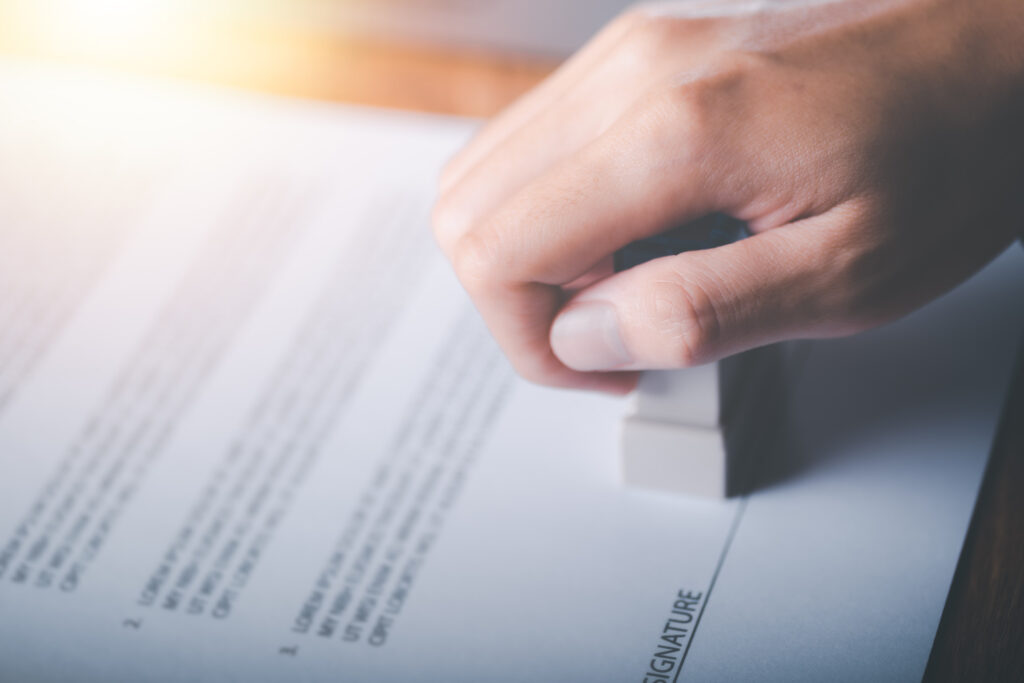Bonus continuità docenti Bonus continuità docenti: cos’è a chi è destinato, requisiti di accesso, importo e criteri di ripartizione delle risorse stanziate
Cos’è il bonus continuità docenti
Il “Bonus continuità docenti” è un incentivo economico, introdotto dal Decreto Ministeriale n. 242/2024, destinato agli insegnanti di ruolo in Italia.
Il decreto attua uno degli obiettivi del PNRR, che prevede “la valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.”
L’obiettivo della misura infatti è quello di premiare i docenti che assicurano stabilità e continuità didattica nella stessa scuola, riconoscendo il valore di un legame duraturo con l’istituto, cruciale per la crescita e il benessere degli studenti, specialmente quelli con esigenze particolari.
Bonus continuità docenti: requisiti di accesso
Per ottenere il bonus i docenti devono soddisfare requisiti specifici:
- aver prestato servizio nella stessa scuola per almeno tre anni consecutivi (dal 2021/2022 al 2023/2024) senza aver richiesto trasferimenti o assegnazioni temporanee;
- aver accumulato un minimo di 480 giorni di servizio complessivi presso lo stesso istituto nel triennio considerato. Sono inclusi anche i docenti rientrati nell’istituto di riferimento dopo un trasferimento temporaneo per mancata assegnazione di posto.
Importo e ripartizione del fondo
L’importo del bonus, da 200 a 500 euro, varia a seconda della scuola, in quanto il fondo totale stanziato per il 2023 è di 30 milioni di euro e viene ripartito in base a criteri come l’Indice ESCs (status socio-economico-culturale), il tasso di dispersione scolastica, la presenza di alunni stranieri e il turnover del personale docente.
Le scuole con maggiori difficoltà o instabilità ricevono una quota maggiore. Solo gli istituti che hanno raggiunto un punteggio minimo di 47 punti nella valutazione annuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno diritto a partecipare.
L’importo specifico per ciascun istituto è consultabile tramite un allegato ufficiale.
La distribuzione definitiva del bonus ai singoli docenti è poi definita tramite contrattazione d’istituto, che coinvolge il personale scolastico e i sindacati.
Leggi anche gli altri articoli dedicati ai docenti e al personale scolastico