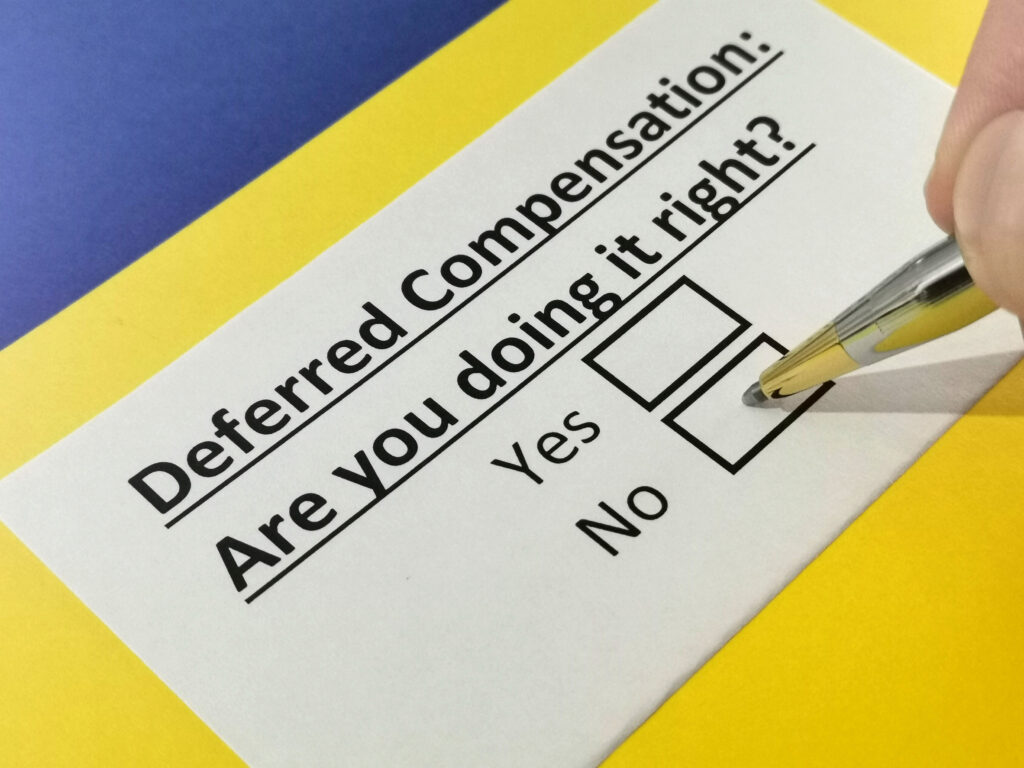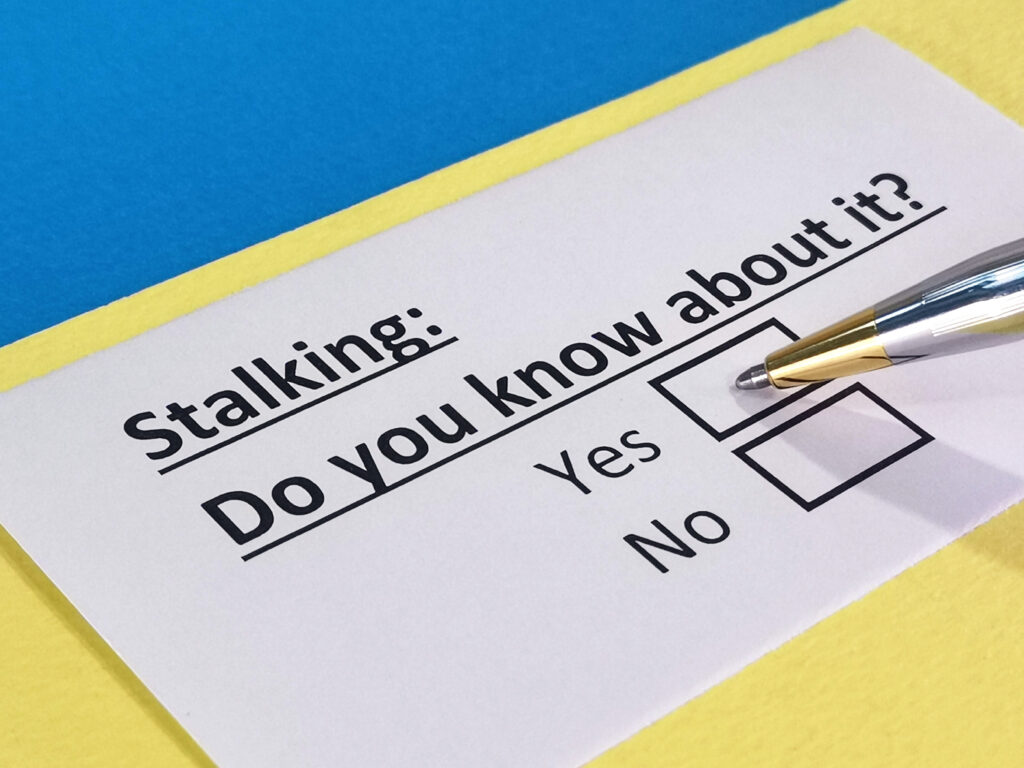Tetto retributivo nel pubblico impiego: incostituzionale il limite fisso di 240.000 euro La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del tetto retributivo fisso per i dipendenti pubblici. Il limite dovrà tornare a essere parametrato al trattamento del primo presidente della Cassazione
Tetto retributivo nel pubblico impiego
Con la sentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale ha ribadito che l’introduzione di un tetto retributivo per i dipendenti pubblici non è, in sé, incompatibile con i principi costituzionali. Tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui prevedeva un limite fisso pari a 240.000 euro lordi annui, invece che rapportarlo al trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Il parametro corretto
Il tetto retributivo era stato inizialmente introdotto dal decreto-legge n. 201/2011, come convertito, prevedendo che la soglia massima fosse pari allo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione. Con il successivo decreto-legge n. 66/2014, però, tale parametro fu sostituito con una soglia fissa, causando una rilevante decurtazione dei compensi, in particolare per i magistrati.
L’evoluzione normativa e il principio di temporaneità
La norma del 2014, sebbene inizialmente ritenuta compatibile con la Costituzione in quanto misura straordinaria e temporanea, giustificata dal contesto di grave crisi finanziaria, ha perso nel tempo il suo carattere transitorio. Tale perdita di temporaneità ha inciso sulla sua compatibilità costituzionale, anche in considerazione dell’indipendenza della magistratura, tutelata dall’art. 104 della Costituzione.
Conformità ai principi europei e comparati
La pronuncia della Corte costituzionale si inserisce in un contesto più ampio di tutela dei diritti retributivi dei magistrati e dei pubblici dipendenti, in linea con i principi degli ordinamenti costituzionali europei. In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (grande sezione, cause riunite C-146/23 e C-374/23), ha espresso un orientamento analogo, censurando la riduzione eccessiva e prolungata delle retribuzioni dei magistrati.
Estensione dell’incostituzionalità a tutti i dipendenti pubblici
La Corte ha inoltre sottolineato che l’illegittimità costituzionale della norma ha carattere generale, pertanto deve applicarsi a tutti i dipendenti pubblici, e non solo ai magistrati. Il limite retributivo, quindi, dovrà essere ridefinito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Effetti temporali della pronuncia
Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta, la dichiarazione di illegittimità non avrà effetto retroattivo, ma produrrà effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.