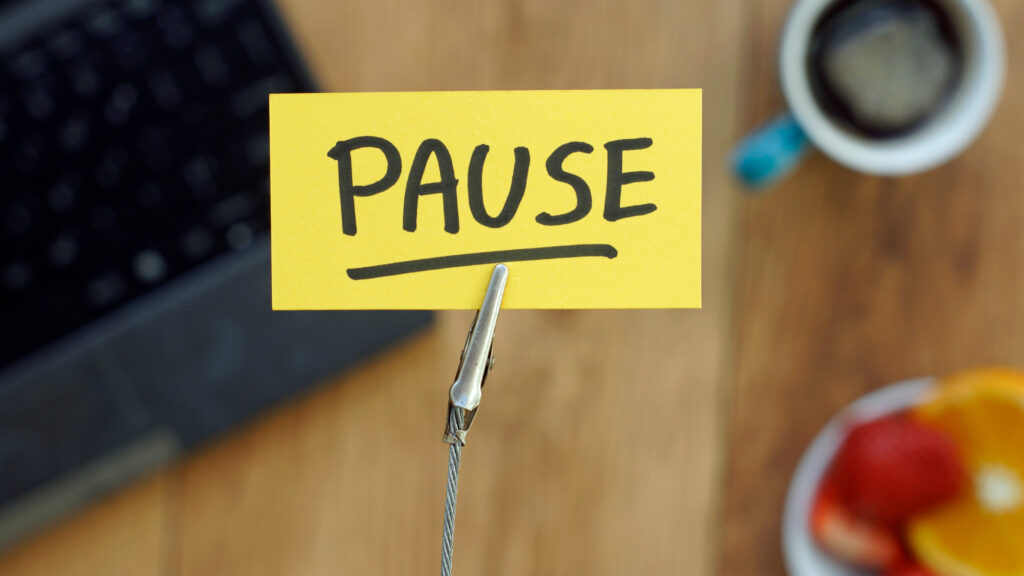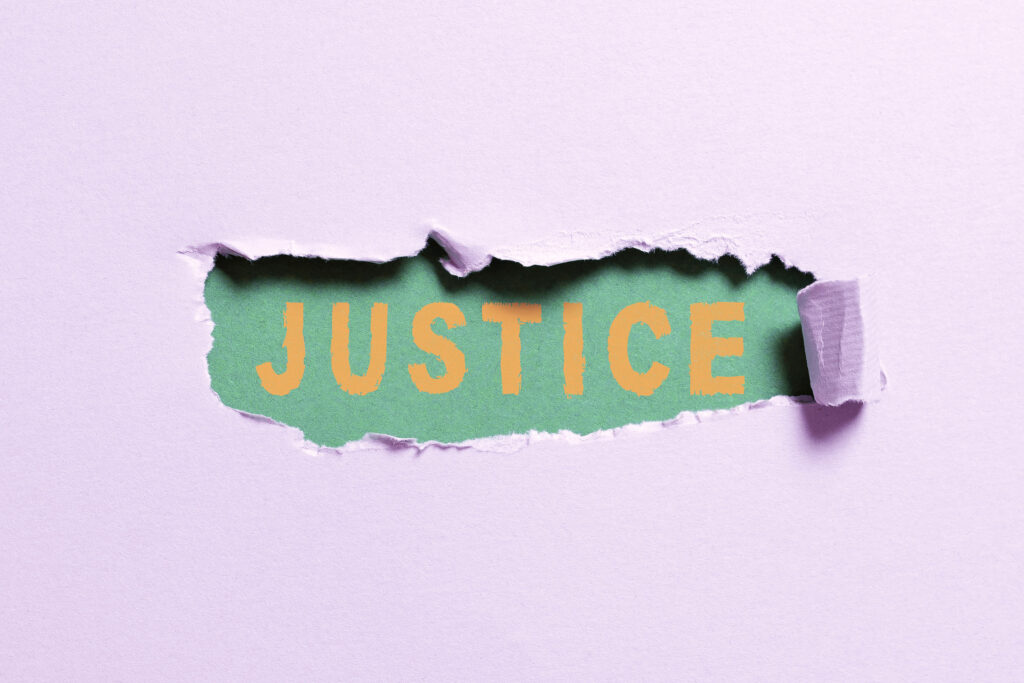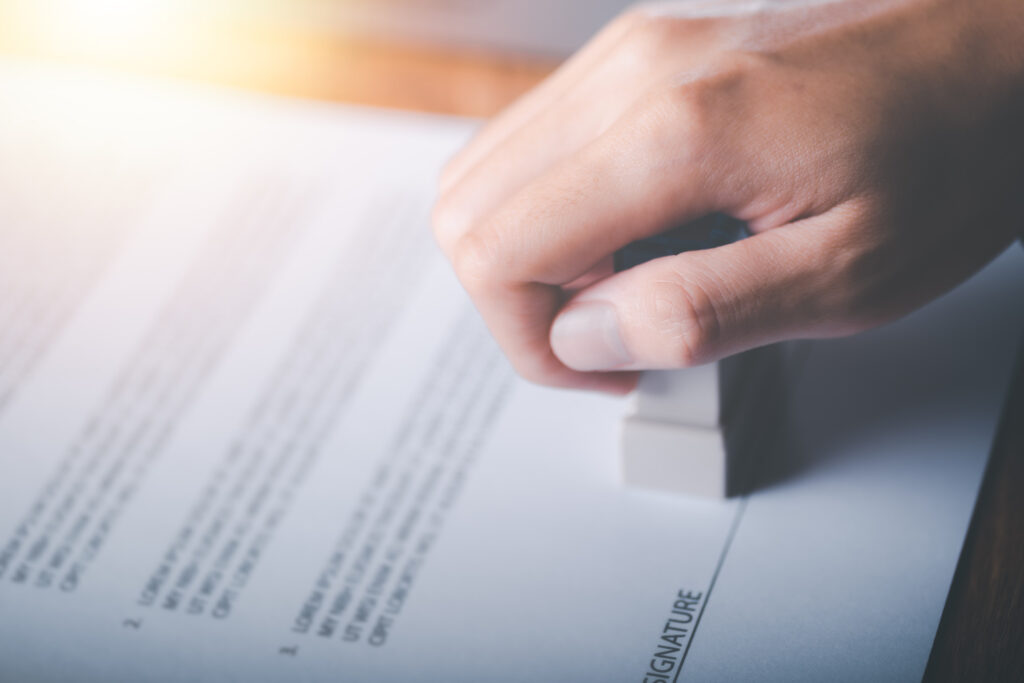Aquaplaning: responsabilità del Comune se causato da ristagno d’acqua La Cassazione riconosce la responsabilità del Comune per l’aquaplaning causato da ristagno d’acqua sulla carreggiata. Risarcito il conducente danneggiato
Responsabile il Comune per l’aquaplaning da ristagno d’acqua
Con l’ordinanza n. 21321/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è responsabile il Comune per il danno subito da un automobilista a causa del ristagno d’acqua sulla carreggiata, che ha generato un fenomeno di aquaplaning e ha determinato lo sbandamento del veicolo contro il guardrail. Secondo i giudici, la dettagliata ricostruzione fornita dal conducente costituisce elemento sufficiente a individuare il nesso causale tra l’anomalia stradale e l’evento dannoso.
I fatti
L’incidente si è verificato nel Comune di Calcinato, dove il conducente, mentre percorreva una strada urbana, ha perso il controllo della vettura a causa dell’accumulo d’acqua sul manto stradale, con conseguente impatto contro la barriera di protezione. Il fenomeno di aquaplaning è stato provocato dal contatto tra le ruote sinistre dell’auto e la zona allagata, che ha generato una perdita di aderenza e il conseguente sbandamento.
Le decisioni di merito
In primo grado, il Tribunale di Brescia (sentenza n. 390/2021) aveva riconosciuto una responsabilità concorrente tra conducente (75%) e Comune (25%). Quest’ultimo era stato condannato al pagamento di 346.250 euro a titolo di danno non patrimoniale. Il giudice aveva accertato, da un lato, la condotta imprudente del conducente (velocità eccessiva e pneumatici usurati), e dall’altro la presenza verosimile di ristagni d’acqua, come evidenziato dal CTU.
La Corte d’appello di Brescia, invece, con sentenza n. 1266/2022, aveva integralmente riformato la decisione, escludendo ogni responsabilità dell’ente. Secondo la Corte, il danneggiato non aveva allegato con precisione la causa dell’incidente, e nel verbale dei Carabinieri non era stata rilevata la presenza di acqua stagnante.
Cassazione: centrale la prova del nesso causale
La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso del danneggiato, ritenendo fondata la sua ricostruzione dettagliata del sinistro. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato non deve dimostrare la pericolosità intrinseca della strada, ma solo allegare e provare l’esistenza del nesso causale tra il bene demaniale e il danno.
La descrizione fornita dal conducente – che ha minuziosamente spiegato le dinamiche dello sbandamento e il ruolo svolto dall’acqua accumulata – è stata considerata sufficiente a configurare la responsabilità dell’amministrazione per omessa manutenzione e vigilanza sul tratto stradale.
Obbligo di custodia e dovere di manutenzione del Comune
Secondo la Cassazione, l’ente proprietario della strada è tenuto a garantire la sicurezza della viabilità pubblica, mediante un’adeguata attività di manutenzione, ispezione e segnalazione dei pericoli. Il ristagno d’acqua, se non tempestivamente rimosso, può costituire insidia stradale, idonea a determinare incidenti come quello oggetto di giudizio.
L’omissione di tali attività integra una colpa in vigilando, salvo che l’ente non dimostri che il danno sia stato causato da caso fortuito, prova che, nel caso concreto, non è stata fornita.