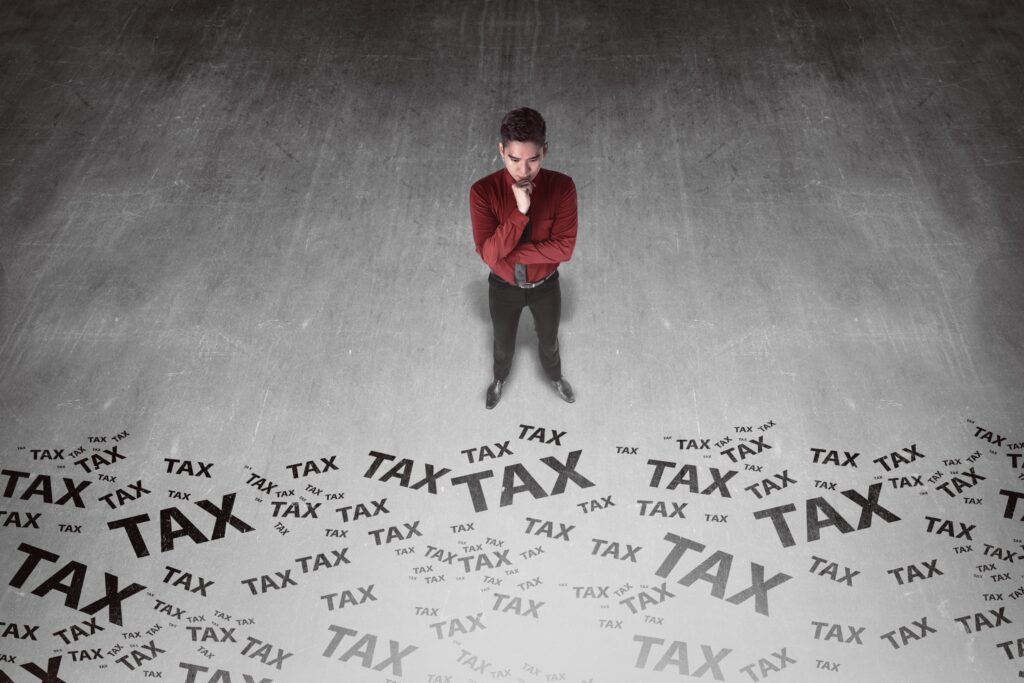Processo tributario: nuove regole in vigore dal 2 settembre 2024 Il processo tributario, riformato dal decreto legislativo n. 220/2023 è soggetto a regole in vigore dal 4 gennaio 2024 e dal 2 settembre 2024
Processo tributario: in vigore il decreto n. 220/2023
Il processo tributario, disciplinato dal decreto legislativo n. 546/1991, è soggetto a nuove regole dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 220/2023. Per il testo del provvedimento di riforma sono previste due date per l’entrata in vigore delle varie norme.
L’articolo 4 prevede infatti che “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”.
Il regime di entrata in vigore del decreto n. 220/2023 si verifica quindi in due tempi. Una parte delle norme sono infatti già in vigore dal 4 gennaio 2024, altre invece dal 2 settembre 2024.
Riforma processo tributario: le norme in vigore dal 2 settembre 2024
Tralasciando il contenuto delle norme già entrate in vigore del decreto legislativo n. 220/2023 contenente disposizioni in materia di processo tributario, vediamo cosa cambia dal 2 settembre 2024.
Procura alle liti del difensore nel processo tributario
In relazione ai giudizi di primo e di secondo grado che vengono instaurati dopo il 1° settembre 2024 il decreto prevede che:
- qualora il cliente conferisca l’incarico al legale con forma digitale, l’avvocato non ha più l’obbligo di procedere con l’autentica della sottoscrizione;
- se però la procura viene conferita in modo tradizionale, ossia su un documento cartaceo, il difensore è tenuto ad autenticare il documento depositando una copia dello stesso in formato immagine, attestandone la conformità con specifica dichiarazione.
Atti processuali: chiarezza e sinteticità
L’avvocato a la parte devono redigere gli atti del processo tributario nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità. Chi viola questi principi ne subisce le conseguenze sulle spese di giudizio. I provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie privi della sottoscrizione digitale sono nulli.
Deposito telematico per la costituzione in giudizio
Il ricorrente e il resistente devono costituirsi in giudizio tramite il deposito telematico del ricorso notificato. La regola vale sia nel caso in cui questi soggetti decidano di agire da soli sia nell’ipotesi in cui si facciano assistere da un legale.
Comunicazioni e notificazioni a mezzo pec
Il relazione ai giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024 con ricorso notificato e poi depositato telematicamente, tutte le comunicazioni e le notificazioni da parte delle segreteria devono essere effettuate in modalità telematica.
A tal fine il difensore o la parte che redige il ricorso deve indicare nell’atto il proprio indirizzo pec.
In caso di variazione dell’indirizzo pec del difensore o della parte, è necessario che i difensori ne diano comunicazione alla segreteria della Corte di giustizia tributaria. Qualora la variazione non venga comunicata la segreteria non ha l’obbligo di cercare il nuovo indirizzo o procedere con la comunicazione tramite deposito in segreteria.
Qualora una parte sia assistita da più difensori, la comunicazione si perfeziona se uno di loro la riceve. In questo caso spetta all’avvocato comunicare agli altri difensori il contenuto della comunicazione di segreteria.
Deposizioni dei testimoni: forma e notifica
Quando il processo tributario è nella fase istruttoria ed è necessario notificare le intimazioni a comparire ai testimoni, si può procedere alla notifica dell’atto e del modulo di deposizione anche in modalità telematica.
Qualora il testimone sia munito di firma digitale, il difensore che lo ha citato deposita in modalità telematica il modulo di deposizione che gli è stato inviato compilato e sottoscritto digitalmente.
Fascicolo telematico
Il fascicolo telematico non deve essere depositato nelle fasi del giudizio successive al primo o nei gradi successivi.
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione gli atti e di documenti cartacei a meno che non sia stata depositata una copia informatica conforme degli stessi.
Deposito telematico della sentenza
L’autorità giudiziaria deve pubblicare la sentenza con deposito telematico presso la segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo e secondo grado nel termine di 30 giorni che decorrono dalla sua deliberazione.
Leggi anche: “Procura alle liti: sanabile nel processo tributario”