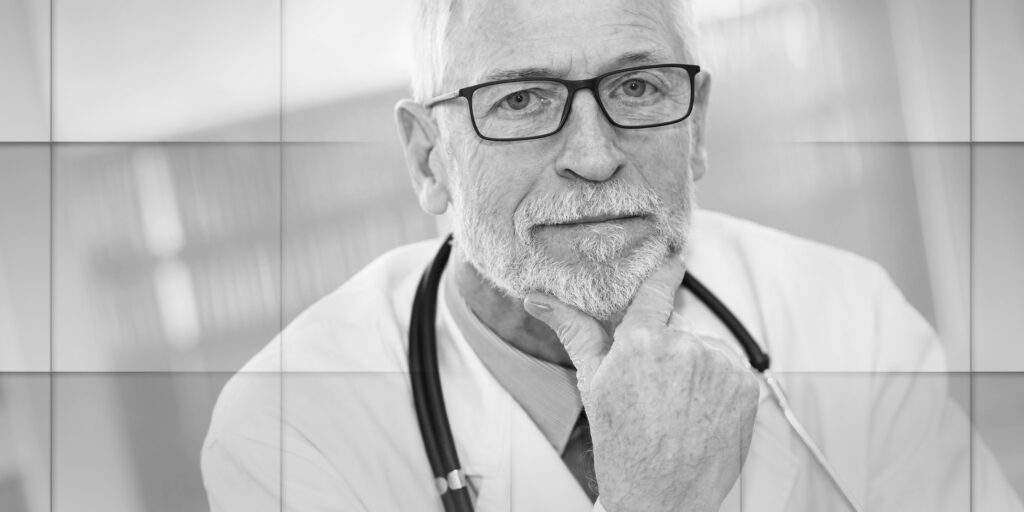Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima, Anna Libraro, Michela Pignatelli
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L. 18 marzo 1958, n. 311, e dell’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, al fine del conferimento della onorificenza di professore emerito, rileva unicamente l’attività svolta nella qualità di professore ordinario per almeno venti anni e non anche il periodo di servizio prestato quale professore associato (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 gennaio 2025, n. 1 – titolo di “Professore emerito”).
La sez. VII ha rimesso all’ Adunanza Plenaria la seguente questione di diritto: “Se alla luce del combinato disposto dell’art. 15 della L. 18 marzo 1958, n. 311, in relazione all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, il periodo di servizio trascorso rivestendo la qualifica di professore associato possa essere riconosciuto ai fini del raggiungimento della soglia dei venti anni di servizio, indispensabile per l’attribuzione della qualifica di professore emerito”.
L’Adunanza ritiene condivisibile la ricostruzione della Sezione, evidenziando che, come è stato correttamente sottolineato, l’art. 15, comma 2, della L. 311/1958 contiene un espresso richiamo all’art. 111 del R.D. 1592/1933 che, a sua volta, individua la qualifica di “professore emerito” e i requisiti per il suo conferimento. Ad avviso del Collegio, tale rinvio ha ribadito, dunque, il perdurante vigore della suddetta disposizione e dei requisiti ivi indicati.
Il dato letterale, ad avviso dei Giudici, è chiaro e insuperabile e comporta la non condivisibilità della ricostruzione effettuata da questo Consiglio di Stato con il parere della sez. II, 2203/2015 e con la sentenza della sez. VI, 1506/2021.
Entrambe queste pronunce, infatti, hanno dato preminente rilievo alla prima frase del secondo comma del citato art. 15, mentre avrebbero dovuto rilevare il significativo richiamo contenuto nella frase successiva (“ai sensi dell’art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592”).
L’Adunanza Plenaria rileva come il primario criterio di interpretazione della legge sia quello letterale.
Infatti, l’art. 12 (rubricato ‘Interpretazione della legge’) delle “disposizioni sulla legge in generale’ allegate al codice civile dispone che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
La rilevanza del dato testuale della legge, evidenzia l’Adunanza Plenaria, è desumibile anche dall’art. 101 della Costituzione, il quale – nel prevedere che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” – dispone il dovere del giudice di darne applicazione, salve le possibilità, consentite da altre disposizioni costituzionali, di emanare una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale o di dare applicazione a prevalenti regole dell’Unione europea.
Gli altri criteri di interpretazione rilevano solo quando risulti equivoca la formulazione linguistica dell’enunciato normativo e la disposizione presenti ambiguità e si presti a possibili differenti o alternative interpretazioni (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024, n. 6440).
Nel caso di specie, sostiene il Collegio, la formulazione linguistica risulta univoca e non si presta a dubbi interpretativi, atteso che occorre tenere conto anche dell’ultima frase contenuta nel sopra riportato comma 2 dell’art. 15.
Inoltre, i Giudici ritengono di non condividere la tesi dell’appellante anche sulla base dei criteri della interpretazione storico-sistematica e dell’interpretazione teleologica.
Innanzitutto, il Collegio disattende la tesi secondo cui vi sarebbe stata la “implicita abrogazione” dell’art. 15, comma 2, cit., in quanto tale disposizione va letta in modo sistematico in relazione alle altre disposizioni della L. 311/1958, e in particolare al suo art. 3, secondo cui: “I professori di ruolo sono straordinari e ordinari”; la portata innovativa di tale disposizione è consistita nell’estendere la valutabilità del servizio come professore di ruolo non solo nella qualità di professore ordinario (come previsto dall’art. 111, cit.), ma anche in quella di professore straordinario.
Rimarca il Collegio che la tesi dell’appellante neppure è supportata dalle considerazioni riguardanti la portata applicativa delle riforme universitarie, disposte dapprima con il D.P.R. 381/1980 (avente il rango di decreto legislativo) e poi dalla L. 240/2010, in quanto hanno sì previsto l’unicità del ruolo dei professori ordinari e di quelli associati, ma li hanno distinti per diversi aspetti.
L’art. 1 del D.P.R. 382/1980, pur prevedendo l’unicità del ruolo, ha distinto i compiti e le responsabilità degli uni e degli altri, inquadrandoli in due fasce funzionali.
Le perduranti differenze tra le due qualifiche riguardano: – le regole sul reclutamento, poiché per accedere alla qualifica di professore ordinario occorre l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, che dimostra il raggiungimento della piena maturità scientifica, mentre per accedere alla qualifica di professore associato occorre l’abilitazione scientifica nazionale; – i presupposti per potere accedere alle due qualifiche, poiché alla qualifica di professore ordinario si accede a seguito del raggiungimento della “piena maturità scientifica”; – le regole sul conferimento degli incarichi direttivi (Direttore di dipartimento, rettore, prorettore), riservati ai professori ordinari, con l’eccezione delle Università nelle quali essi non vi siano), con un regime diverso anche sull’elettorato attivo.
Dunque, anche dopo la riforma universitaria non si può ravvisare l’equiparazione tra la qualifica del professore ordinario e quella di quello associato.
Oltre alla persistente differenza sostanziale delle qualifiche di professore ordinario e di professore associato, in sede di interpretazione del secondo comma dell’art. 15, il Collegio afferma che occorre tenere conto della sua specifica ratio.
Sulla base di una specifica valutazione del legislatore, l’onorificenza può essere conferita al professore ordinario in considerazione della perduranza nel tempo – fissato in venti anni – dello svolgimento dell’attività lavorativa nella posizione apicale della docenza universitaria.
Tale perduranza, evidenzia la Plenaria, è stata considerata decisiva dal legislatore, affinché possa essere valutata la eccezionalità della carriera accademica, giustificativa dell’onorificenza.
Rileva, dunque, anche il dato testuale dell’art. 22 del D.P.R. 382/1980, per il quale sussiste l’equiparazione dello stato giuridico dei professori ordinari e di quello dei professori associati, “salvo che non sia diversamente disposto”: in materia di conferimento dell’onorificenza, il legislatore ha sempre attribuito rilievo esclusivamente alla qualifica di professore ordinario.
L’Adunanza Plenaria, pertanto, condivide e fa proprie le considerazioni poste a base della sentenza della Corte cost. 990/1988, per la quale “l’unitarietà della funzione docente non equivale all’unicità del ruolo dei professori universitari. Il sistema normativo del 1980 stabilisce una gerarchia di valori e delle funzioni tra le due fasce del ruolo dei professori, riservando compiti direttivi, organizzativi e di coordinamento all’ordinario, acquisito all’istruzione universitaria attraverso più severa selezione concorsuale mirante ad individuare una personalità scientifica compiutamente matura, mentre le diverse modalità del reclutamento dell’associato è preordinata soltanto ad accertarne l’idoneità scientifica e didattica”.
Non hanno pertanto rilievo gli indiscussi principi relativi alla unitarietà della funzione docente e alla pari garanzia di libertà didattica e di ricerca, evocati dall’appellante.
La distinzione tra le due qualifiche, ciascuna delle quali correlata ad un diverso livello di maturità scientifica e didattica, è stata confermata anche dalla riforma universitaria recata dalla L. 240/2010, che nulla ha innovato in materia.
(*Contributo in tema di “L’adunanza plenaria chiarisce i presupposti per il conferimento del titolo di “Professore emerito” nell’università”, a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima, Anna Libraro, Michela Pignatelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)