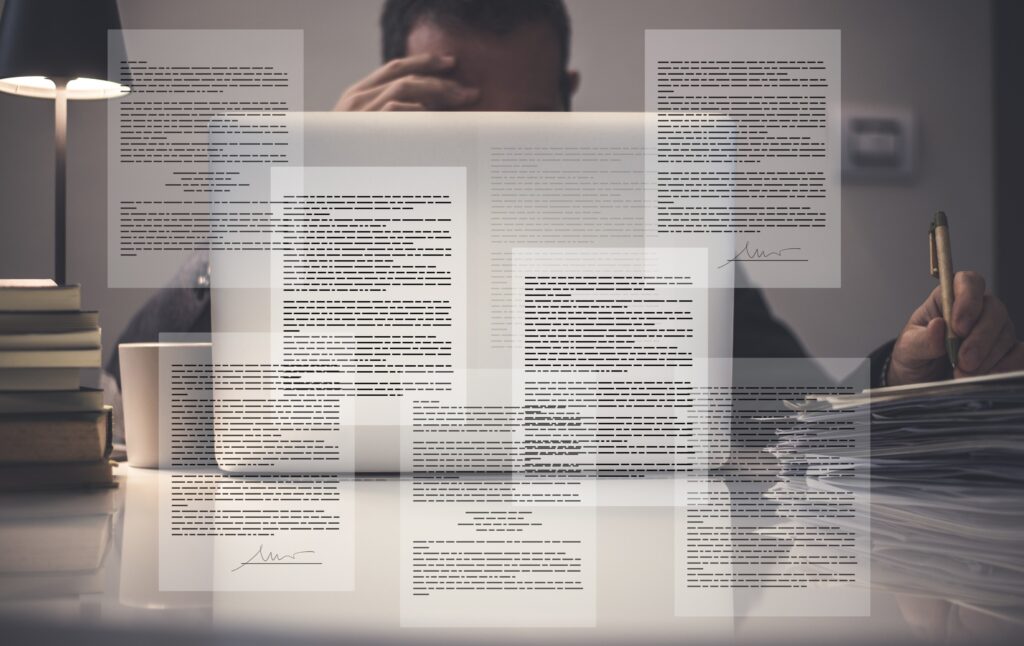Quesito con risposta a cura di Alessia Bruna Aloi, Beatrice Doretto, Antonino Ripepi, Serena Suma e Chiara Tapino
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea in concreto ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. – Cass. Sez. Un. 12 maggio 2022, n. 18891.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, riunita in Sezioni Unite, è stata chiamata a valutare se ad escludere l’operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131bis c.p., sia sufficiente il solo riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati, ovvero sia a tal proposito altresì necessaria la sussistenza di ulteriori condizioni previste dalla predetta disposizione normativa.
Nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato che l’utilizzo del termine “abituale” e non “occasionale” da parte del legislatore, nel disposto di cui all’art. 131bis c.p., ha sollevato un contrasto tra due opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa l’applicabilità in concreto della causa di esclusione della punibilità al reato continuato.
Secondo il primo indirizzo interpretativo, inizialmente prevalente, la causa di non punibilità non troverebbe applicazione nel caso di più reati esecutivi del medesimo disegno criminoso, in quanto tale vincolo, rispondendo alla medesima ratio del comportamento abituale, non supererebbe lo sbarramento posto dalla predetta disposizione normativa. Pur comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, invero, il vincolo della continuazione consisterebbe in un’oggettiva reiterazione di condotte rilevanti, sintomatiche di una devianza non occasionale, pertanto espressive di un comportamento abituale che giustificherebbe l’esclusione dal suddetto beneficio (Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897).
Il secondo indirizzo interpretativo, attualmente prevalente, ritiene configurabile la particolare tenuità del fatto nell’ipotesi di reato continuato, purché lo stesso non sia espressivo di una tendenza o inclinazione al crimine (Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358).
L’esclusione dell’abitualità anche rispetto ad un reato continuato, invero, dovrebbe avvenire valorizzando elementi ulteriori desumibili dall’art. 131bis c.p., in presenza dei quali, pertanto, il vincolo di continuazione non sarebbe indicativo del carattere seriale dell’attività criminosa o dell’abitudine del soggetto a violare la legge, ostativi all’operatività della predetta disposizione normativa.
Tuttavia, tale indirizzo distinguerebbe tra continuazione diacronica, sussistente in caso di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, ma commessi in contesti spaziali e temporali diversi, e continuazione sincronica, sussistente in caso di una pluralità di condotte espressive di un medesimo disegno criminoso, ma commesse in un unico contesto spaziale e temporale.
La violazione criminosa in caso di continuazione sincronica sarebbe invero unica, stante la contemporanea esecuzione temporale e spaziale delle distinte azioni delittuose e sarebbe pertanto compatibile con il concetto di estemporaneità dell’azione illecita rispetto alla personalità positiva del reo, da cui si desumerebbero i presupposti finalizzati alla valutazione dell’operatività dell’art. 131bis c.p. (Cass., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434).
Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto stabilito dalle Sezioni Unite in una precedente pronuncia, che ha analizzato le tre ipotesi tassative di comportamento abituale di cui all’art. 131bis, comma 3, c.p.
Il primo di tale triplice criterio risulta non suscitare problemi di interpretazione, essendo già definita dal legislatore la qualificazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza attraverso gli artt. 105 e ss. c.p.
In relazione al secondo criterio, vale a dire più reati della stessa indole, il dato normativo parla di “reati” e non di “condanne”; pertanto, la pluralità di reati, da intendere partendo da almeno due rispetto a quello in sede di accertamento, è configurata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche a fronte di accertamenti di reato non ancora definitivi o di reati da giudicare nel medesimo procedimento.
In relazione al terzo criterio, vale a dire condotte abituali e reiterate, la sentenza richiamata chiarisce che il legislatore richiami fattispecie che prevedono l’elemento tipico della condotta abituale, come nel caso del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., nonché delle condotte reiterate, come nel caso del reato di atti persecutori di cui all’art. 612bis c.p.
Le condotte plurime, lungi dall’essere una ripetizione delle condotte abituali e reiterate, si riferiscono a fattispecie concrete connotate da distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti. Non è desumibile, pertanto, alcun riferimento preclusivo al reato continuato (Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016, n. 13681).
Le Sezioni Unite aderiscono alle conclusioni della predetta pronuncia e condividono l’impostazione del secondo orientamento giurisprudenziale.
Il Supremo Collegio muove, in prim’ordine, dalla premessa che il concorso formale di reati è caratterizzato dall’unicità dell’azione o dell’omissione, escludendone pertanto sia la collocazione tra i reati della stessa indole o tra le condotte plurime, abituali e reiterate, sia la natura di condotta abituale.
Il reato continuato, parimenti, consiste in una particolare ipotesi di concorso di reati, essendo tuttavia considerato unitario ai soli fini della determinazione della pena o della garanzia di un eventuale risultato favorevole al reo (Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775; Cass. Sez. Un. 27 novembre 2008, n. 3286).
Di conseguenza, annoverare il concorso formale di reati tra i presupposti per la particolare tenuità del fatto a discapito del reato continuato, comporterebbe un trattamento discriminatorio e una violazione del canone di ragionevolezza.
Chiarito che i reati avvinti dal vincolo della continuazione possono essere suscettibili di applicazione dell’art. 131bis c.p., le Sezioni Unite hanno altresì stabilito che gli stessi devono essere oggetto di un complessivo apprezzamento discrezionale del giudice, che deve soppesarli con la sussistenza di ulteriori criteri al fine di valutare l’operatività dell’art. 131bis c.p., tra cui la natura e la gravità dei reati unificati, dei beni giuridici lesi o posti in pericolo, l’entità delle disposizioni di legge violate, le finalità e le modalità esecutive della condotta, le motivazioni e le conseguenze derivatene, l’arco temporale e il contesto in cui le violazioni medesime si collocano, l’intensità del dolo e la rilevanza dei comportamenti successivi ai fatti.
La natura dei reati in continuazione e il bene giuridico dagli stessi leso, tuttavia, sollevano la possibilità di integrare più reati della stessa indole, che definiscono un comportamento abituale tale, dunque, da escludere il reato continuato dall’operatività dell’art. 131bis c.p.
La soluzione cui perviene il Supremo Collegio consiste invero nella valutazione del dato numerico dei reati della stessa indole, posto che l’art. 131bis c.p. parla di più reati, che pertanto devono essere almeno due e a cui deve aggiungersi il reato oggetto di accertamento giudiziario. Ne consegue che, solo se inferiori a tre, i reati della stessa indole uniti dal vincolo della continuazione non incorrono nel comportamento abituale preclusivo dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità.
Tuttavia, nella nozione di “stessa indole” vi rientra la sola continuazione omogenea, caratterizzata dalla plurima violazione della medesima disposizione di legge.
Le Sezioni Unite infine escludono dall’ambito dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis c.p., la sola continuazione diacronica, dal momento che comporta la reiterazione di condotte delittuose in contesti spaziali e temporali distanti, sintomatiche di una pervicacia criminale che non consente di qualificare il fatto come occasionale.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che la pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione non è ostativa all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis c.p., salvo che il giudice la ritenga idonea ad integrare una o più delle condizioni previste dalla medesima disposizione normativa per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.
| PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI |
Conformi: Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 5358; Cass., sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434;
Cass. Sez. Un. 25 febbraio 2016, n. 13681; Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2009, n. 18775;
Cass. Sez. Un. 27 novembre 2008, n. 3286 |
| Difformi: Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897 |