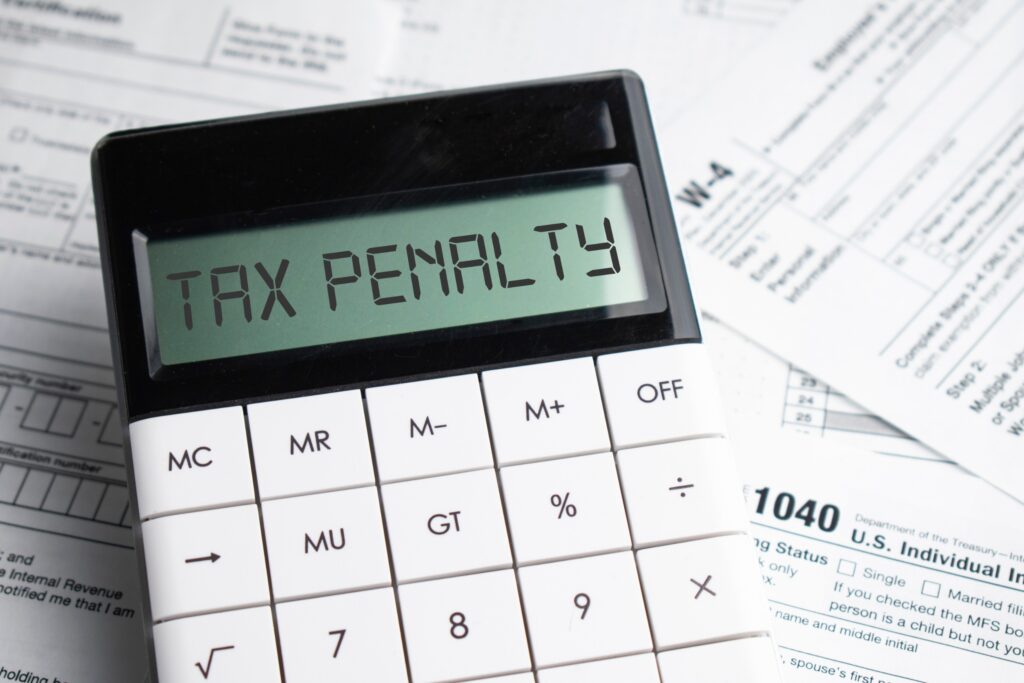Bollette: cosa cambia con la fine del mercato di maggior tutela Cosa cambia dal 1° luglio 2024 per chi ancora non ha scelto un fornitore del mercato libero dell’energia elettrica
Mercato libero: dal 1° luglio 2024 tutele graduali
Il 1° luglio 2024 entra in vigore il servizio a tutele graduali per l’energia elettrica. Si tratta di un meccanismo temporaneo che accompagna i clienti domestici non vulnerabili verso la fine del mercato tutelato, con l’obiettivo di favorire la completa liberalizzazione del mercato entro il 2027. Le tutele graduali rappresentano un passo verso la completa liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Per i consumatori è importante essere informati e fare scelte consapevoli, valutando le proprie esigenze e confrontando le diverse offerte disponibili.
Cosa cambia?
I soggetti interessati al passaggio alle tutele graduali sono i clienti domestici non vulnerabili che, al 30 giugno 2024, non hanno ancora scelto un fornitore del mercato libero. Si tratta, come anticipato, di un passaggio morbido verso il mercato libero, che rappresenterà l’unica scelta possibile.
Fino alla fine del mese di giugno 2024 i clienti non vulnerabili riceveranno, in almeno due bollette, una comunicazione con cui vengono informati della possibilità di scegliere un fornitore e quindi un’offerta del mercato libero. Chi non dovesse fare una scelta in tale senso entro la scadenza del 1° luglio beneficerà del servizio a tutele graduali. Le condizioni contrattuali verranno definite da ARERA.
La “nuova” bolletta
La bolletta prevista per il regime delle tutele graduali comprende:
- la spesa per la materia energia (basata sul PUN ossia il prezzo unico nazionale);
- i costi di approvvigionamento e commercializzazione.
Il prezzo finale che verrà applicato dal fornitore varierà tuttavia in base ai parametri dell’area in cui lo stesso opera. In base ai calcoli di Arera, il risparmio in bolletta rispetto al regime di maggior tutela, dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro all’anno.
Per i clienti “vulnerabili”, ossia gli over 75enni e i beneficiari di bonus sociali o delle agevolazioni previste dalla legge 104, invece, non cambia nulla. La fornitura rimane nel mercato tutelato alle stesse condizioni.
Mercato tutelato e libero a confronto
Nel secondo semestre 2023 il prezzo medio nel mercato libero era superiore a quello del mercato tutelato (39,18 contro 28,11 centesimi/kWh). C’è da dire però che il mercato libero offre maggiore flessibilità perché prevede tariffe fisse o variabili, servizi aggiuntivi e la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore.
Come scegliere il fornitore del mercato libero
I clienti che sceglieranno il mercato libero potranno confrontare le offerte sul portale https://ilportaleofferte.it/ e valutare la tariffa più adatta alle proprie esigenze, valutando se sia migliore quella fissa, quella variabile, i servizi aggiuntivi di interesse, ecc.
Qualche consiglio
Per una scelta ponderata confrontare le offerte è fondamentale. Prima di aderire alle tutele graduali o scegliere un fornitore del mercato libero, è importante infatti confrontare le diverse proposte per trovare la soluzione più conveniente. É necessario poi valutare le proprie esigenze. La scelta tra tutele graduali e mercato libero dipende da vari fattori, come il profilo di consumo, la necessità di servizi aggiuntivi e l’avversione al rischio, che farà propendere per una prezzo fisso anziché variabile. Da ultimo, ma non per importanza, si consiglia di approfondire le novità. A questo proposito è opportuno consultare il sito web di Arera (https://www.arera.it/) e il portale https://ilportaleofferte.it/.
Abolizione del mercato tutelato
Il mercato tutelato viene abolito perché il decreto legge “Bersani” n. 79/1999 aveva avviato il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, in quanto recepiva le prescrizioni contenute nella Direttiva UE del 1996 per la creazione di mercato europeo unico dell’energia. Nel 2007 in Italia il mercato dell’energia è stato liberalizzato, ma sarà solo con la chiusura del mercato regolamentato che si avrà il passaggio definitivo al libero mercato, caratterizzato da un prezzo che si formerà grazie all’incontro di domanda e offerta.