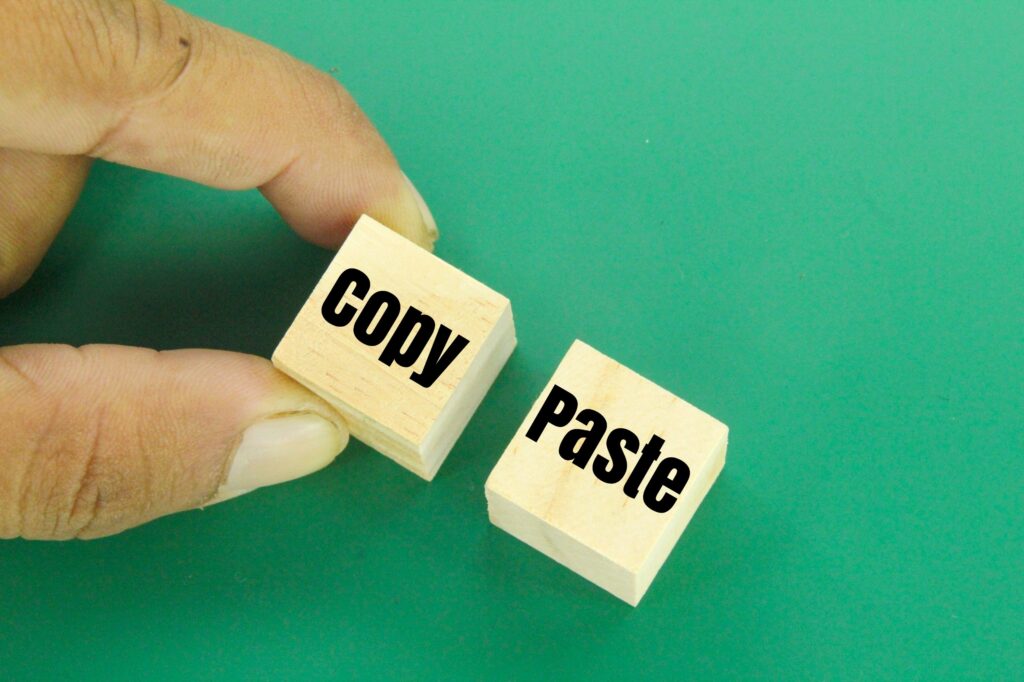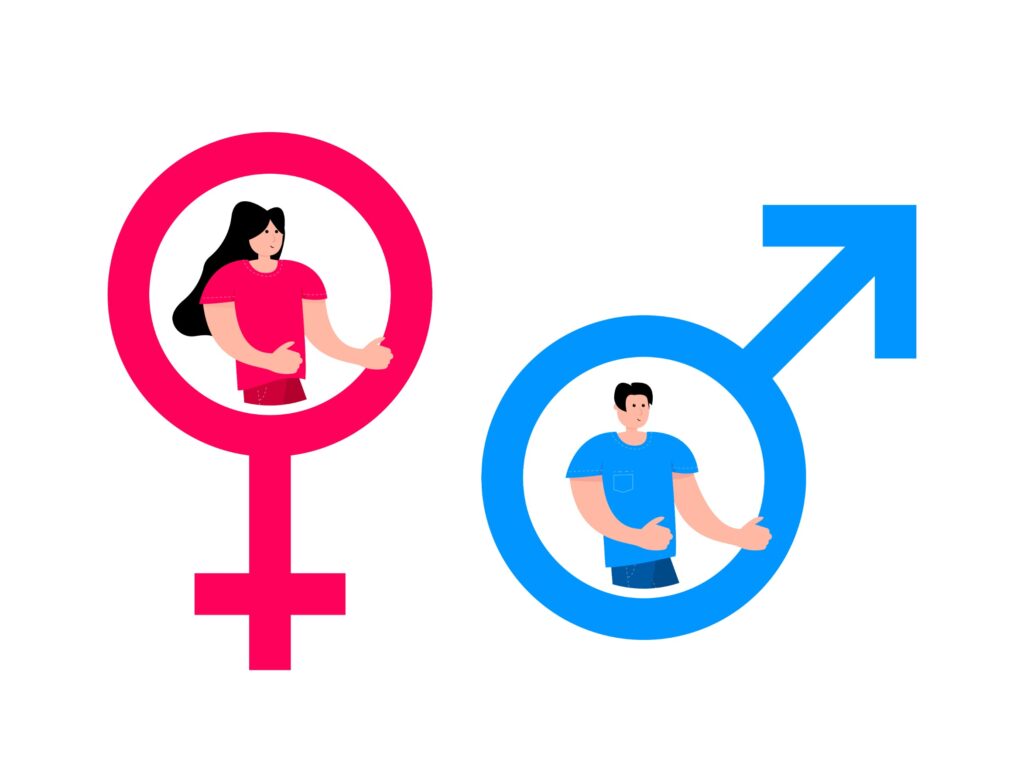Non punibile chi copia senza citare la fonte Non punibile chi copia senza menzionare la fonte da cui ha attinto e chi offende su Facebook se i fatti sono particolarmente tenui
Particolare tenuità del fatto per chi copia
Non punibile chi copia senza citare la fonte da cui ha attinto e chi rivolge frasi ingiuriose alla persona offesa su Facebook se i fatti si caratterizzano per la particolare tenuità prevista dall’art. 131 bis c.p. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 39647/2024.
Imputati assolti per particolare tenuità dei fatti commessi
La Corte d’appello riformando la sentenza di primo grado assolve uno degli imputati dal reato previsto dall’articolo 171 della legge n. 633/1941. Il soggetto agente è stato ritenuto responsabile di avere trascritto e diffuso senza autorizzazione e senza citare la fonte la parte di un libro, opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore. L’imputata invece è stata assolta “per la particolare tenuità del fatto” dal reato di cui all’art. 595 commi 1 e 3. La stessa è stata accusata di aver offeso la persona offesa su Facebook rivolgendole frasi ingiuriose. La sentenza revoca inoltre le statuizioni civili del giudice di primo grado con cui aveva condannato le parti a risarcire la parte civile con l’importo complessivo di 5.500,00 euro.
Errato ritenere non punibile chi copia e chi offende
La parte civile ricorre la decisione in Cassazione lamentando principalmente l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis c.p e contestando la revoca delle statuizioni civili.
Assoluzione per particolare tenuità
La Cassazione però ritiene inammissibile l’impugnazione della parte civile relativa alla concessione agli imputati del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Per la S.C. il ricorso della parte civile è inammissibile per carenza di interesse considerato che il pubblico ministero non ha impugnato la sentenza che ha dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La statuizione della non punibilità non produce infatti alcun effetto pregiudizievole per il danneggiato nel giudizio civile in base a quanto sancito dall’articolo 652 bis c.p.p Il comma 1 di questa norma dispone infatti che: “La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.”
Leggi anche: Particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione