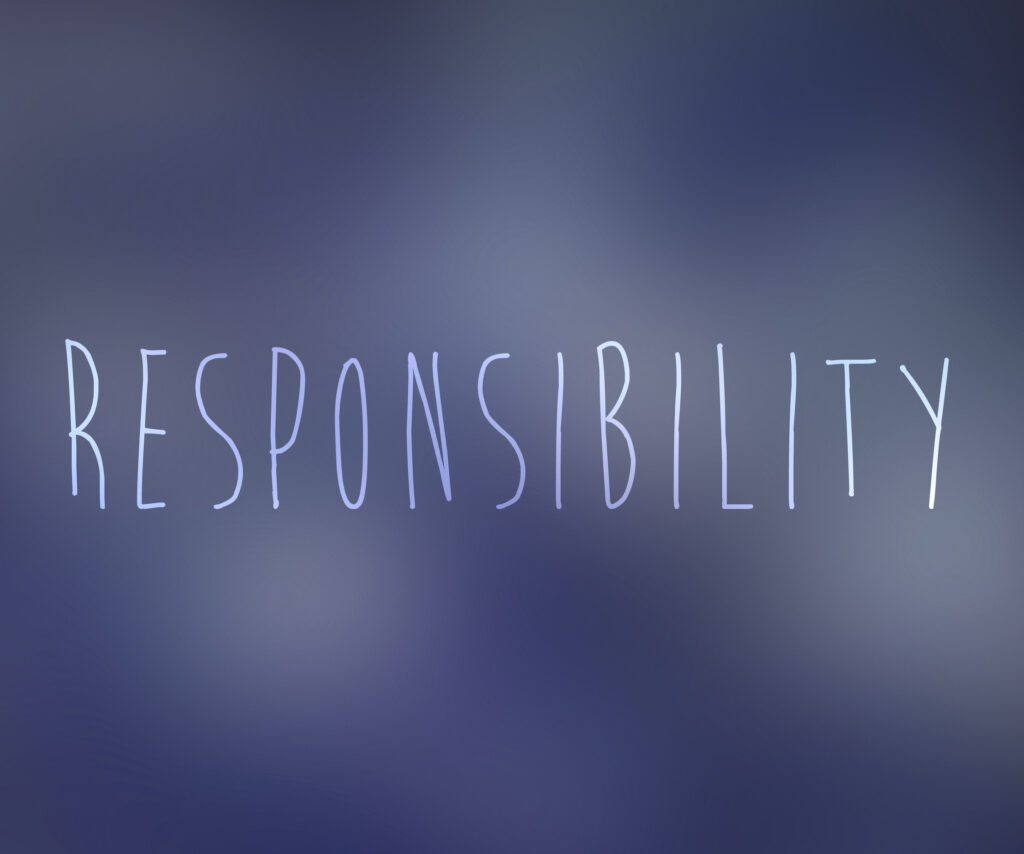Quesito con risposta a cura di Silvia Mattei e Michele Pilia
In tema di riduzione o mantenimento in schiavitù, presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente è la situazione di necessità da porsi in relazione non con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., quanto piuttosto con la nozione di bisogno delineata in tema di usura aggravata e allo stato di bisogno utilizzato nella rescissione del contratto; la predetta condizione deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo adatta a condizionarne la volontà personale, coincidendo con la definizione di “posizione di vulnerabilità” nell’ambito della disciplina europea individuata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani (Cassazione, sez. III, 21 gennaio 2025, n. 2450).
La Corte di Assise ha dichiarato colpevoli tre imputati delle condotte rispettivamente loro ascritte di riduzione in schiavitù, di tentata alienazione della persona offesa, di tentata estorsione, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e di cessione di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la Corte di Assiste d’appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado oggetto di gravame, assolvendo uno degli imputati dal delitto di tentata alienazione perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, riducendo altresì la pena nei confronti di altro imputato, ferma restando l’acclarata responsabilità penale di costoro.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri motivi di ricorso presentati dagli imputati per il tramite dei loro difensori, l’insussistenza del delitto di riduzione in schiavitù posto che, secondo le argomentazioni del ricorrente, non sarebbe riscontrabile la mancanza di libertà di movimento da parte della persona offesa, l’impossibilità di comunicare con terze persone, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza, come formalmente contestato.
In merito al motivo di censura oggetto di interesse, la Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso non fondato, ha analizzato la struttura nonché i presupposti del reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all’art. 600 c.p. Il delitto in parola è un reato a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario – implicando così la reificazione della vittima ed ex se lo sfruttamento – ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa in relazione alla quale è richiesta la prova dell’imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima (prestazioni lavorative o sessuali, accattonaggio o comunque il compimento di attività illecite).
In particolare, la condizione personale della vittima del delitto di cui all’art. 600 c.p. qualificabile come “servitù” è caratterizzata da uno stato di soggezione continuativa, provocato e mantenuto con una delle modalità indicate al comma 2, ossia mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento della situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l’autorità sulla persona, che si sostanza nel costringere o indurre la persona stessa a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in stato di schiavitù o di servitù di una persona in stato di soggezione continuativa è richiesto, oltre la prova dell’imposizione alla persona offesa di prestazioni integranti una delle predette forme di sfruttamento di cui al comma 1 dell’art. 600 c.p., preliminarmente la dimostrazione che il soggetto agente ha ridotto o mantenuto la persona sfruttata in servitù tramite una delle modalità alternative indicate al comma 2.
Orbene, come espresso dalla Suprema Corte, il reato di riduzione in schiavitù non richiede la totale privazione della libertà personale, ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione delle persona offesa, idonea a configurare lo stato di soggezione richiesto dalla norma incriminatrice (Cass. 21 maggio 2020, n. 15662). Di conseguenza, la soggezione continuativa non viene meno in presenza di una limitata autonomia della vittima che non intacchi il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato.
Inoltre, i giudici di legittimità si sono espressi riguardo la “situazione di necessità” in cui deve versare la vittima ritenendo che costituisca presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente che essa non deve porsi in relazione con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., quanto piuttosto con la nozione di bisogno delineata in tema di usura aggravata (art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) e allo stato di bisogno utilizzato nella rescissione del contratto (art. 1418 c.c.); la predetta condizione deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale coincidendo con la definizione di “posizione di vulnerabilità” nell’ambito della disciplina europea individuata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani (Cass. 25 gennaio 2007, n. 2841).
Pertanto, si ha approfittamento della situazione di vulnerabilità della persona offesa anche quando l’autore del reato, conscio della condizione di debolezza fisica, psichica o esistenziale della persona offesa, se ne sia subdolamente avvalso per accedere alla sua sfera interiore, manipolandone la capacità critica e le tensioni emotive e per tale via inducendola in uno stato di remissività così da ridurla a mezzo per soddisfare più agevolmente il proprio proposito di sfruttamento sul piano lavorativo ovvero imponendo obblighi di facere.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte ha ritenuto che l’imputata si sia avvalsa della condizione oggettiva di vulnerabilità e inferiorità psichica della persona offesa, costringendola a prostituirsi, a lavorare fino a tarda notte e a consegnarle i proventi dell’attività di meretricio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte ha, quindi, dichiarato l’infondatezza dei ricorsi presentati, rigettandoli e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.