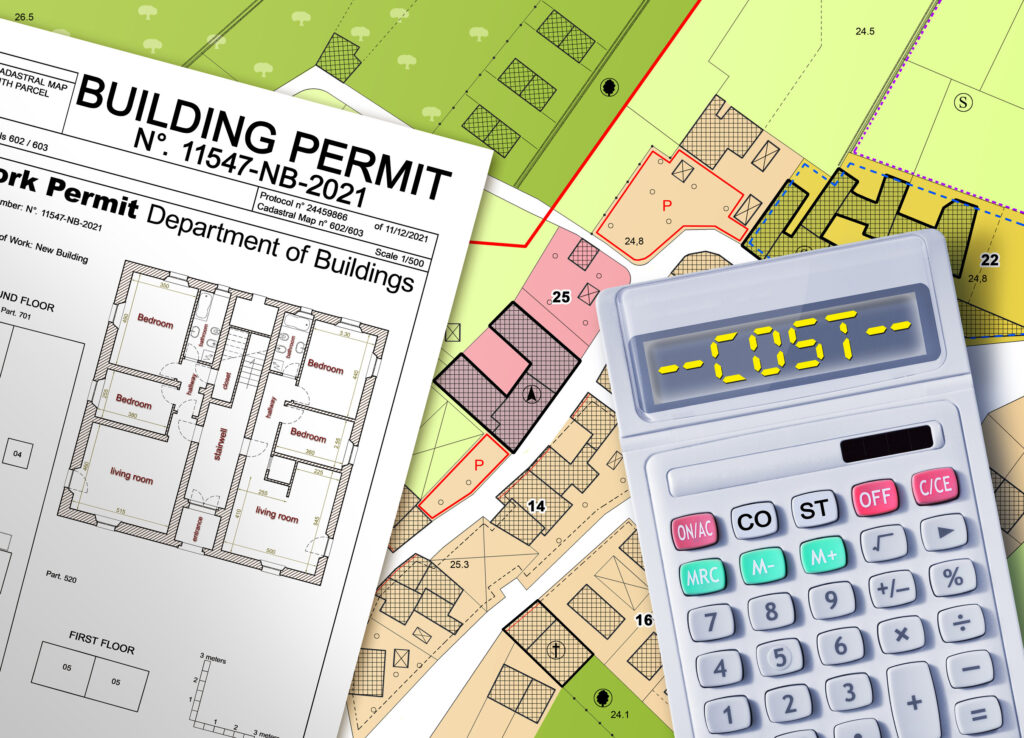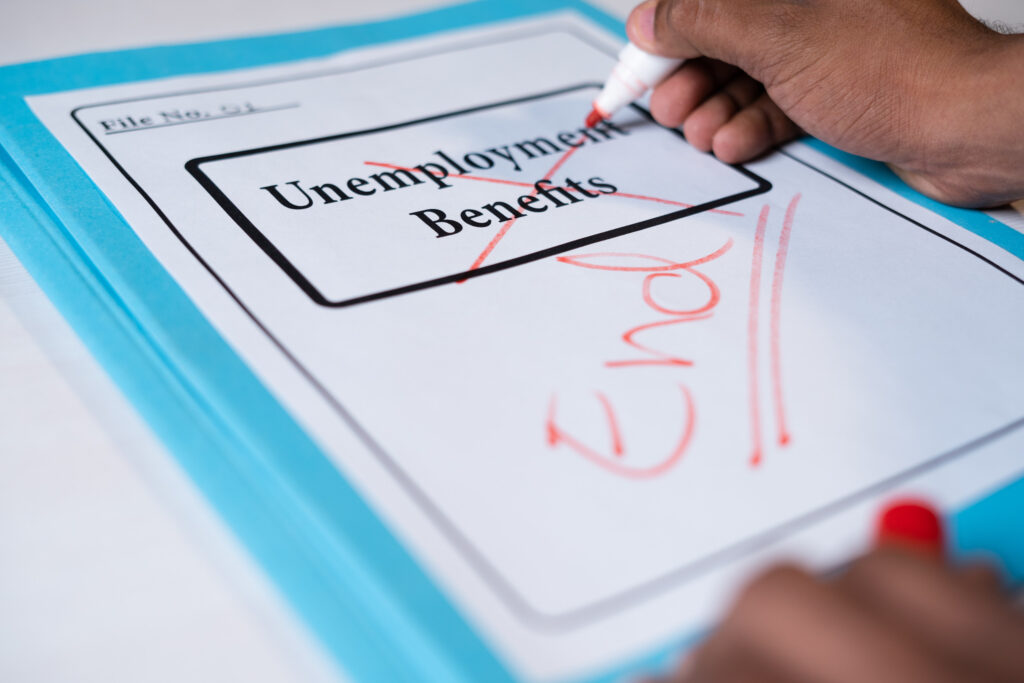Tribunale per i minorenni: 8 euro per ogni e-mail con copie digitali Il Ministero della giustizia chiarisce i costi per il rilascio di copie digitali nei procedimenti minorili: 8 euro per ogni email inviata, 25 euro per copie audio-video
Costi copie digitali nei procedimenti minorili
Con provvedimento del 10 giugno 2025, la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, tramite il canale Filo Diretto, ha fornito risposta a un quesito sollevato dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari in merito all’applicazione dei diritti di copia nei procedimenti penali minorili.
Assenza del fascicolo informatico e problematiche
Il Tribunale per i minorenni di Bari ha evidenziato come, in assenza del fascicolo penale informatico e del relativo applicativo gestionale (TIAP), la trasmissione telematica degli atti richieda una preventiva scansione manuale dei documenti. Questa attività, particolarmente onerosa in termini di tempo e risorse umane, non è attualmente valorizzata nei diritti forfettari previsti per la copia degli atti.
Applicazione dell’art. 269-bis del Dpr n. 115/2002
La Direzione generale ha chiarito che trova piena applicazione l’articolo 269-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), anche in assenza del fascicolo informatico.
In particolare, è stato stabilito che:
-
Per ogni richiesta di rilascio e invio per via telematica (email o PEC) di copie digitali di atti e documenti relativi a procedimenti penali minorili, si applica un diritto forfettario di 8 euro per ogni singolo invio, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse.
-
Tale importo è previsto dalla tabella allegato n. 8 del d.P.R. n. 115/2002.
Copie di file audio e video: il diritto forfettario
Sebbene non oggetto diretto del quesito, la Direzione ha confermato che anche per la riproduzione di file audio o video su supporti informatici (come chiavette USB, CD o DVD), si applica un diritto di copia forfettario pari a 25 euro.
Possibilità di rilascio cartaceo
Resta salva, come già ricordato nel provvedimento del 5 marzo 2025, la possibilità per l’utente di richiedere copie cartacee, per le quali continua ad applicarsi il tradizionale sistema di calcolo dei diritti di copia, commisurati al numero di pagine richieste.