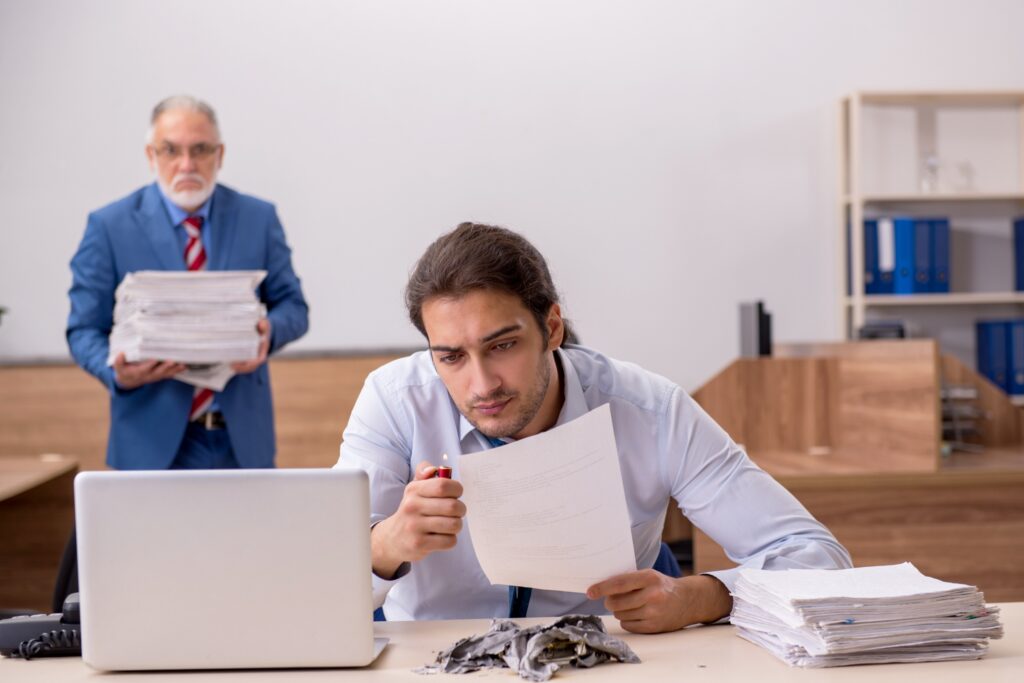Testo Unico Rinnovabili Testo Unico energie rinnovabili: semplificazioni, zone di accelerazione e nuove regole amministrative per la produzione di energia
Approvato il Testo Unico Rinnovabili
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico Rinnovabili, una normativa che ridefinisce i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Sebbene l’obiettivo dichiarato sia la semplificazione delle procedure, il decreto rischia di aggiungersi alla già complessa giurisprudenza in materia energetica.
Il Testo Unico Fer rappresenta un tentativo di bilanciare le esigenze di sostenibilità con la necessità di semplificazione amministrativa. Tuttavia, resta il dubbio che questa nuova normativa possa creare sovrapposizioni con il quadro normativo esistente, accentuando la complessità anziché ridurla. Sarà fondamentale un attento monitoraggio per valutarne l’efficacia e l’impatto sul settore delle energie rinnovabili in Italia.
La normativa entrerà in vigore il 30 dicembre 2024. Regioni ed enti locali avranno 120 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Testo Unico Rinnovabili: obiettivi e ambiti di applicazione
Il decreto si propone di favorire la diffusione degli impianti di energia rinnovabile, garantendo al contempo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio. Le principali novità includono la definizione di tre regimi amministrativi: attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica. L’introduzione di meccanismi come il silenzio-assenso e la riduzione dei tempi per la PAS (ora fissati a 30 giorni) mirano a snellire gli iter burocratici, incentivando gli investimenti nel settore.
Modifiche principali
Diverse le novità che meritano di essere segnalate.
- Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL), per semplificare la gestione per molti interventi.
- Ampliate le attività in regime di attività libera, che ora includono interventi su aree vincolate, purché non visibili dall’esterno e realizzati con materiali tradizionali.
- Nuove disposizioni sulla PAS, che prevedono una sola sospensione per eventuali integrazioni documentali e oneri istruttori per progetti sopra 1 MW di potenza.
- Autorizzazione unica, concessa entro 120 giorni dalla Conferenza dei Servizi, con validità minima di cinque anni.
Le violazioni alle disposizioni comporteranno sanzioni amministrative più severe, per prevenire abusi e difformità.
Zone di accelerazione e impatti ambientali
Il decreto introduce anche il concetto di zone di accelerazione, aree in cui le procedure autorizzative vengono ulteriormente semplificate. Il GSE (Gestore dei Servizi energetici) si occuperà di una mappatura nazionale per individuare le aree terrestri e marine idonee, che saranno poi regolamentate da piani regionali e nazionali. Inoltre, interventi in attività libera e PAS non saranno soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), grazie a modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006.
Leggi anche: Decreto Ambiente: cosa prevede