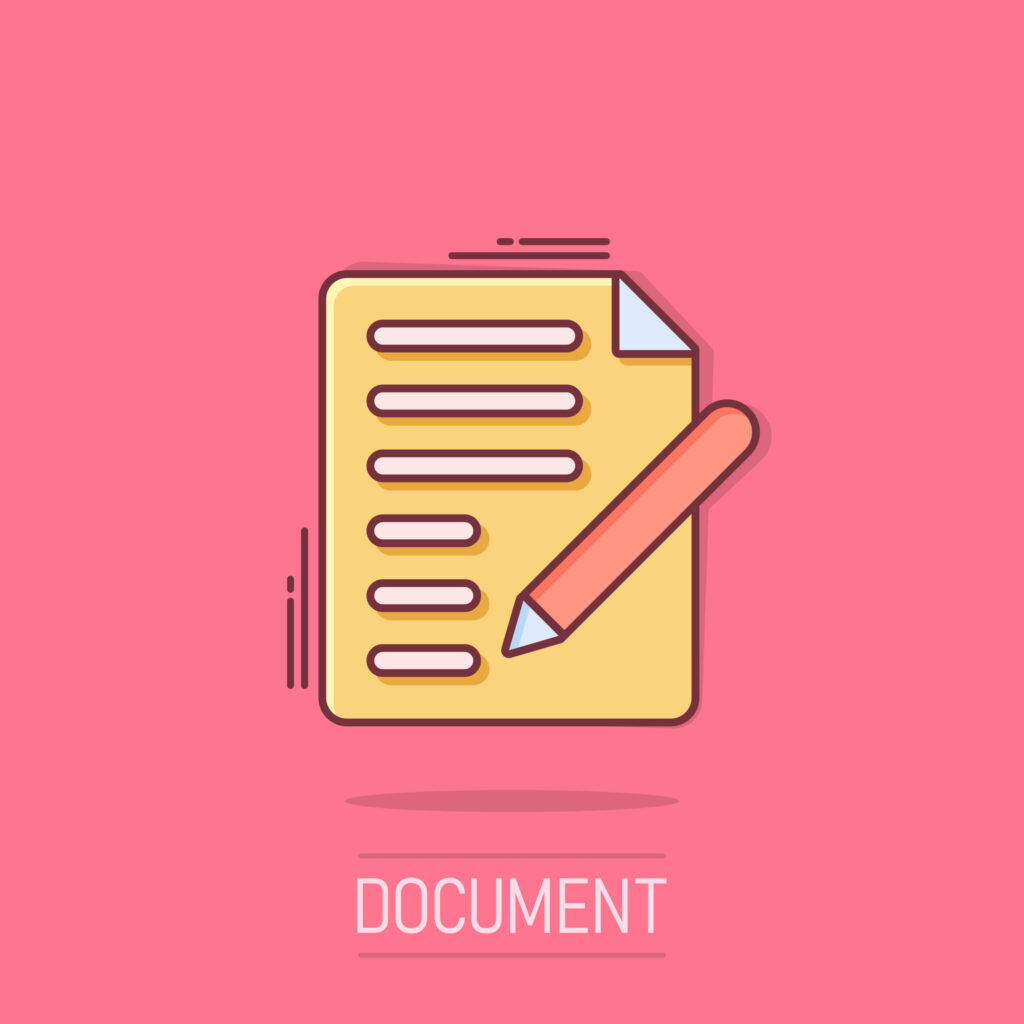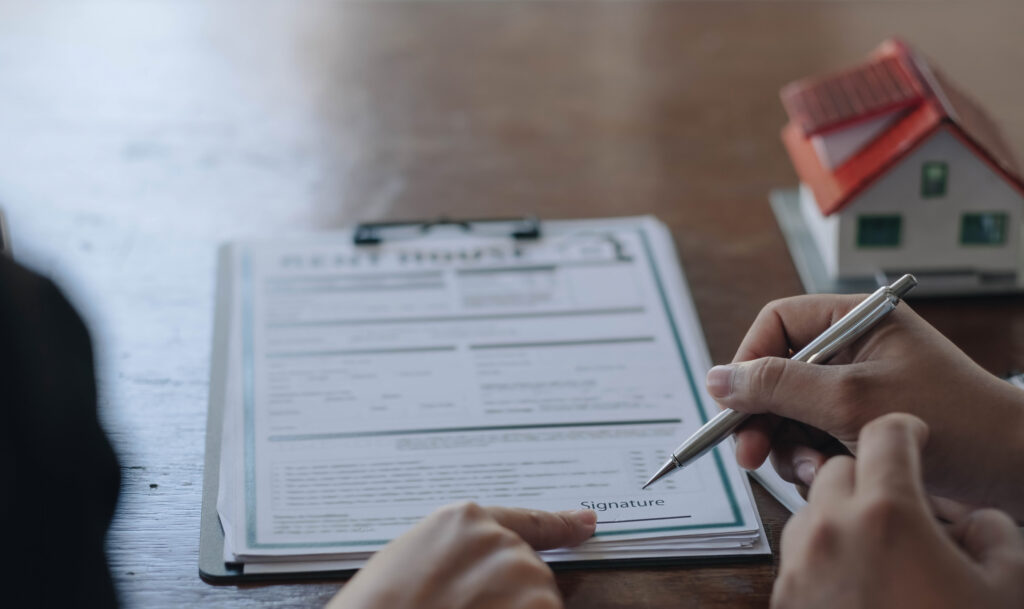Remissione di querela: guida e modello Remissione di querela: cos'è, quali sono le conseguenze e la giurisprudenza rilevante in materia
Cos’è la remissione di querela
La remissione di querela, disciplinata dall’art. 152 del Codice Penale, è l’atto con cui la persona offesa revoca la querela sporta per un reato perseguibile a querela di parte, provocando l’estinzione del reato. Questa facoltà è fondamentale nei procedimenti per reati minori, favorendo la composizione bonaria delle controversie.
Quando si può fare la remissione di querela
La remissione è possibile solo per i reati procedibili a querela di parte, come:
- ingiuria (prima della depenalizzazione), diffamazione, lesioni lievi, violenza privata;
- danneggiamento semplice, minacce non aggravate.
Essa può essere effettuata:
- prima dell’inizio del processo o durante il processo, ma prima della condanna, ad eccezione dei casi previsti dalla legge;
- in sede processuale o extraprocessuale in modo espresso o tacito (se il querelante compie atti incompatibili con la volontà di portare avanti la querela);
- senza apporre alla stessa termini o condizioni, in essa però si può indicare la rinuncia al diritto di ottenere restituzioni e risarcimento del danno.
Conseguenze della remissione di querela:
- estinzione del reato: il procedimento penale cessa;
- impossibilità di riproporre la querela, in quanto l’atto è irrevocabile.
Accettazione della remissione
L’art. 155 c.p. stabilisce che:
- la remissione non produce effetti se il querelato la ricusa in modo espresso o tacito;
- se il querelato è un minore o un interdetto, non ha un rappresentante o è in conflitto con lo stesso, la remissione è accettata dal curatore speciale.
Giurisprudenza rilevante sulla remissione di querela
Di seguito alcune massime della Cassazione:
Cassazione n. 16375/2019
La rinuncia alla denuncia, una volta che la persona accusata l’ha formalmente accettata, porta alla chiusura del procedimento penale, annullando il reato. Questo effetto ha la precedenza su qualsiasi altra ragione di chiusura del caso. Se questa rinuncia avviene mentre il caso è in esame presso la Corte di Cassazione, i giudici devono obbligatoriamente dichiarare la fine del processo. La decisione di chiudere il caso per rinuncia alla denuncia cancella automaticamente tutte le condanne civili legate al reato.
Cassazione n. 35539/2021
“integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016).
Cassazione n. 31832/2024
“Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.”
Cassazione n. 6031/2025
“ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.”
Modello di remissione di querela
Oggetto: Remissione di querela
Spett.le Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Città]
Io sottoscritto/a [Nome e Cognome], nato/a il [data] a [luogo], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo], dichiaro di rimettere la querela sporta in data [inserire data] nei confronti del Sig./Sig.ra [Nome dell’imputato], nato/a il [data], per il reato di [indicare il reato] (art. [articolo c.p.]).
Dichiaro di essere consapevole che la remissione è irrevocabile e comporta l’estinzione del reato.
[Luogo, Data]
Firma: _____________________
Allega: copia del documento di identità.
Leggi anche: Il singolo condomino può proporre querela