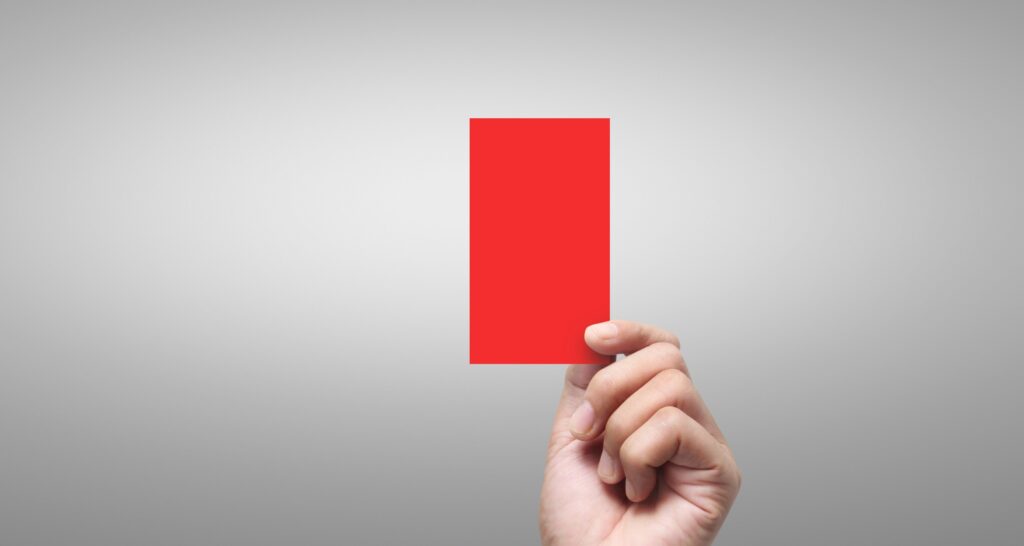Fondo di garanzia per le vittime della strada Il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada risarcisce i danni a persone e cose nei casi e nei modi stabiliti dalla legge
Cos’è il Fondo di Garanzia per le vittime della strada
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (FGVS) è nato per risarcire i danni causati da sinistri stradali che si verificano in circostanze particolari. Il fondo è operativo dal 12 giugno 1971 ed è amministrato dalla Consap con l’assistenza di un Comitato. Sul Fondo vigila il Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Principali riferimenti normativi
Il Fondo di Garanzia è nato grazie alla legge n. 990/1969, abrogata quando è entrato in vigore il Codice delle assicurazioni private contenuto nel decreto legislativo n. 209/2005, continuamente modificato e aggiornato. Le principali norme di riferimento del Fondo di garanzia sono gli articoli 283 e 286 del dlgs n. 209/2005.
Fondo di Garanzia per le vittime della strada: quando opera
Il Fondo di Garanzia opera infatti nei casi specifici previsti dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni private.
Esso risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nei seguenti casi principali:
- il veicolo o il natante che hanno cagionato i danni non è stato identificato;
- il mezzo non risulta coperto da assicurazione;
- il natante è assicurato presso un’impresa che opera all’interno del territorio della Repubblica in regime di stabilimento di libertà di prestazione di servizi e al momento del sinistro o in seguito si trova in stato di liquidazione coatta;
- il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario o di chi ne ha la titolarità;
- il veicolo che ha cagionato il sinistro è estero e la targa non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo;
- veicolo non assicurato è stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato dello Spazio Economico Europeo avvenuto nel periodo compreso tra la data di accettazione di consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.
Limiti risarcitori
Il Fondo di Garanzia non provvede sempre al risarcimento integrale dei danni. Ci sono dei casi in cui lo stesso risarcisce certi tipi di danno e certi importi.
Ad esempio, nel caso in cui un veicolo non identificato sia responsabile dei danni, il Fondo risarcisce solo i danni alla persona, mentre per i danni alle cose risarcisce la parte del danno che eccede i 500,00 euro. Se invece il veicolo che cagiona i danni non è coperto da assicurazione, il Fondo copre sia i danni alle persone che alle cose. La norma di riferimento per conoscere in dettaglio i limiti risarcitori del Fondo è l’art. 283 del Codice delle. Assicurazioni Private.
Liquidazione dei danni
L’articolo 286 del Codice delle Assicurazioni private stabilisce che la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo 283, coperti quindi dal Fondo di garanzia, venga effettuata da un’impresa assicurativa designata dall’IVASS secondo quanto stabilito nel regolamento adottato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.
L’impresa di assicurazione, una volta designata, liquida anche i danni relativi ai sinistri che si sono verificati oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designa una nuova impresa.
Le somme che vengono pagate dalle imprese designate sono rimborsate dalla Consap, che gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Per sapere quale impresa è designata dall’IVASS alla liquidazione dei danni nei casi sopra esaminati basta visitare la pagina dedicata Elenchi Imprese del sito della Consap.
Come farsi risarcire dal Fondo vittime della Strada
Per chiedere il risarcimento nei casi di sinistro stradale rientrante in una delle ipotesi per le quali è prevista la copertura del Fondo vittime della strada è necessario accedere al sito della Consap.
Nella pagina dedicata al Fondo vittime della Strada è sufficiente linkare nella pagina dedicata alla procedura generare il modulo, compilarlo, sottoscriverlo e inviarlo, anche mezzo pec.
Leggi anche: Auto ferma: va sempre assicurata