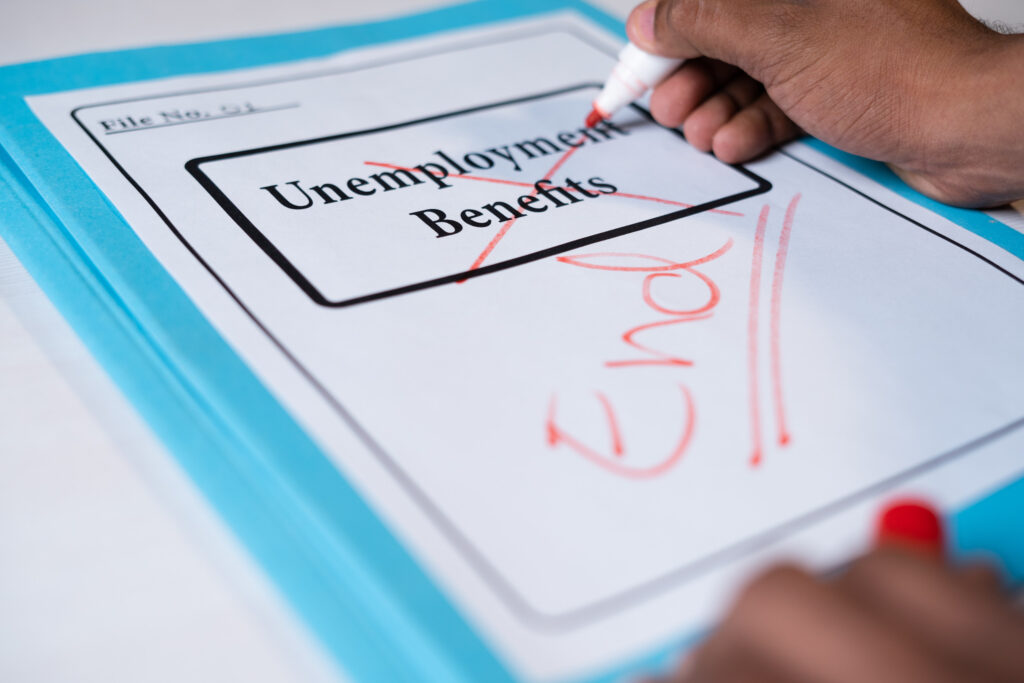Adescamento di minore e reati-fine: quale confine Come si atteggia il delitto di adescamento di minore previsto e punito dall’art. 609undecies c.p. rispetto ai reati-fine cui tende la condotta dell’agente?
Quesito con risposta a cura di Giulia Boursier Niutta e Tiziana Cassano
Il delitto di adescamento, di cui all’art. 609undecies c.p., è stato introdotto dalla L. 1° ottobre 2012, n. 172, recante la ratifica della Convenzione di Lanzarote, per accrescere la tutela del minore rispetto ai pericoli cui è esposto, in particolare sul web, e contiene una clausola di riserva “se il fatto non costituisce più grave reato”. Punisce infatti solo le condotte prodromiche a quelle previste dagli articoli da 600 a 600quinquies e dagli art. 609bis, 609quater, 609quinquies, 609octies c.p., sempre che non si sia verificato il reato fine. Il presupposto, pertanto, è che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine. Si tratta quindi di una tutela anticipata rispetto alla commissione del reato fine, sia pure allo stadio del tentativo, e non è ammesso il concorso formale tra i due reati, perché vi sarebbe un bis in idem (Cass. sez. VI, 23 gennaio 2025, n. 2787).
Avverso la sentenza di condanna pronunciata in secondo grado che riconosceva la responsabilità penale dell’imputato in ordine al delitto previsto e punito dall’art. 609undecies c.p., la difesa ricorreva per Cassazione, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo alla carenza dell’elemento soggettivo del reato di adescamento sotto il duplice profilo dell’assenza di prova dell’intenzione di commettere il reato-fine di atti sessuali con minorenne e della mancanza di prova della conoscenza o conoscibilità dell’età della persona offesa.
Dall’ipotesi accusatoria recepita dai giudici di merito, emergeva che l’imputato – venticinquenne – avesse adescato la persona offesa – dodicenne – su un social, carpendone la fiducia mediate la cessione delle credenziali di accesso alla piattaforma Netflix, finalizzata ad ottenere incontri sessuali. Inequivocabile appariva l’intento dal contenuto erotico delle conversazioni virtuali intrattenute, connotate da richieste ed inoltro da parte dell’imputato di materiale pornografico autoprodotto, nonché dalle bramose richieste di incontro in circostanze di intimità. Parimenti sconfessata appariva l’eccezione della difesa in ordine alla conoscibilità dell’età della persona offesa, atteso che quest’ultima denegava una richiesta d’incontro a causa della punizione impartita dai genitori.
Ebbene, la Suprema Corte adita – ritenendo il ricorso complessivamente infondato – ha trattato della fattispecie di adescamento di minore, analizzandone natura e funzione. Partendo dalla ratio legis della fattispecie in esame – rappresentata dalla necessità di tutelare i minori rispetto ai pericoli cui sono esposti, in particolare sul web, concepita al precipuo scopo di neutralizzare il rischio di commissione di reati più gravi – e dall’analisi della casistica nella quale si è costantemente ravvisato il tentativo del delitto di atti sessuali con minorenni, la Corte di legittimità ha evidenziato quanto segue. La disposizione di cui all’art. 609undecies c.p., integrando un reato di pericolo concreto, offre una tutela anticipata al bene giuridico che mira a proteggere (corretto sviluppo psicofisico del minore e sua autodeterminazione), criminalizzando condotte prodromiche rispetto a quelle previste dagli articoli da 600 a 600quinquies e dagli artt. 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies c.p., sempreché non si sia verificato il reato fine. Segnatamente, il delitto de quo si configura allorquando l’agente ponga in essere – attraverso artifici, lusinghe o minacce – atti volti a carpire la fiducia del minore, al fine di attrarre la persona offesa al proprio volere e addivenire al compimento del reato-fine. Affinché si configuri il delitto di cui all’art. 609undecies c.p. è, pertanto, necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine, cui si accede quando si passa a richieste insistenti o pressanti di ottenere materiale pornografico ovvero atti sessuali. Quanto detto fuga ogni dubbio in ordine alla tenuta costituzionale della norma rispetto al principio di offensività. Parimenti è a dirsi per quanto concerne la legittimità della norma rispetto ai principi di determinatezza e proporzionalità della pena, atteso che il vaglio sull’elemento soggettivo del reato – dolo specifico – e sulla materialità dello stesso è ancorato a parametri oggettivi dai quali possa dedursi il movente sessuale e che gli atti posti in essere dall’agente finalisticamente orientati alla commissione del reato fine sono sanzionati con una cornice edittale autonoma – equa, proporzionata e inferiore – rispetto a quella prevista per i delitti cui accede. Di qui, la compatibilità del sistema anche con il principio di rieducazione della pena.
(*Contributo in tema di “Il confine tra il delitto di adescamento di minore e i reati-fine che la norma mira a prevenire”, a cura di Giulia Boursier Niutta e Tiziana Cassano, estratto da Obiettivo Magistrato n. 84 / Aprile 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)