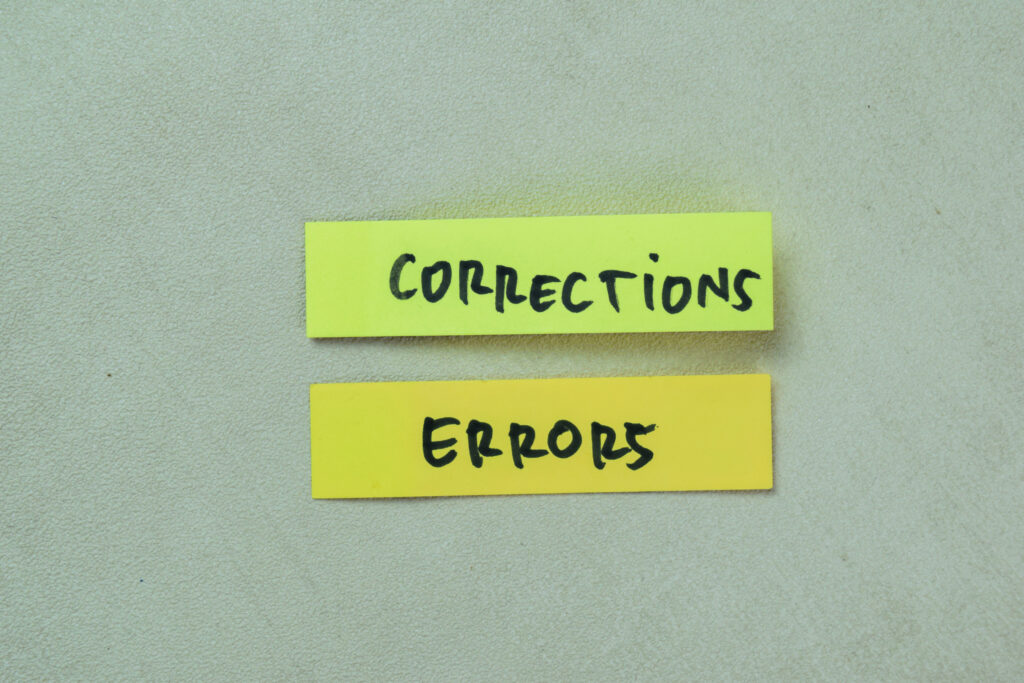Garanzia per i vizi Garanzia per i vizi della cosa venduta: definizione, normativa civilistica, effetti e termini per denuncia e azione
Garanzia per i vizi della cosa venduta: cos’è
Il codice civile italiano stabilisce una garanzia per vizi come obbligo fondamentale del venditore nel contratto di compravendita. Questa garanzia tutela il compratore nel caso in cui il bene acquistato presenti difetti che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano il valore.
Garanzia per i vizi: art. 1490 c.c.
L’articolo 1490 del Codice Civile sancisce infatti che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. Questi vizi possono essere di due tipi:
- quelli che impediscono al bene di essere utilizzabile per lo scopo previsto;
- quelli che, pur non compromettendone l’uso, ne riducono in maniera apprezzabile il valore.
La legge presume che un bene sia idoneo all’uso normale per cui è stato progettato. La presenza di difetti, anche non evidenti, rende il venditore inadempiente. La garanzia si basa sull’idea che il compratore ha diritto a ricevere un bene che rispetti le sue aspettative economiche e funzionali.
Garanzia e malafede del venditore
In alcune circostanze la garanzia può essere limitata o esclusa, con particolari eccezioni. L’articolo 1490, al comma 2, sancisce che un eventuale accordo finalizzato a escludere o a limitare la garanzia non ha effetto qualora il venditore abbia agito in malafede, cioè abbia intenzionalmente nascosto i vizi al compratore. La malafede, in questo contesto, richiede la prova che il venditore fosse a conoscenza dei difetti e li abbia taciuti. La semplice negligenza o l’ignoranza dovuta a disattenzione non sono sufficienti per annullare il patto di esclusione.
Casi di esclusione della garanzia
L’articolo 1491 del Codice civile specifica invece che la garanzia non è dovuta se, nel momento in cui le parti hanno stipulato il contratto, il compratore era già a conoscenza dei vizi o se, in ogni caso, erano facilmente riconoscibili con la normale diligenza, a meno che il venditore abbia specificamente dichiarato che il bene era esente da vizi.
Garanzia per i vizi: effetti
Se la garanzia è dovuta, l’articolo 1492 offre al compratore due opzioni principali.
- Risoluzione del contratto (azione redibitoria): il compratore può richiedere cioè l’annullamento della vendita. In questo caso, come stabilito dall’articolo 1493, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare tutte le spese legittimamente sostenute per l’acquisto (es. spese notarili, di registrazione). Il compratore, a sua volta, deve restituire il bene, a meno che non sia perito a causa dei vizi stessi. Se il bene è perito per caso fortuito o per colpa del compratore, o se è stato da lui alienato o trasformato, la risoluzione non è più possibile. In questi casi il compratore può chiedere solo la riduzione del prezzo.
- Riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris): il compratore può chiedere una riduzione del prezzo pagato, in modo da adeguarlo al valore reale del bene viziato.
La scelta tra risoluzione e riduzione è irrevocabile una volta che viene fatta la domanda giudiziale.
Risarcimento del danno
L’articolo 1494 prevede inoltre che il venditore è tenuto in ogni casoal risarcimento del danno, a meno che non riesca a dimostrare di aver ignorato i vizi senza sua colpa. Il venditore deve inoltre risarcire i danni che i vizi hanno causato al compratore o a terzi (es. lesioni personali o danni a beni).
Termini per la denuncia dei vizi e per l’azione
L’articolo 1495 sancisce precisi oneri procedurali per il compratore. Questi deve denunciare i vizi al venditore entro un termine di otto giorni dalla loro scoperta, a meno che non sia previsto un termine diverso per contratto o per legge. La mancata denuncia entro questo termine comporta la decadenza del diritto alla garanzia. Questo onere non è necessario se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha intenzionalmente nascosto. L’azione legale per far valere la garanzia invece si prescrive in un anno dalla consegna del bene. Un’eccezione a questo termine di prescrizione si ha quando il compratore viene citato in giudizio per l’esecuzione del contratto: in tal caso, può eccepire la garanzia, a condizione che i vizi siano stati denunciati entro otto giorni dalla scoperta e prima dello scadere dell’anno.
Leggi anche gli altri articoli dedicati al contratto di compravendita