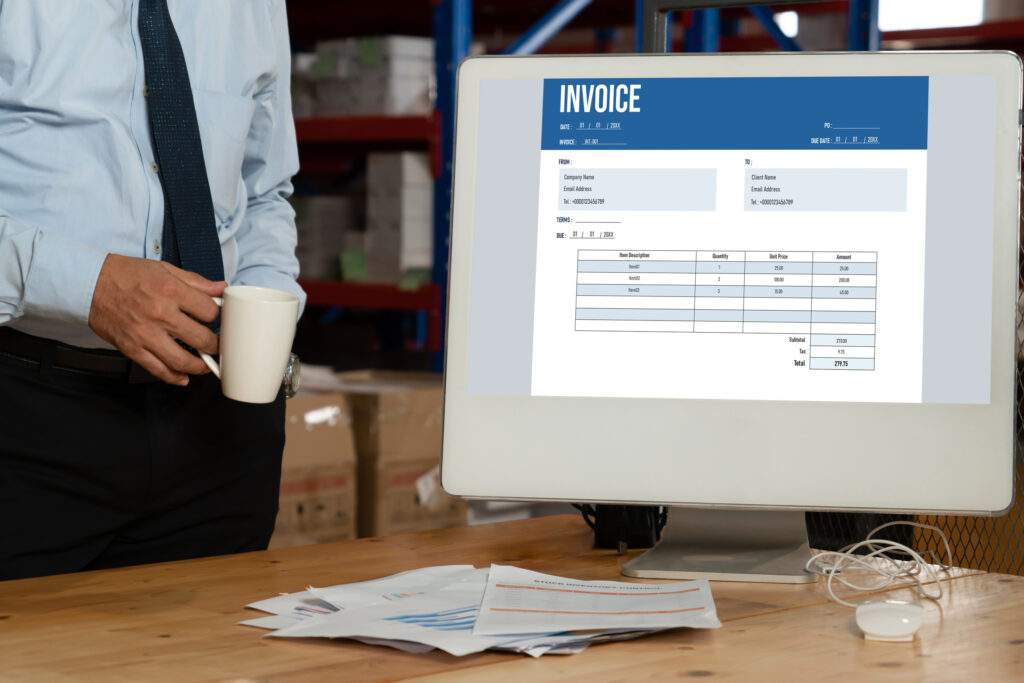Eredità devoluta a minori incapaci e accettazione con beneficio d’inventario L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consente al minore di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o tale facoltà gli è preclusa e il minore può solo redigere l’inventario nel termine di legge?
Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo
In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall’inventario, comporta per il minore l’acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all’eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310).
L’art. 471 c.c. prescrive che l’eredità a favore di minori o interdetti deve essere accettata con beneficio di inventario. La ratio della disciplina risiede nell’esigenza di tutelare i predetti soggetti dal rischio di depauperare il loro patrimonio a causa di debiti altrui. In questa prospettiva si giustifica la previsione della nullità della dichiarazione di accettazione dell’eredità pura e semplice da parte del legale rappresentante. Pertanto, all’accettazione dell’eredità mediante dichiarazione con forma scritta ad substantiam si pone come unica alternativa la rinuncia.
Ai sensi dell’art. 471 c.c. la redazione dell’inventario deve avvenire entro un anno dal conseguimento della maggiore età, quindi entro un termine ben più ampio di quello previsto a favore del chiamato all’eredità maggiorenne che, invece, deve procedere all’inventario entro tre mesi ai sensi dell’art. 485 c.c. La circostanza che l’esecuzione dell’inventario si realizzi a distanza di tempo dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad assumere posizioni discordanti sul rapporto accettazione-inventario.
Posto che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario esprime la volontà del chiamato di accettare l’eredità e che tale dichiarazione è irrevocabile, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale la dichiarazione è ex se idonea a far acquisire, ancorché in via provvisoria, il beneficio, i cui effetti si consolideranno una volta redatto l’inventario nei termini previsti. Si individua, in altri termini, in capo all’erede un onere di redigere l’inventario e in caso di mancato adempimento si decade dal beneficio (Cass., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2198; Cass., sez. II, 1° aprile 1995, n. 3842). Viceversa, un altro orientamento individua nell’accettazione con beneficio d’inventario una fattispecie a formazione progressiva, ove tanto la dichiarazione quanto l’esecuzione dell’inventario dell’eredità sono indispensabili per acquisire l’effetto della limitazione della responsabilità. La dichiarazione, infatti, ha una propria efficacia ma la limitazione delle responsabilità deriva dall’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477).
Tuttavia, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il chiamato all’eredità sia un minore una parte della giurisprudenza sostiene che una volta raggiunta la maggiore età l’erede possa rinunciare all’eredità, ritenendo inoperante la disciplina di cui all’art. 485 c.c. (Cass., sez. II, 6 dicembre 2016, n. 841; Cass., sez. II, 16 novembre 2018, n. 29665).
Secondo un opposto orientamento, invece, in caso di accettazione con beneficio di inventario da parte di un minore, una volta che questi raggiunge la maggiore età, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 489 c.c. In forza di questa disposizione il minore divenuto maggiorenne non può rinunciare all’eredità ma può solo procedere all’inventario la cui omissione comporta che egli sia considerato erede puro e semplice (Cass., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8832; Cass., sez. II, 5 giugno 2019, n. 15267).
Questo orientamento è stato condiviso anche dalla Cassazione a sezioni unite secondo cui l’accettazione, seppur beneficiata, è sempre accettazione dell’eredità ed esprime la volontà del chiamato a succedere nel patrimonio del defunto. Inoltre, la decadenza dal beneficio di inventario ex art. 489 c.c. fa si che il minore divenuto maggiorenne sia considerato erede puro e semplice. A ulteriore sostegno di questa conclusione la Cassazione invoca l’art. 320, comma 3, c.c. che prevede che l’accettazione dell’eredità del minore sia sottoposta all’autorizzazione del giudice tutelare e l’art. 484 c.c che prevede l’inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall’inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registi immobiliari.