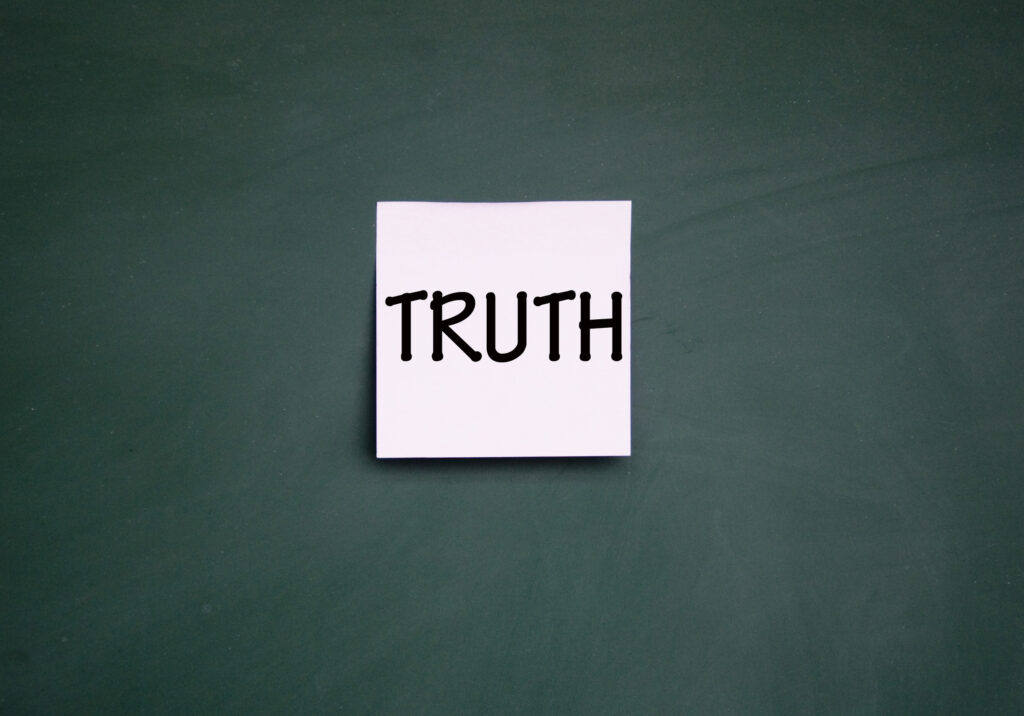Quesito con risposta a cura di Caterina D’Alessandro, Giulia Fanelli, Mariella Pascazio
Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione da parte del locatore di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c. (Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2025, n. 4892).
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite dalla questione dalla Terza Sezione Civile, sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale riguardante il diritto del locatore di conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno conseguente alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, in relazione ai casi in cui la restituzione del bene locato avvenga in data antecedente alla scadenza naturale del contratto. In particolare, ci si interroga se il locatore possa ottenere un risarcimento per i canoni non percepiti tra la riconsegna dell’immobile e la naturale scadenza del contratto o, se anteriore, fino alla stipula di una nuova locazione.
In assenza di una disposizione normativa volta a regolare la fattispecie, sussistevano sul punto due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Secondo un primo orientamento, prevalente seppur più risalente, risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore riconsegnato l’immobile al locatore, questi avrebbe avuto anche diritto al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuarsi nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore e il cui ammontare è riservato alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso concreto. (Cass. 5 gennaio 2023, n. 194; Cass. 5 maggio 2020, n. 8482; Cass. 13 febbraio 2015, n. 286; Cass. 3 settembre 2007, n. 18510 e Cass. 29 gennaio 1980, n. 676).
Secondo altro orientamento, recepito dalla sentenza di merito, il locatore, una volta rientrato nella materiale disponibilità dell’immobile, non avrebbe diritto ad ottenere alcun risarcimento correlato alla mancata percezione dei canoni, rappresentando i canoni il corrispettivo che il locatore percepisce per non potere godere direttamente dell’immobile. Invece, un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio può configurarsi se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione, commisurandosi in tal caso la perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 c.c. (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1426; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27614).
Con la pronuncia in esame, pur con alcune puntualizzazioni, le Sezioni Unite si sono espresse in favore del primo orientamento, rilevando che la diversa tesi che individua la causa della locazione nella preliminare rinuncia al godimento diretto non considera che non necessariamente in capo al locatore risiede un interesse al godimento diretto del proprio immobile, compensato dal canone.
Tale impostazione, secondo le Sezioni Unite, sarebbe riduttiva e non aderente alla realtà contrattuale della locazione, atteso che non terrebbe conto di tutte quei casi, diffusi nella pratica, in cui chi loca un bene intende utilizzarlo al solo fine di trarne delle rendite o realizzare profitti (es. società commerciale orientata a realizzare profitti attraverso l’acquisto sistematico di immobili da destinare con immediatezza al godimento di terzi dietro compensi).
La tesi secondo cui il rilascio dell’immobile locato a seguito di risoluzione per inadempimento del conduttore non sarebbe di per sé tale da integrare un danno trascura la mancata realizzazione del programma negoziale originariamente convenuto tra le parti.
Attraverso la conclusione di un contratto, le parti non si propongano affatto di ricomporre, come conseguenza della realizzazione della causa contrattuale, il medesimo equilibrio economico originario astrattamente considerato (sia pure in una diversa composizione materiale: una somma di danaro al posto di un periodo di godimento dell’immobile, e viceversa), bensì a raggiungere un diverso e più avanzato assetto economico-giuridico della propria sfera patrimoniale, rivisto attraverso il prisma delle proprie prospettive d’interesse.
La frustrazione che il locatore è costretto a subire per effetto dell’inadempimento del conduttore, in relazione al compimento del programma contrattuale originariamente convenuto (e, dunque, in relazione al forzato sacrificio degli interessi negoziati), non potrà in tal senso mai essere reintegrata, sul piano risarcitorio, dalla ricollocazione dello stesso locatore nella medesima condizione economico-patrimoniale precedente la conclusione del contratto.
Muovendo da queste premesse, le Sezioni Unite ritengono di dover dar seguito all’orientamento secondo il quale “il locatore, il quale abbia chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per l’anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore”.
Allo stesso tempo, deve essere escluso qualsiasi automatismo in ipotesi volto a identificare il danno del locatore nell’insieme dei canoni non percepiti. Non si deve confondere l’azione risarcitoria con l’azione di adempimento (solo grazie alla quale il locatore può esigere il mancato pagamento dei canoni convenuti fino alla scadenza del rapporto) e, dall’altro, occorre rammentare come l’operazione di liquidazione del danno si fondi necessariamente sulla preliminare distinzione fra danno-evento (qui coincidente con l’inadempimento e identificato dalla mancata percezione dei canoni di locazione concordati fino alla scadenza del contratto o al reperimento di un nuovo conduttore) e danno-conseguenza disciplinato dall’art. 1223 c.c., ai sensi del quale il “mancato guadagno” del locatore, in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento.
Tale nesso di “causalità giuridica” tra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (il carattere di derivazione immediata e diretta di queste ultime dal primo) costituisce materia di un onere probatorio (necessariamente) incombente sul locatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.; e tanto, a prescindere da quanto il conduttore potrà eventualmente opporre ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.
Da questa prospettiva, la circostanza dell’avvenuta restituzione anticipata dell’immobile da parte del conduttore inadempiente a seguito della risoluzione del contratto se, da un lato, non esclude di principio la risarcibilità delle possibili conseguenze dannose correlate alla mancata percezione dei canoni dovuti fino alla naturale scadenza del contratto (o alla conclusione di un’eventuale nuova locazione), dall’altro, non potrà non offrire al giudice del merito elementi utili (sul piano del ragionamento probatorio d’indole critica) ai fini della più corretta ricostruzione in fatto delle conseguenze dannose effettivamente ricollegabili al l’inadempimento, normalmente identificabili con la perdita dei canoni previsti fino alla naturale scadenza del contratto.
È in questo quadro che si colloca la giustificazione dell’attribuzione di un carattere ragionevolmente dirimente alla dimostrazione, da parte del locatore, d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione.
Le Sezioni Unite, infine, hanno anche escluso in tali ipotesi la possibilità di fare applicazione in via analogica della disciplina prevista dalla regola dettata dall’art. 1591 c.c. (“Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”), rimarcando che detta norma disciplina le sole conseguenze risarcitorie connesse al ritardo nella restituzione dell’immobile da parte del conduttore.
(*Contributo in tema di “Risoluzione del contratto e rilascio di immobile”, a cura di Caterina D’Alessandro, Giulia Fanelli e Mariella Pascazio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)