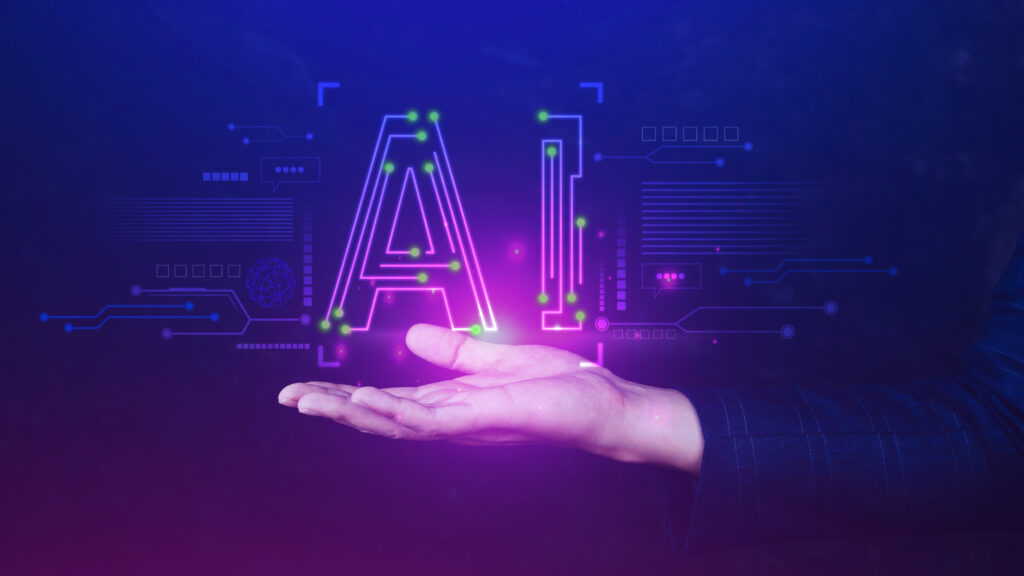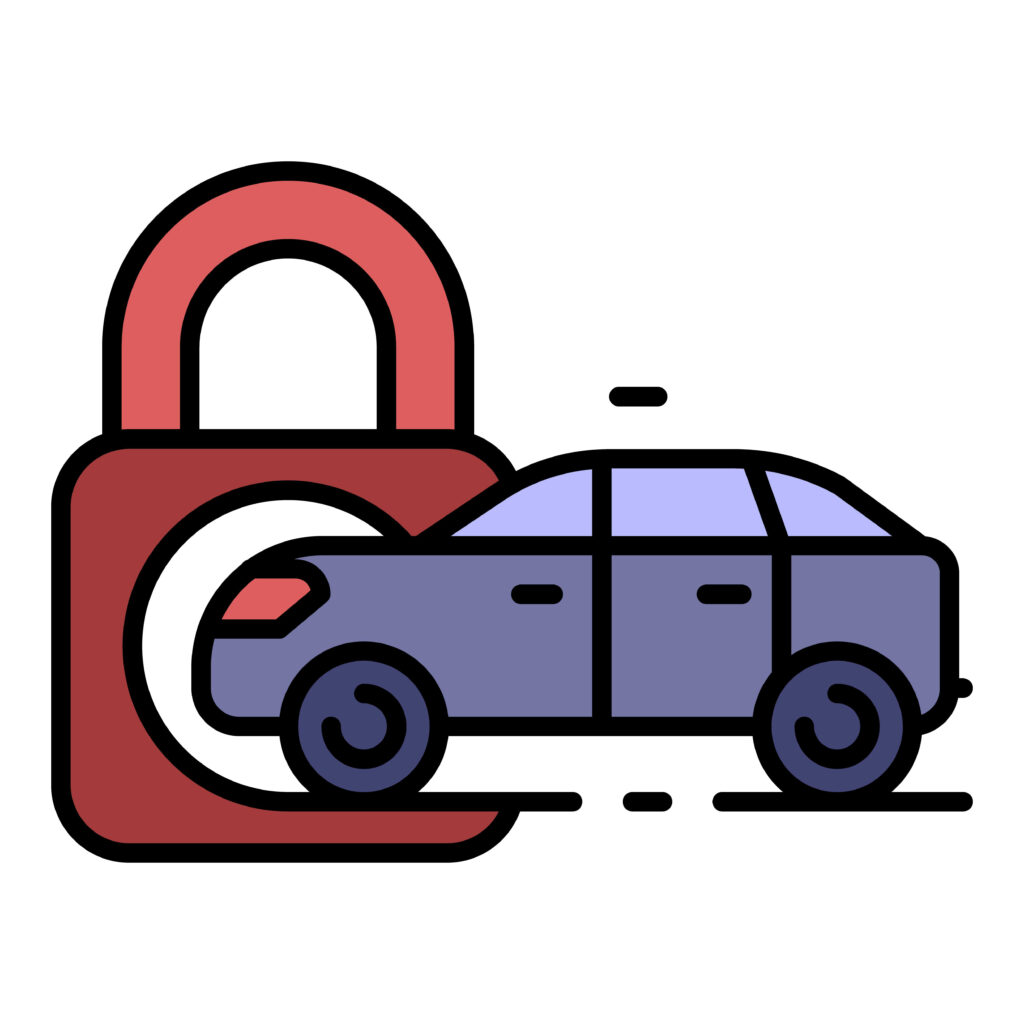Ddl Sicurezza: dall’UE l’invito a modificare il testo Ddl Sicurezza: il Commissario per i Diritti Umani Europeo invita i senatori a rivedere il testo, troppi limiti alla libertà di pensiero
Ddl Sicurezza: l’invito dell’UE
Il Ddl Sicurezza continua a sollevare polemiche e opposizioni, con rilievi significativi provenienti dal Consiglio d’Europa e dalla politica italiana. Michael O’Flaherty, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, ha espresso preoccupazioni in una lettera indirizzata al Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
O’Flaherty sottolinea come diversi articoli del Ddl limitino il diritto alla manifestazione e alla libertà di espressione ed esorta i senatori a modificare profondamente il testo prima di procedere all’approvazione.
Leggi anche Decreto sicurezza 2024: cosa prevede
Le disposizioni sotto accusa del Ddl Sicurezza
Gli articoli contestati includono:
- Articolo 11: introduce un’aggravante per reati commessi vicino a infrastrutture ferroviarie.
- Articolo 13: estende il Daspo urbano e amplia l’arresto in flagranza differita.
- Articolo 14: trasforma in reato penale il blocco stradale o ferroviario attuato con il corpo.
- Articolo 24: aggrava le pene per imbrattamento di beni pubblici, con reclusione fino a tre anni in caso di recidiva.
- Articolo 26: introduce un’aggravante per istigazione a disobbedire alle leggi e nuovi reati per disordini in carceri e centri di accoglienza.
- Articolo 27: colpisce le proteste violente di stranieri irregolari nei centri di trattenimento.
Secondo il Consiglio d’Europa, queste norme, formulate in termini vaghi, potrebbero portare a un’applicazione arbitraria, minando il legittimo esercizio dei diritti fondamentali.
La risposta istituzionale e le reazioni
La Russa ha trasmesso la lettera alle commissioni competenti. La sua reazione pubblica ha definito l’intervento di O’Flaherty come un’ingerenza inaccettabile. Intanto, le opposizioni si sono schierate contro il Ddl, con oltre 1.500 emendamenti presentati e manifestazioni che hanno visto migliaia di partecipanti. La Rete nazionale “No Ddl Sicurezza” annuncia ulteriori proteste.
Ddl sicurezza: un percorso accidentato
Il Ddl, composto da 38 articoli, è stato approvato alla Camera nel settembre 2023, ma incontra difficoltà al Senato. Restano da discutere i due terzi del testo, comprese norme controverse come il divieto di vendere SIM ai migranti senza permesso di soggiorno e lo stop al rinvio della pena per madri con figli minori. Segnalazioni critiche sono giunte anche dal Quirinale, rendendo necessario un rinvio della discussione a gennaio 2025.
Il Ddl Sicurezza rappresenta un banco di prova per il Governo, che cerca di bilanciare misure restrittive e rispetto dei diritti fondamentali. Le pressioni del Consiglio d’Europa e le critiche interne rendono indispensabile una revisione del testo per garantire la conformità agli standard democratici e costituzionali.
Leggi anche: Cannabis light: il ddl sicurezza la vieta