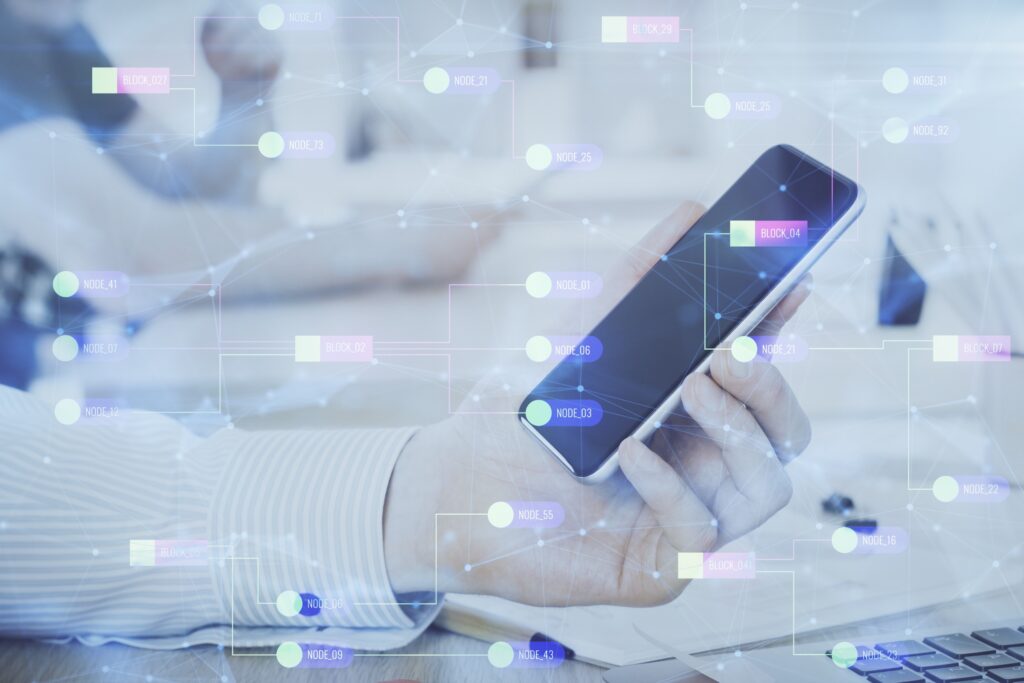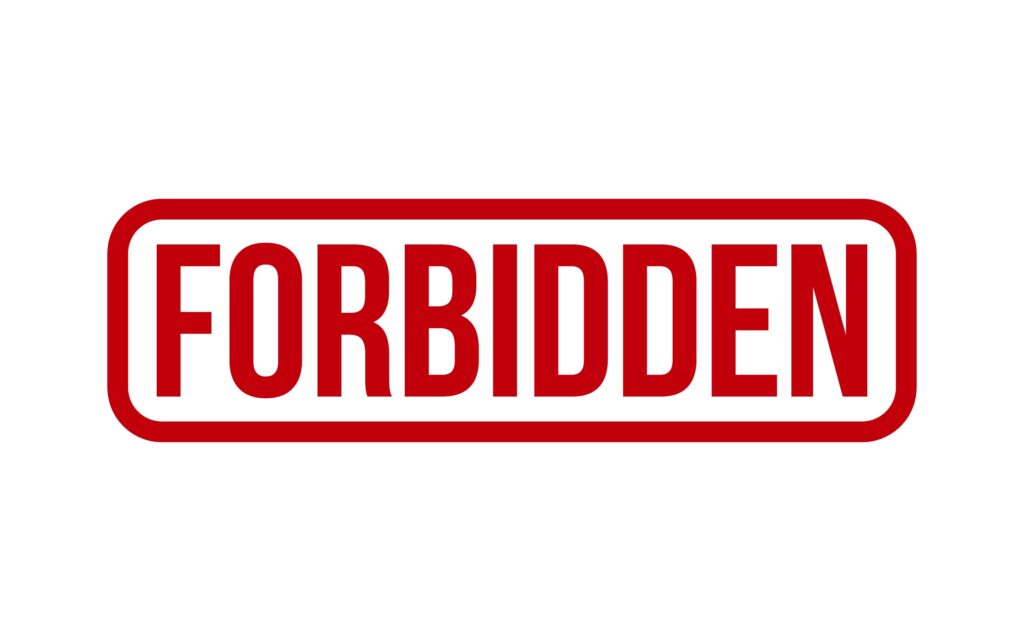Illecito deontologico divulgare i nomi dei clienti Illecito deontologico diffondere nomi di clienti e parti assistite sul sito dello studio legale e nelle mail inviate con la newsletter
Illecito deontologico avvocato
Costituisce illecito deontologico la divulgazione dei nominativi dei clienti e delle parti assistite, anche dopo che il decreto Bersani ha abrogato le disposizioni che impedivano ai liberi professionisti di farsi pubblicità. E’ quindi vietato nelle informazioni rivolte al pubblico, come quelle pubblicate su un sito o inviate per mezzo di una newsletter, indicare i nominativi di clienti e parti assistite. L’avvocato deve infatti garantire la riservatezza del cliente. Questa condotta è espressione del decoro e della dignità della funzione sociale della professione forense. Lo ha chiaro il CNF nella sentenza n. 294/2024.
Nomi dei clienti e delle parti assistite su sito e mail
Nel gennaio e febbraio 2022, un avvocato pubblica sul sito del proprio studio legale e invia per mezzo della newsletter informazioni riguardanti operazioni seguite dal proprio studio. Nei comunicati vengono citati i nomi di clienti e dettagli delle operazioni. Un esposto anonimo inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Trento avvia il procedimento disciplinare nei suoi confronti contestandogli la violazione dell’art. 35 del Codice deontologico.
L’avvocato si difende sostenendo che le informazioni erano già di pubblico dominio, essendo state pubblicate da altri soggetti con il consenso delle parti coinvolte. Argomenta inoltre che l’art. 35, comma 8 è in realtà una specificazione del più generale dovere di riservatezza e non si applica a notizie già pubbliche.
Il CDD ritiene però sussistente la violazione dell’art. 35, comma 8 del CDF, che vieta agli avvocati di includere nelle informazioni al pubblico i nomi di clienti e assistiti. L’avvocato viene così sanzionato con l’avvertimento. Il divieto previsto dalla regola deontologica mira a proteggere la riservatezza, indipendentemente dalla precedente pubblicità dei dati.
Informazioni legittime se già pubblicate da terzi
L’avvocato presenta ricorso al CNF sostenendo la legittimità della divulgazione delle informazioni perché già pubblicate da terzi. Il ricorrente richiama inoltre la libertà di informazione professionale sancita dall’art. 17 del CDF, che consente la promozione dell’attività legale nel rispetto di trasparenza, correttezza e verità.
Illecito deontologico anche con consenso clienti
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) però respinge il ricorso dell’avvocato ricorrente, confermando la violazione dell’art. 35, comma 8 del Codice Deontologico Forense (NCDF). La norma vieta agli avvocati di pubblicizzare il nome dei propri clienti, anche se questi consentono. Prima del verdetto finale il CNF ci tiene ad esporre alcune considerazioni preliminari.
- Il divieto esiste dal primo Codice Deontologico del 1997. Nonostante le successive riforme (Decreto Bersani 2006, Legge 247/2012, NCDF del 2014), il comma 8 è rimasto invariato, confermando obbligatorietà del divieto.
- I moderni strumenti di comunicazione permettono agli avvocati di diffondere contenuti promozionali attraverso piattaforme non tradizionali, spesso a pagamento. Questo rischia di eludere il divieto, sfruttando canali non qualificati.
- La pubblicazione contestata non si limita a informare, ma presenta anche contenuti promozionali. Lo scopo va oltre la semplice comunicazione.
L’avvocato ricorrente ha pubblicato sul sito web dello studio e inviato email tramite la newsletter contenenti il nome dei clienti assistiti. Lo stesso ha infatti riferito di aver assistito il Consorzio [AAA] in un leverage buyout e ha menzionato l’assistenza fornita ad altri clienti in concordati preventivi.
La comunicazione quindi non si è limitata a riprodurre articoli già pubblici. Ha invece avuto contenuti redatti ad hoc, con accenti promozionali e autocelebrativi, comportamento che integra pienamente la violazione dell’art. 35 NCDF.
Il CNF precisa che la norma tutela riservatezza, decoro e dignità della professione. La valenza pubblicistica dell’attività forense impone autonomia e prudenza nella comunicazione. Il consenso del cliente o la diffusione precedente tramite terzi non escludono il divieto. Il ricorso viene quindi respinto e la sanzione dell’avvertimento confermata.
Leggi anche: “Faccia di bronzo” alla controparte: avvocato sanzionato