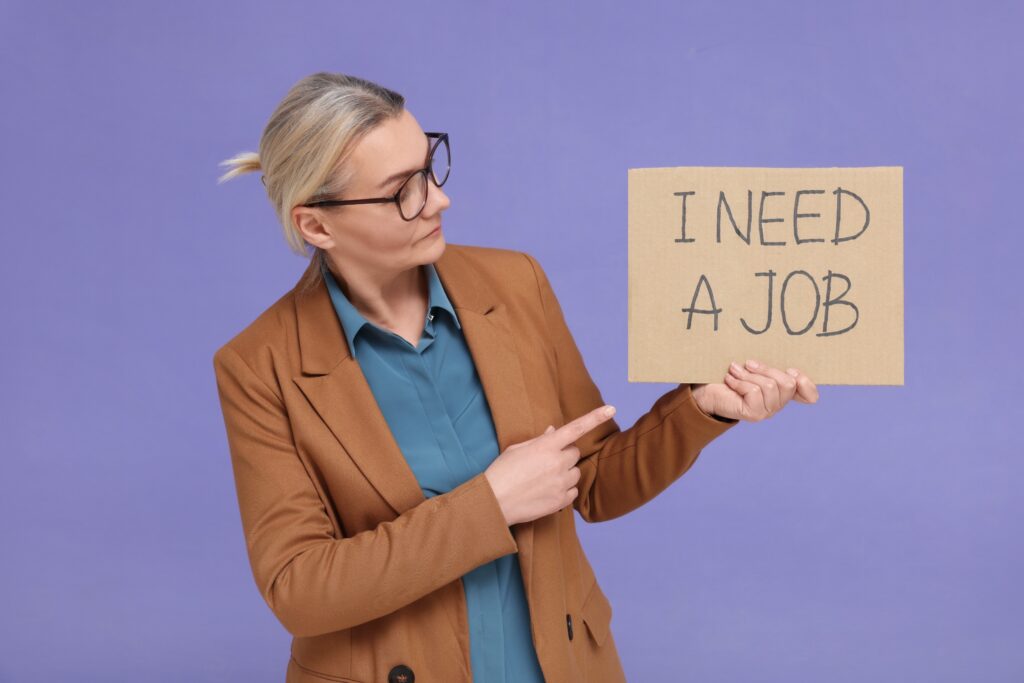Pacchetto giustizia 2025: contributo unificato in primo piano Pacchetto giustizia 2025: divieto di iscrizione cause civili se non si paga il contributo unificato, sanzionati atti e documenti “pesanti”
Pacchetto giustizia 2025: novità nella manovra 2025
Il pacchetto giustizia della manovra 2025 prevede poche misure di rilievo e incentrate soprattutto sugli adempimenti fiscali collegati ai processi.
Vediamo quelle di maggiore interesse.
Contributo unificato: quali novità?
Le modifiche introdotte dal comma 812 aggiornano il decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e mirano a ottimizzare la gestione del contributo unificato nei procedimenti civili. Si stabilisce in particolare che una causa civile può essere iscritta a ruolo solo dopo il versamento minimo previsto per il contributo unificato.
Leggi anche Processo estinto se non si paga il contributo unificato
Si attribuisce a Equitalia Giustizia S.p.A., in presenza di specifica convenzione, il compito di avviare il recupero immediato in caso di mancato pagamento, comprendendo interessi e sanzioni. Queste misure riducono i rischi di insolvenza, semplificano i procedimenti e velocizzano la riscossione, eliminando passaggi burocratici inutili.
Il comma 813 introduce invece nell’ambito del processo amministrativo, una sanzione pecuniaria decisa dal giudice, per atti processuali che superano i limiti dimensionali previsti, che può arrivare fino al doppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Il comma 814 aumenta invece il contributo unificato per le controversie sulla cittadinanza italiana, portandolo da 518 a 600 euro per ciascun ricorrente. Questa modifica interessa procedimenti civili semplificati e punta a incrementare il gettito erariale, pur non quantificabile con precisione.
Queste innovazioni mirano a rendere i procedimenti più efficienti e ad assicurare un miglior recupero delle somme dovute, migliorando l’equilibrio tra semplificazione amministrativa e tutela delle finanze pubbliche.
Copie di atti e documenti
La norma contenuta nel comma 815 aggiorna le modalità di rilascio di copie di atti e documenti in formato non cartaceo, armonizzandole con il sistema telematico. Si interviene sul DPR 115/2002, estendendo l’esonero dal pagamento dei diritti di copia non autenticata per difensori e parti private che scaricano direttamente dal portale telematico senza assistenza del personale.
Viene introdotto l’articolo 269-bis, che impone il versamento di un diritto forfettizzato nella misura indicata nella tabella di cui all’allegato 8 per la trasmissione di duplicati o copie informatiche di atti e decrementi del procedimento penale da parte della segreteria o della cancelleria.
La norma in questo modo migliora l’efficienza processuale e incrementa le entrate erariali. Si eliminano supporti obsoleti come CD e cassette.
Pacchetto giustizia 2025: le altre misure
Il comma 816 estende l’inviolabilità dei fondi destinati “a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi” al pagamento di tasse e tributi, per evitare esecuzioni forzate che generano costi aggiuntivi per l’amministrazione.
Il comma 817 rivede invece le procedure di pagamento per l’equa riparazione per processi irragionevolmente lunghi. Si introduce la trasmissione telematica obbligatoria delle istanze e documentazioni. I termini di validità delle dichiarazioni passano da sei mesi a due anni, e gli interessi sulle somme tardive non decorrono. È previsto un piano per smaltire l’arretrato dei pagamenti entro il 2026, riducendo contenziosi e interessi passivi.
Il comma 819 stabilisce che il Ministero della Giustizia, per ridurre i ritardi nei pagamenti connessi ai ricorsi per la durata irragionevole dei processi (legge n. 89/2001), collabori con l’Associazione Formez PA nel biennio 2025-2026. Formez PA supporterà l’organizzazione delle fasi di pagamento, migliorando l’efficienza e affrontando le criticità sollevate dalla procedura di infrazione europea sui ritardi di pagamento. Questa misura rientra nella riforma del PNRR per accelerare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
Collaborazione che è già iniziata grazie al progetto “PintoPaga”.
II comma 821 prevede che il Ministero della Giustizia monitori e valuti l’efficienza delle procedure di pagamento tramite dati telematici. L’obiettivo è verificare la validità delle richieste e migliorare la gestione delle risorse destinate agli indennizzi. L’amministrazione liquiderà i pagamenti solo in presenza di documentazione completa e correttamente trasmessa, ottimizzando l’utilizzo delle somme stanziate per i risarcimenti.
Leggi anche: Legge bilancio 2025: cosa prevede