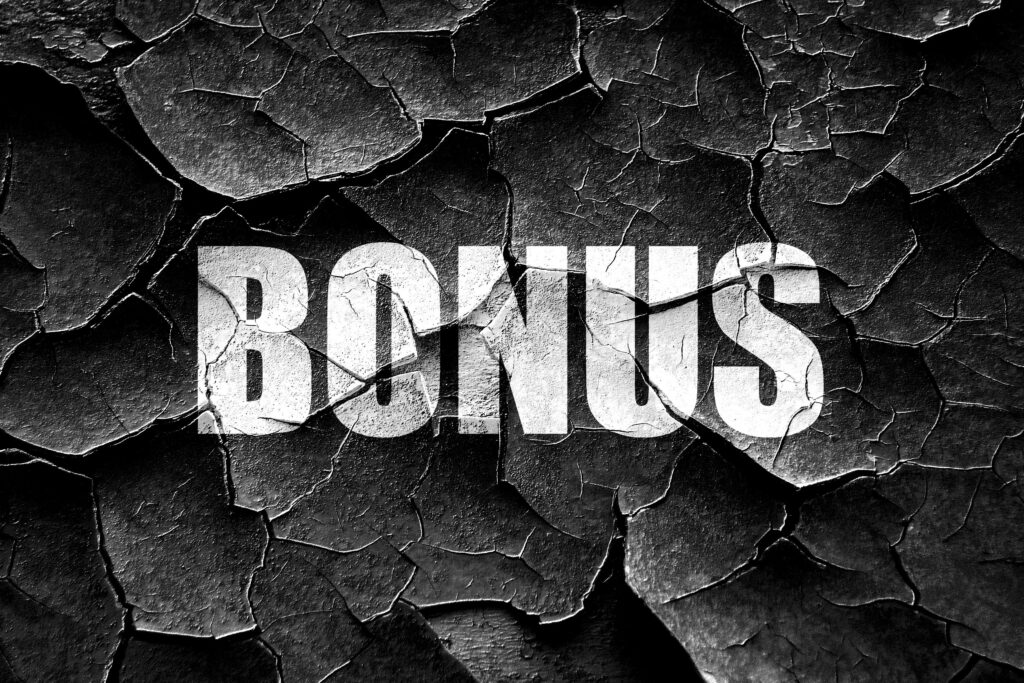Quesito con risposta a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin
La ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca. Il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo. – Cass., sez. I, 26 febbraio 2024, n. 5064.
La pronuncia della Suprema Corte trae origine dall’iniziativa giudiziaria di una società nei confronti della banca presso la quale aveva acceso un rapporto di conto corrente fin dall’anno 1981. La correntista chiedeva la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dall’istituto di credito a titolo di interessi anatocistici. La banca eccepiva la prescrizione in relazione agli addebiti aventi natura di rimesse solutorie effettuati sul conto in data anteriore al decennio dalla notifica della citazione. Il Tribunale rigettava l’eccezione della banca ritenendo che la stessa non avesse indicato le rimesse solutorie e accoglieva la domanda dell’attrice provvedendo alla rideterminazione del saldo in seguito ad una c.t.u. contabile.
La decisione veniva riformata dal giudice del gravame sul presupposto che incombesse sulla correntista produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto.
Secondo la Corte di Appello solo attraverso l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti si sarebbe potuti pervenire alla determinazione dell’eventuale credito della correntista e alla quantificazione degli importi da espungere, non essendo sufficienti a tale fine gli estratti conto scalari in quanto rappresentativi dei soli conteggi degli interessi attivi e passivi, senza possibilità di individuare le operazioni alla base delle annotazioni degli interessi e dei movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato.
La società ha così proposto ricorso in Cassazione lamentando in prima battuta l’erronea statuizione riguardo la ripartizione degli oneri probatori con riferimento all’eccezione di prescrizione considerando che l’onere probatorio di un fatto estintivo incombe sul soggetto che lo eccepisce.
Secondariamente si è censurata l’erronea valutazione dei fatti costituivi posti a fondamento della domanda, posto che la ragione della produzione degli estratti conto scalari con riferimento ad un limitato periodo di tempo del conto corrente dipendeva dalla domanda, limitata a quell’intervallo temporale, con esplicita rinuncia a qualsiasi contestazione quanto ai periodi per i quali non vi era documentazione contabile. Si aggiungeva, altresì, l’assenza di una motivazione per il mancato accoglimento delle risultanze espresse nella consulenza tecnica.
In ultimo, veniva contestata la natura migliorativa della capitalizzazione degli interessi introdotta dalla delibera del Cicr del 9 febbraio del 2000 rispetto alla clausola anatocistica precedentemente applicata.
La Suprema Corte, nella decisione de qua, accogliendo il ricorso, ricorda preliminarmente come in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte anteriore (così anche Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895 – termine di prescrizione estintiva).
Tuttavia, ricorda la Corte che il principio opera solo sul versante dell’onere di allegazione ammettendo una simmetria, in quanto così come il correntista può limitarsi a indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione previa verifica del saldo del conto, anche la banca può a sua volta limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore per il tempo necessario alla prescrizione.
Ciò posto, il problema delle rimesse solutorie si sposta sul piano dell’onere probatorio per cui all’allegazione consegue la prova della parte su cui, per legge, incombe il relativo onere, anche facendo luogo a una c.t.u., cosicché le relative risultanze probatorie vengano valutate dal giudice.
A tal riguardo, la Corte di Appello aveva disatteso le risultanze della consulenza tecnica sul presupposto di una non idonea documentazione in grado di evidenziare l’esistenza di rimesse con funzione solutoria, sostenendo come il conto corrente era contraddistinto dalla mancanza di affidamenti e ricavandone la funzione solutoria per tutte le rimesse, salvo prova contraria della correntista.
Tale motivazione viene ritenuta affetta da un’incongruenza logica in quanto, nel caso in cui un cliente citi in giudizio l’istituto di credito domandando la ripetizione di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici, relativamente ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca. Questo si rende necessario ai fini della decorrenza del dies a quo della prescrizione, termine che inizia a decorrere per quella parte delle rimesse sul conto corrente la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo” (termine di prescrizione per l’azione di ripetizione).
Spostandosi sul versante dell’onere probatorio a carico della correntista censurato dalla Corte di Appello, la Cassazione afferma che una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi anatocistici a carico della stessa, occorre distinguere il caso in cui essa è convenuta da quella in cui sia attrice. In quest’ultimo caso, invero, l’accertamento del dare e dell’avere può aversi tramite l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete tese a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, in quanto l’estratto è un documento formato e proveniente dalla banca.
Da ciò deriva che è possibile ricostruire l’effettività del saldo finale partendo dai documenti esibiti dal correntista e provenienti dalla banca, anche tramite elaborazioni tecniche dei dati risultanti dai riassunti scalari così come anche statuito da Cass., sez. I, 18 aprile 2023, n. 10293.
Nel caso in esame, essendo il correntista ad agire in giudizio per la rideterminazione del saldo e la correlata ripetizione delle somme indebitamente considerate, ed avendo egli prodotto il primo degli estratti conto scalari con un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni o diano giustificazione di un saldo diverso nel periodo di riferimento per effetto della eliminazione delle voci o delle competenze illegittimamente applicate fino a quel momento. In tal modo, la base di calcolo può essere determinata proprio sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, dato che questo costituisce un documento redatto dalla controparte in funzione riassuntiva delle movimentazioni del conto corrente, e rimane, nel quadro delle risultanze di causa, il dato più sfavorevole alla stessa parte attrice.
Su tali assunti, la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello, la quale dovrà uniformarsi ai principi esposti.
*Contributo in tema di “ termine di prescrizione per l’azione di ripetizione ”, a cura di Beatrice Parente ed Elisa Visintin, estratto da Obiettivo Magistrato n. 73 / Aprile 2024 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica