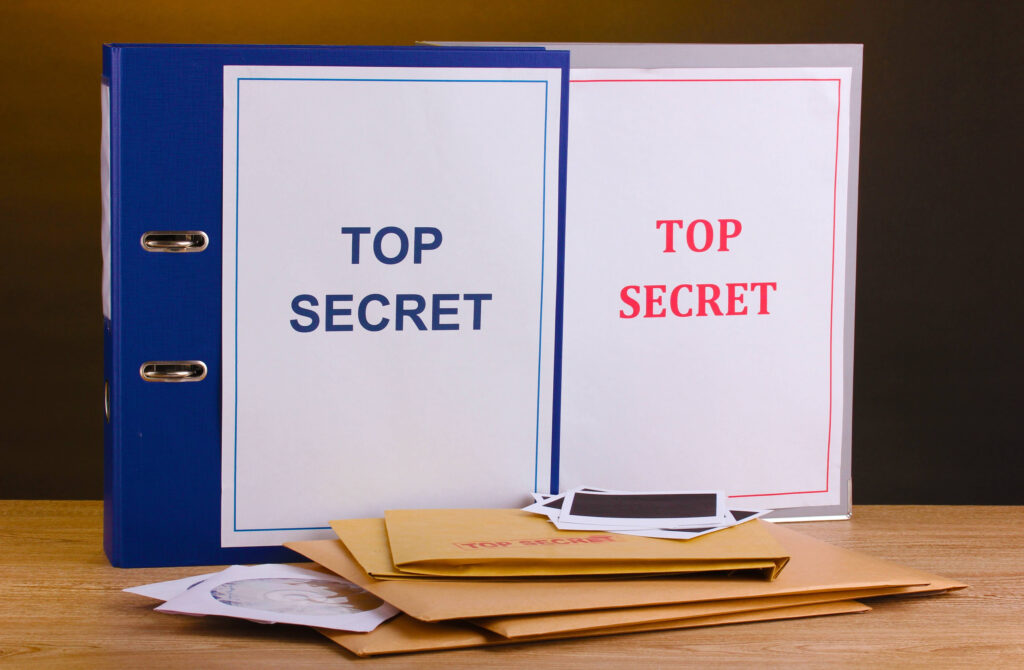Quesito con risposta a cura di Caterina D’Alessandro, Giulia Fanelli e Mariella Pascazio
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, comma 1, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2025, n. 1898).
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite dalla questione dalla Terza Sezione Civile, sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale riguardante la natura generica o specifica del dolo del debitore richiesto dall’art. 2901, comma 1, c.c. ai fini della revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale anteriori al sorgere del credito.
Sul punto, infatti, coesistevano nella giurisprudenza di legittimità di due diversi orientamenti, che individuavano il consilium fraudis rispettivamente nella dolosa preordinazione dell’atto alla compromissione del soddisfacimento del credito e nella mera previsione del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori.
Secondo le Sezioni Unite, ai fini della risoluzione della questione posta dall’ordinanza interlocutoria, occorre muovere dalla lettura del testo dell’art. 2901, comma 1, c.c., il quale subordina la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore in pregiudizio alle ragioni del creditore alle seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
La tesi del dolo generico attribuisce portata non decisiva alla differente formulazione delle due parti di cui si compone il n. 1 della norma in esame, osservando che la stessa non richiede, ai fini della configurabilità della dolosa preordinazione, che il debitore abbia agito con la specifica intenzione di danneggiare i creditori, ma solo che abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicarne le ragioni, ed escludendo quindi, in entrambe le ipotesi da essa contemplate, la necessità sia dell’animus nocendi, ovverosia di “una callida volontà dell’obbligato di danneggiare il creditore”, sia, nel caso di atto a titolo oneroso, della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito di cui l’atto dispositivo è volto a pregiudicare la soddisfazione.
In realtà, la mera considerazione del significato letterale delle espressioni utilizzate nell’art. 2901, comma 1, c.c. risulta di per sé sufficiente ad evidenziare l’intento del legislatore di subordinare l’accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda: mentre il verbo “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto direttamente o indirettamente esperienza o per averla appresa da altri, il sostantivo “preordinazione” fa riferimento alla predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato.
La seconda espressione implica, pertanto, una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nell’aggiunta dell’aggettivo “dolosa”, che allude al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell’azione, indirizzata ad impedire od ostacolare l’azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito; tale finalizzazione è del tutto assente nella prima espressione, che fa invece riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l’atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso.
L’utilizzazione di due espressioni aventi un significato completamente differente nell’ambito della medesima disposizione appare tutt’altro che casuale, se solo si tiene conto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi, proprio con riguardo all’azione revocatoria, precedentemente all’entrata in vigore del Codice civile del 1942.
Nel Codice civile del 1865, la medesima azione era infatti disciplinata dall’art. 1235, il quale, oltre a prevedere (almeno secondo l’opinione prevalente) soltanto la revocabilità degli atti dispositivi posti in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, la subordinava alla condizione che gli stessi fossero stati “fatti in frode” delle ragioni dei creditori.
Il significato di tale espressione era controverso, ritenendosi da parte di alcuni autori che con la stessa il legislatore avesse inteso fare riferimento all’intenzione di recare danno ai creditori (c.d. animus nocendi), e da parte di altri che avesse voluto invece richiedere, ai fini dell’accoglimento della domanda, la mera coscienza del pregiudizio arrecato ai creditori, attraverso la creazione o l’aggravamento di una situazione d’insolvibilità (c.d. scientia damni). Alla fine prevalse la seconda tesi, in virtù della considerazione che l’individuazione del presupposto soggettivo della revocatoria nell’animus nocendi avrebbe comportato un eccessivo restringimento dei limiti di operatività dell’azione, impedendo alla stessa di svolgere efficacemente la propria funzione di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Tale indirizzo trovò accoglimento anche in sede di redazione del Codice vigente, il quale, tuttavia, ha ampliato l’ambito applicativo dell’azione, ammettendone l’esercizio anche nei confronti degli atti dispositivi posti in essere anteriormente al sorgere del credito, ma differenziandone il presupposto soggettivo da quello richiesto ai fini della revocatoria degli atti posti in essere successivamente, nel senso che, mentre per la dichiarazione d’inefficacia di questi ultimi è necessaria soltanto la prova della “conoscenza del pregiudizio” arrecato alle ragioni dei creditori, per quella dei primi occorre la prova della “dolosa preordinazione” al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito. In quanto adottata nella piena consapevolezza dei contrasti insorti in ordine all’interpretazione della disciplina previgente, la formulazione letterale dell’art. 2901, comma 1, c.c. non può dar luogo ad equivoci, testimoniando chiaramente la volontà del legislatore di regolare in maniera diversa il profilo soggettivo delle due fattispecie da esso contemplate, attraverso l’introduzione di una disciplina più restrittiva per la revocatoria degli atti compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito: diversamente, infatti, la norma si sarebbe limitata a chiarire che l’azione era proponibile anche contro gli atti dispositivi compiuti in epoca anteriore al sorgere del credito, richiedendo per entrambe le ipotesi la prova della consapevolezza da parte del debitore della dell’incidenza dell’atto sulla consistenza quantitativa o qualitativa del proprio patrimonio, e quindi sulla garanzia generica dei creditori, senza fare alcun riferimento alla necessità di un disegno fraudolento, volto a sottrarre il bene alienato o vincolato all’azione esecutiva del creditore o a rendere più difficile il soddisfacimento del suo credito.
La differenza esistente tra la pura e semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e la volontà di danneggiarli mediante il compimento dell’atto dispositivo era stata d’altronde già colta dalla dottrina in epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice civile del 1942, anche se ne era stata sminuita la portata concreta: premesso infatti che il consilium fraudis presuppone ad un tempo la rappresentazione dell’effetto dannoso dell’atto e la volontà di porlo ugualmente in essere, si era osservato che nella gestione del proprio patrimonio il debitore non tiene normalmente conto dell’interesse del creditore, ma agisce come se lo stesso non esistesse, e si era pertanto concluso che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della revocatoria, non era necessaria una specifica intenzione di danneggiare il creditore o determinati creditori, ma era sufficiente la coscienza, da parte del debitore, di determinare o accrescere la propria insolvenza, attraverso il compimento dell’atto dispositivo, mettendo quindi il proprio patrimonio in condizione di non poter offrire ai creditori la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte .
La necessità di un quid pluris, sotto il profilo soggettivo, era invece emersa in giurisprudenza, proprio nell’ambito di un orientamento volto a ricondurre nell’ambito applicativo dell’azione revocatoria anche gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito: nel dichiarare ammissibile la domanda proposta dal primo acquirente di un immobile a tutela del credito risarcitorio vantato nei confronti del venditore, il quale aveva successivamente alienato il medesimo bene ad un terzo, che aveva reso inattaccabile il proprio acquisto mediante la tempestiva trascrizione, la giurisprudenza di legittimità aveva infatti ritenuto che l’azione potesse essere esercitata anche nel caso in cui l’atto anteriore alla frode fosse stato compiuto “con l’obliquo intento di rendere vano il credito che stava per sorgere”, non essendovi ragione di negare tutela al soggetto rimasto danneggiato da questo più raffinato consilium fraudis. (cfr. Cass., Sez. Un., 22 dicembre 1930, n. 3669).
Al di là dei profili collegati all’interpretazione letterale e storico-sistematica della norma in esame, la scelta tra l’una e l’altra tesi impone peraltro d’interrogarsi anche in ordine alle conseguenze che l’accoglimento di una concezione più o meno restrittiva del consilium fraudis può produrre nei rapporti tra le parti dell’obbligazione ed in quelli con i terzi che siano entrati in contatto con le stesse, nonché, più in generale, sul piano della certezza e della rapidità dei traffici giuridici.
L’identificazione dell’elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato i creditori comporta, infatti, un’indubbia dilatazione dei margini di operatività dell’istituto, già alquanto estesi per effetto dell’opinione comune, che ritiene configurabile il presupposto dell’eventus damni non solo in presenza di una compromissione totale della consistenza del patrimonio del debitore, ma anche a fronte di una variazione quantitativa o qualitativa dello stesso tale da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
Tale dilatazione, che si traduce naturalmente in un rafforzamento della tutela dei diritti dei creditori, si pone, tuttavia, in contrasto con la natura eccezionale che l’azione revocatoria viene ad assumere nell’ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito: in quanto avente la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi su beni che hanno cessato di far parte del patrimonio del debitore prima dell’insorgenza dell’obbligazione, essa costituisce una deroga al principio generale, sancito dall’art. 2740, comma 1, c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento “con tutti suoi beni presenti e futuri”, cioè con quelli esistenti nel suo patrimonio alla data in cui è sorta l’obbligazione e con quelli che abbia acquistato in epoca successiva, e non anche con quelli di cui alla predetta data avesse già cessato di essere titolare.
Questa esclusione trova giustificazione nella considerazione che, nel momento in cui entra in contatto con il debitore, il creditore è perfettamente in grado di rendersi conto dell’attuale consistenza e composizione del suo patrimonio, nonché di apprezzarne l’idoneità a garantire il soddisfacimento del credito in caso d’inadempimento: può quindi ritenersi ragionevole che l’esercizio dell’azione revocatoria resti limitato all’ipotesi, avente carattere ordinario, in cui il debitore abbia disposto dei propri beni in epoca successiva, nella consapevolezza del pregiudizio in tal modo arrecato al creditore, nonché a quella, eccezionale, in cui l’atto dispositivo, pur essendo stato posto in essere in epoca anteriore, costituisca attuazione di un disegno volto a disfarsi dei propri beni, proprio in vista dell’assunzione di quello specifico debito.
(*Contributo in tema di “L’azione revocatoria e la dolosa preordinazione”, a cura di Caterina D’Alessandro, Giulia Fanelli e Mariella Pascazio, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)