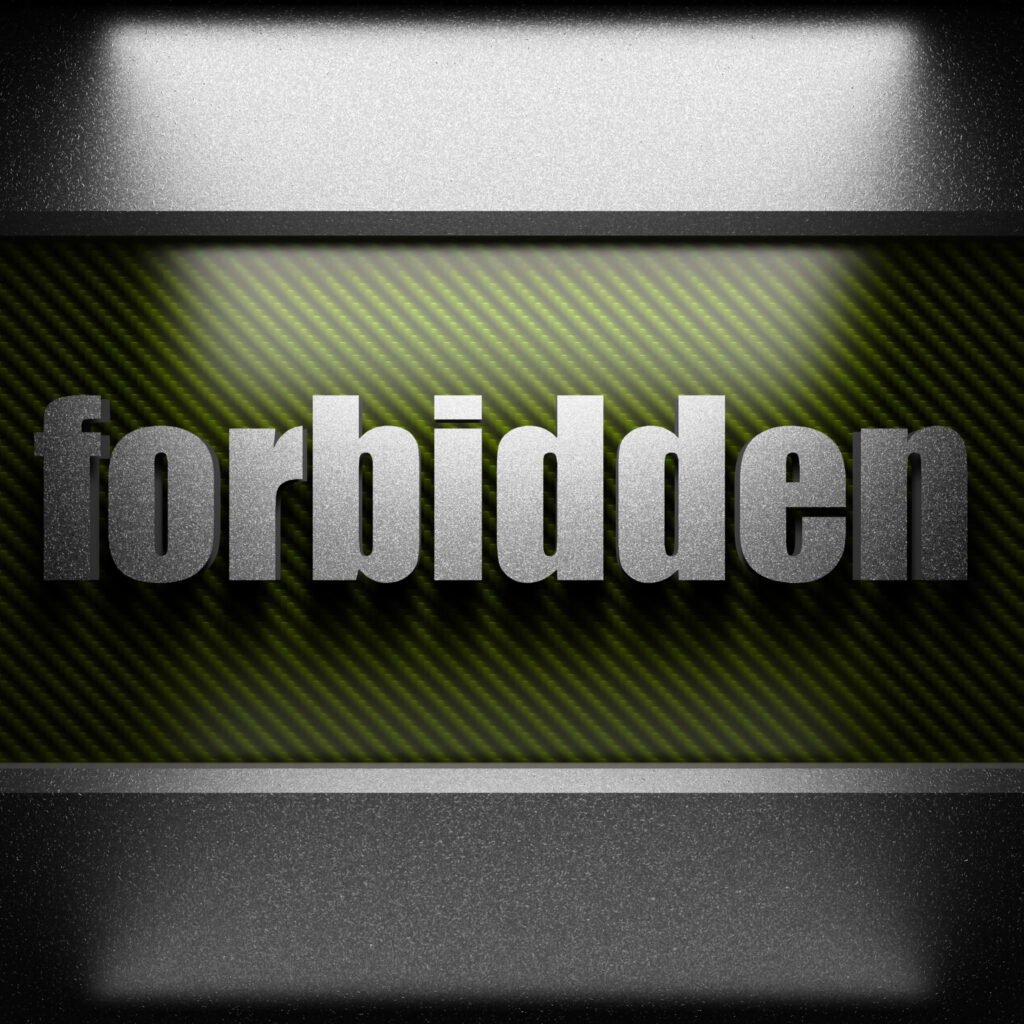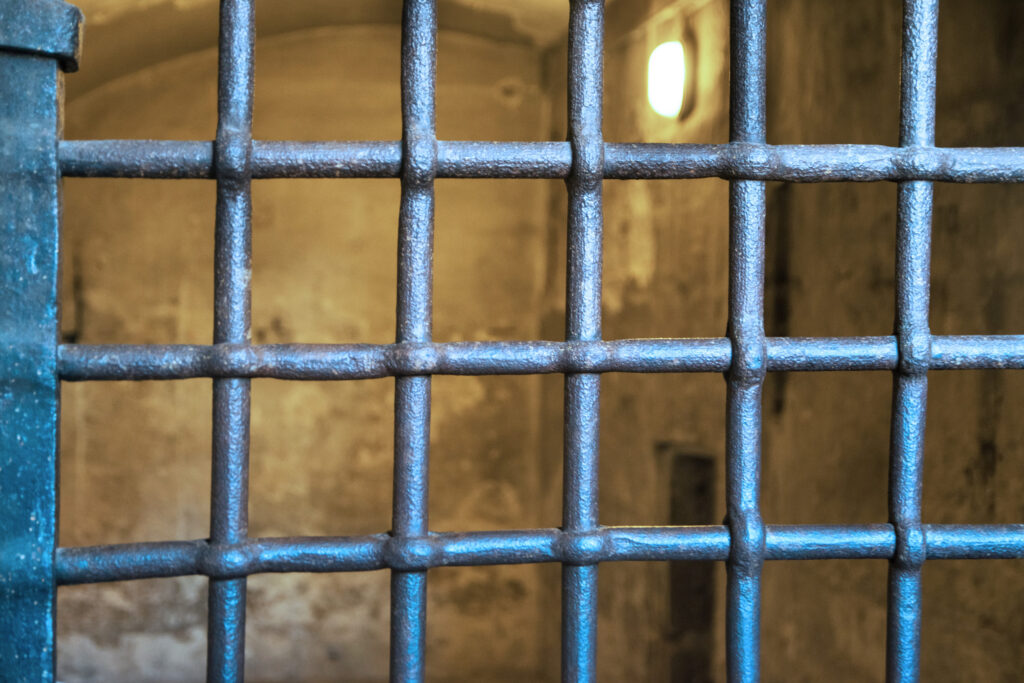Assegno nucleo familiare: la convivenza di fatto non esclude il diritto La Corte costituzionale ha stabilito che il rapporto di convivenza di fatto non comporta la perdita del diritto all’assegno per il nucleo familiare
-
By
Redazione
Convivenza di fatto e diritto all’ANF
Assegno nucleo familiare: la Corte costituzionale, con la sentenza numero 120/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, in relazione all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955. Questa norma stabilisce che l’assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato. Tale differenziazione, secondo il rimettente, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La finalità della norma sull’assegno per il nucleo familiare
La Corte ha chiarito che la ratio dell’articolo 2 del d.P.R. numero 797 del 1955 può essere ravvisata nell’esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di “autofinanziamento”. Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell’esclusione dall’ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell’ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge numero 69 del 1988.
Rilevanza giuridica della convivenza di fatto
La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016.
Coerenza della disciplina sull’ANF
La disciplina dell’ANF risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.