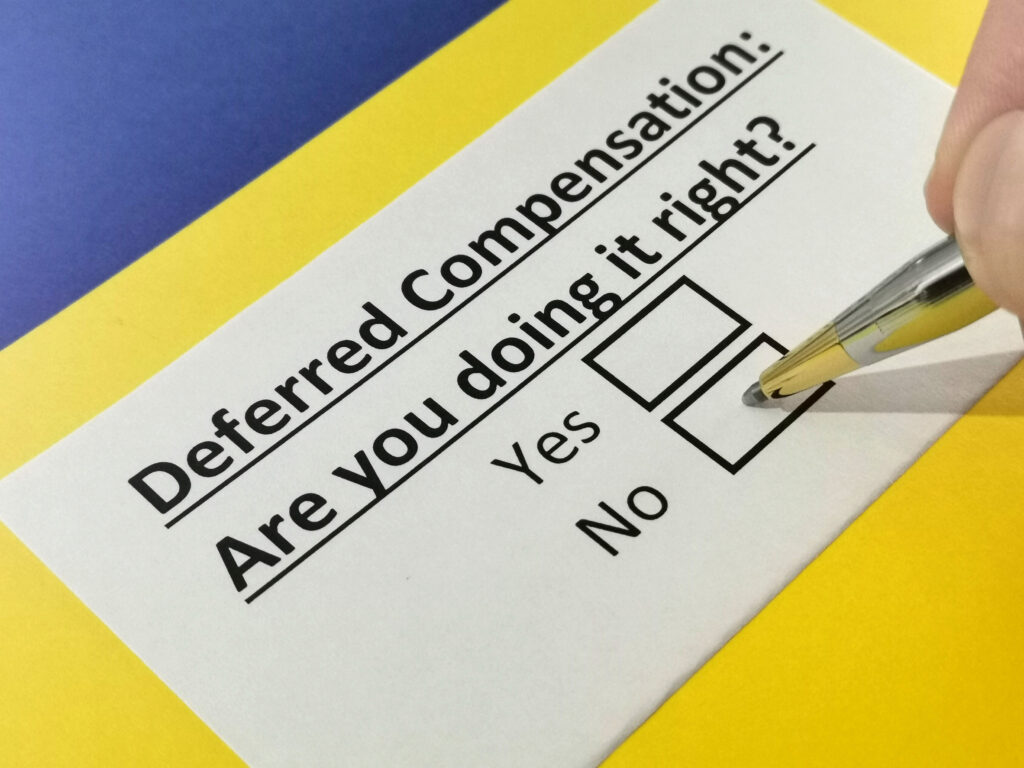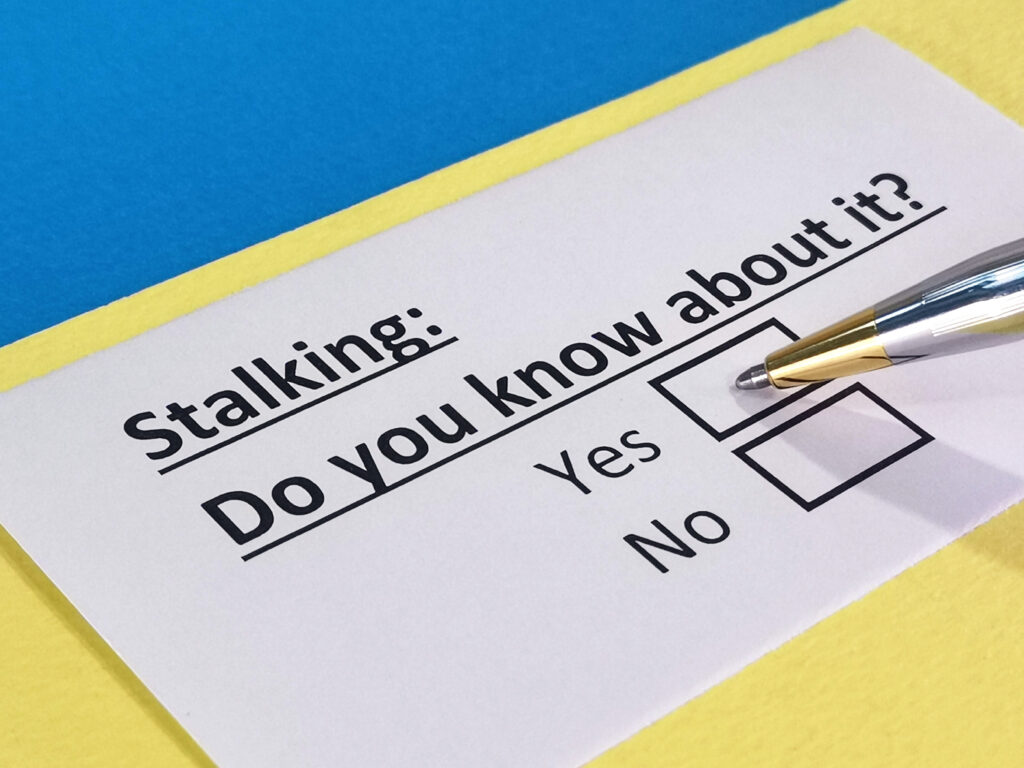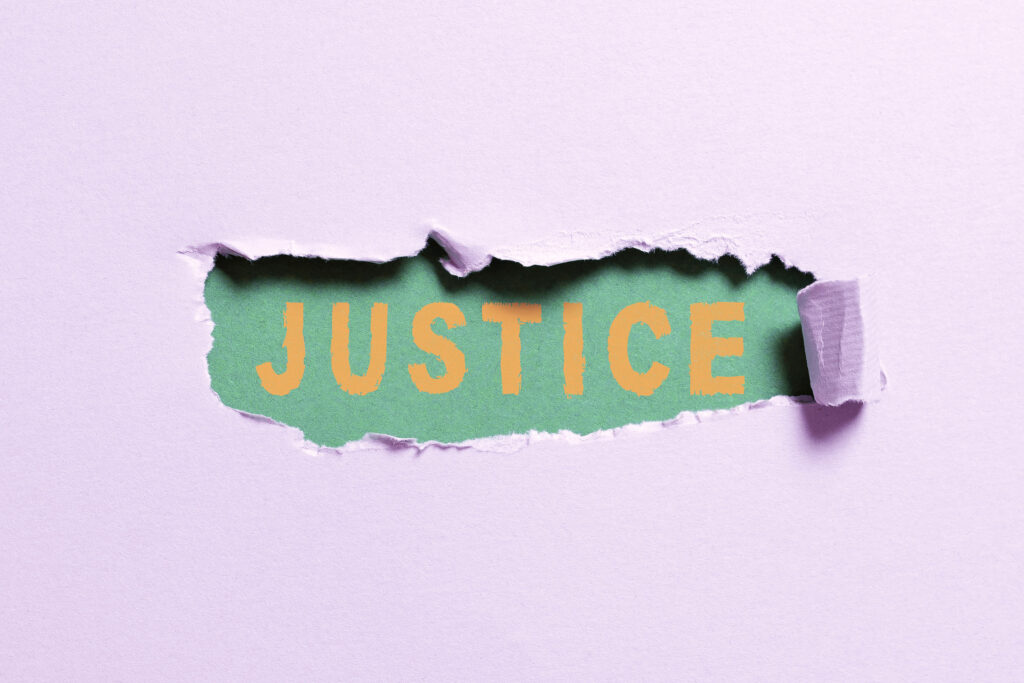Locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale Il comune ha poteri inibitori in materia di locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale?
Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante
No, il comune non ha poteri inibitori in materia di locazione di immobili per finalità turistica in forma non imprenditoriale. – Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2025, n. 2928.
In via preliminare, si rileva che la materia del turismo rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ferma restando la possibilità di intervento dello Stato nella materia dell’ordinamento civile di sua competenza esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., ambito nel quale si colloca la disciplina della libertà contrattuale, rilevante anche con riferimento ai rapporti di locazione turistica e suscettibili di incidere anche sul settore del turismo.
La Sezione evidenzia che l’attività di locazione a fini turistici svolta in forma non imprenditoriale, riconducibile al mero godimento indiretto di beni immobili, non è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 L. 241/1990, ma richiede unicamente una comunicazione di inizio attività (CIA), avente finalità di monitoraggio. Ne consegue che tale attività non può essere assoggettata a poteri prescrittivi o inibitori da parte dell’amministrazione locale.
Dunque, gli immobili destinati alla locazione per finalità turistiche devono essere conformi ai requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria per le civili abitazioni; tuttavia, l’eventuale difetto di tali requisiti potrà incidere sulla validità o sull’esecuzione del contratto di locazione eventualmente stipulato, ma non legittima l’amministrazione a vietarne la stipula.