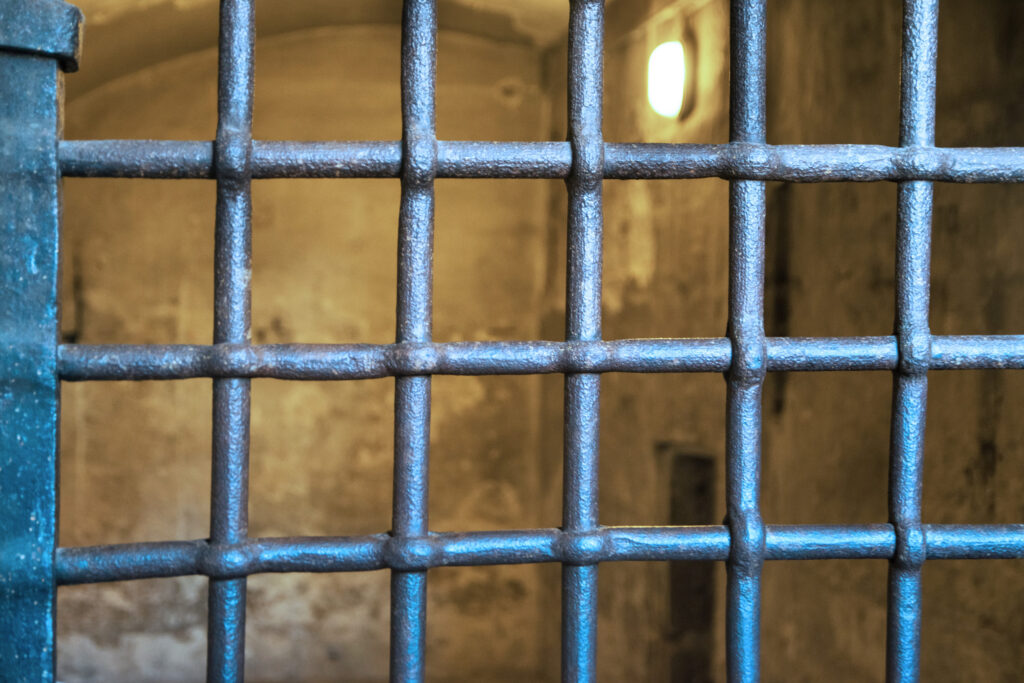Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Alessandra Fantauzzi
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4 c.p. nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante della collaborazione del reo, prevista dall’art. 625bis dello stesso codice, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata. – Corte cost. 22 aprile 2025, n. 56 (Divieto di prevalenza dell’attenuante).
La questione veniva sollevata con ordinanza dal Tribunale di Perugia, il quale era stato chiamato a decidere su un furto in abitazione. Nel caso trattato dal giudice a quo l’imputato veniva fermato dal proprietario dell’immobile in cui stava effettuando il furto dopo aver tentato la fuga, trovando refurtiva di poco valore. Nel corso dell’interrogatorio reso in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto, l’imputato ammetteva l’addebito e consentiva l’identificazione del correo.
Il riconoscimento del fatto così come contestato è indubbio: sussistenti erano tutti gli elementi del furto in abitazione, così come la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista all’art. 625bis c.p. e la contestata recidiva. Infatti, l’imputato aveva collaborato con le autorità per l’individuazione dei correi e, al contempo, era gravato da due precedenti specifici. Il Giudice remittente aggiungeva considerazioni sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione: la prima sulla base della ben inferiore sanzione irrogabile, la seconda per manifesta irragionevolezza rispetto alla ratio della circostanza attenuante, parametrandolo all’art. 3 Cost.. La circostanza attenuante di cui all’art. 625bis c.p. sarebbe «espressione di una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento post-delittuoso dell’imputato, rispondendo, sia all’esigenza di tutela del bene giuridico, sia a quella di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio». A ciò si aggiunga che per il riconoscimento dell’attenuante non è richiesta la spontaneità della collaborazione, ma solo il ruolo effettivamente avuto nell’individuazione dei correi. La norma posta al vaglio di legittimità della Consulta fornisce una rilevanza quasi insuperabile della condotta criminosa, anche rispetto alla collaborazione successiva del reo. Sistematicamente, questo aspetto si rivela scorretto su più fronti: da una parte, la collaborazione rappresenterebbe un disconoscimento del fatto illecito e un allontanamento dalla condizione di illegalità; dall’altra, la condotta contemporanea o susseguente al reato è indice di valutazione della capacità a delinquere del reo ai sensi dell’art. 133 c.p. e il Giudice di merito deve tenerne conto anche nella comparazione di circostanze eterogenee concorrenti.
La norma censurata, inoltre, ad avviso del giudice a quo, sarebbe costituzionalmente illegittima in un’ottica comparativa. In primo luogo, risulta incompatibile con il trattamento della circostanza attenuante a effetto speciale per i delitti di stampo mafioso, la quale non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed è obbligatoria. In secondo luogo, rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4 c.p. come sostituito dalla dall’art. 3 della L. 251/2005 nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante a effetto speciale di cui all’art. 73, comma 7 D.P.R. 309/1990 sulla recidiva reiterata (Corte cost. 74/2016).
La Corte dichiara la fondatezza della questione prospettata, riferendosi a ben dodici pronunce antecedenti che hanno colpito il divieto di prevalenza di date circostanze attenuanti rispetto alla suddetta recidiva reiterata. Infatti, scopo del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è quello di permettere al giudice di “valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono” (Corte cost. 38/1985). D’altra parte, deroghe al regime del bilanciamento sono ammissibili e rientranti nella discrezionalità del legislatore, purché non travalichino i confini della manifesta irragionevolezza o dell’arbitrio anche con riferimento ai principi costituzionali. Sulla base di queste considerazioni, la Consulta ha rinvenuto alterazioni degli equilibri in relazione a circostanze espressive di un minor disvalore del fatto. I filoni argomentativi si suddividono in tre tipologie.
Secondo il primo, la ratio della illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza è stata individuata nella centralità del fatto oggettivo rispetto alla qualità soggettiva del colpevole, in base alla quale deve escludersi che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente possano assumere nel processo di individualizzazione della pena una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (Corte cost. 141/2023).
Proseguendo con il secondo, tali pronunce hanno fatto venire meno il divieto di prevalenza anche rispetto a circostanze inerenti alla persona del colpevole per la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (Corte cost. 73/2020) e per quella di cui all’art. 116 c.p. (Corte cost. 55/2021). Una terza ratio, infine, attiene all’incentivo alla collaborazione del reo post delictum (Corte cost. 74/2016 e, da ultimo, Corte cost. 201/2023); scopo di quest’ultima è quella di incentivare, mediante una sensibile riduzione di pena, il ravvedimento dell’imputato rispetto alla condotta criminosa attuata rispondendo alle esigenze di tutela del bene giuridico e di prevenzione o repressione di condotte delittuose.
A conclusione, viene rimarcato dalla Consulta che il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena consentita dall’attenuante, in presenza di recidiva reiterata, impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti e ne frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio. Tale circostanza può in tal modo essere percepita come ingiusta dal cittadino, impedendo l’assolvimento della finalità rieducativa a cui deve aspirare la sanzione penale. Inoltre, in relazione al furto in abitazione, la scelta di incentivare la collaborazione non è venuta meno neppure nei successivi interventi legislativi. Pertanto, la suddetta norma veniva dichiarata costituzionalmente illegittima.
(*Contributo in tema di “Divieto di prevalenza dell’attenuante e circostanza aggravante della recidiva reiterata”, a cura di Daniela Cazzetta e Alessandra Fantauzzi, estratto da Obiettivo Magistrato n. 86 / Giugno 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)