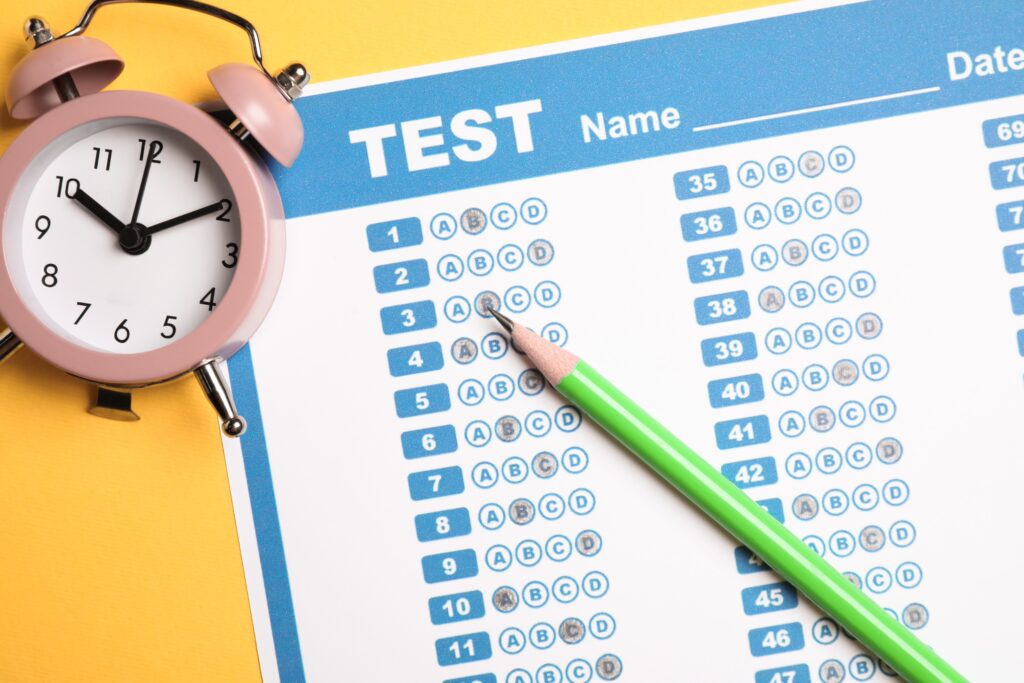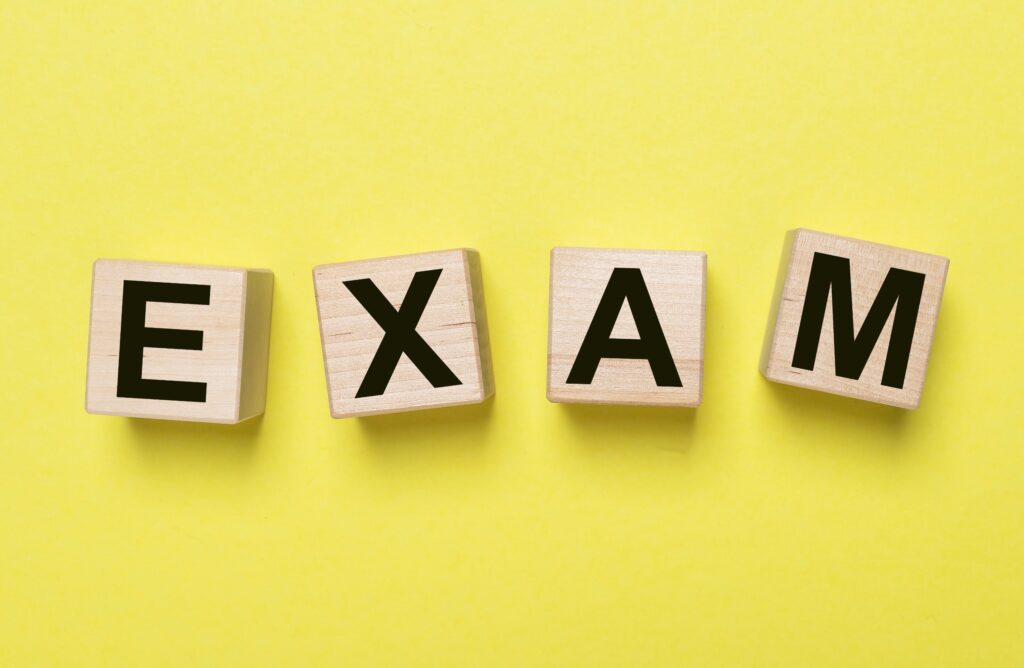Licenziamento per esubero personale Nel licenziamento per esubero del personale, i dipendenti da licenziare devono essere scelti in base ai criteri di buona fede e correttezza. Cenni sul repechage
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento per esubero di personale è una delle possibili ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, secondo cui il licenziamento per giustificato motivo può essere determinato anche da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Tale forma di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro rientra tra le facoltà dell’imprenditore, che però può esercitarla entro determinati limiti.
I presupposti del licenziamento per esubero personale
Innanzitutto, va evidenziato che il giustificato motivo oggettivo ricorrente in questa ipotesi non è da ricondurre necessariamente a uno stato di crisi dell’impresa, che può anche non sussistere.
I motivi della scelta imprenditoriale, infatti, ben possono ricondursi a esigenze del datore di lavoro riferibili alla riorganizzazione aziendale, alla soppressione di sedi o rami d’azienda o al ridursi della produttività dell’attività.
Esubero personale: la scelta dei dipendenti da licenziare
Uno degli aspetti cruciali in tema di licenziamento per esubero del personale è rappresentato dalla scelta, da parte del datore, del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare.
In caso di omogeneità di mansioni ricoperte da parte di più dipendenti, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere compiuta dal datore di lavoro attenendosi ai criteri di buona fede e correttezza.
Sebbene i contorni di tali criteri risultino spesso sfumati, la giurisprudenza ha chiarito che è possibile fare riferimento ai criteri individuati dalla disciplina in tema di licenziamento collettivo. Quest’ultima prevede che, se l’accordo sindacale non individua altri criteri, la scelta dei dipendenti da licenziare deve essere effettuata tenendo conto dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia.
In base a tali criteri, quindi, a parità di mansioni, verrà licenziato il dipendente con minore anzianità di servizio e con un minor numero di familiari a carico.
Come ricorda la Corte di Cassazione, del resto, “la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza e buona fede” (Cass. n. 31490/2018 e n. 19732/2018).
Licenziamento per esubero e repechage
Un altro aspetto cruciale della disciplina del licenziamento per esubero del personale è rappresentato dal c.d. repechage, o ripescaggio, e cioè quella particolare soluzione per cui il datore di lavoro è tenuto a mantenere il rapporto di lavoro in essere con il dipendente, se è possibile adibire quest’ultimo ad una diversa posizione lavorativa, pur con differenti mansioni e retribuzione da quelle precedenti.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato di recente che il datore, nell’assolvimento dell’obbligo di repechage, deve prendere in esame anche quelle posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso. In altre parole, nella ricerca di posizioni nelle quali adibire il lavoratore in esubero, l’azienda deve prendere in considerazione anche quelle attualmente ricoperte da dipendenti che abbiano già dato il preavviso di dimissioni (Cass. sent. n. 12132/2023).
Esubero personale e offerta di part-time
Un’altra interessante pronuncia della Cassazione in tema di licenziamento per esubero del personale ricorda che, in un contesto di riorganizzazione aziendale per esubero del personale, può costituire giustificato motivo oggettivo per il licenziamento il rifiuto da parte del dipendente di accettare la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full-time a part-time.
In generale, infatti, il rifiuto del part-time non costituisce di per sé giustificato motivo per il licenziamento, ma la presenza di ragioni oggettive che giustifichino la richiesta datoriale rende giustificabile anche il licenziamento, in caso di rifiuto della stessa (Cass. ord. n. 12244/2023).