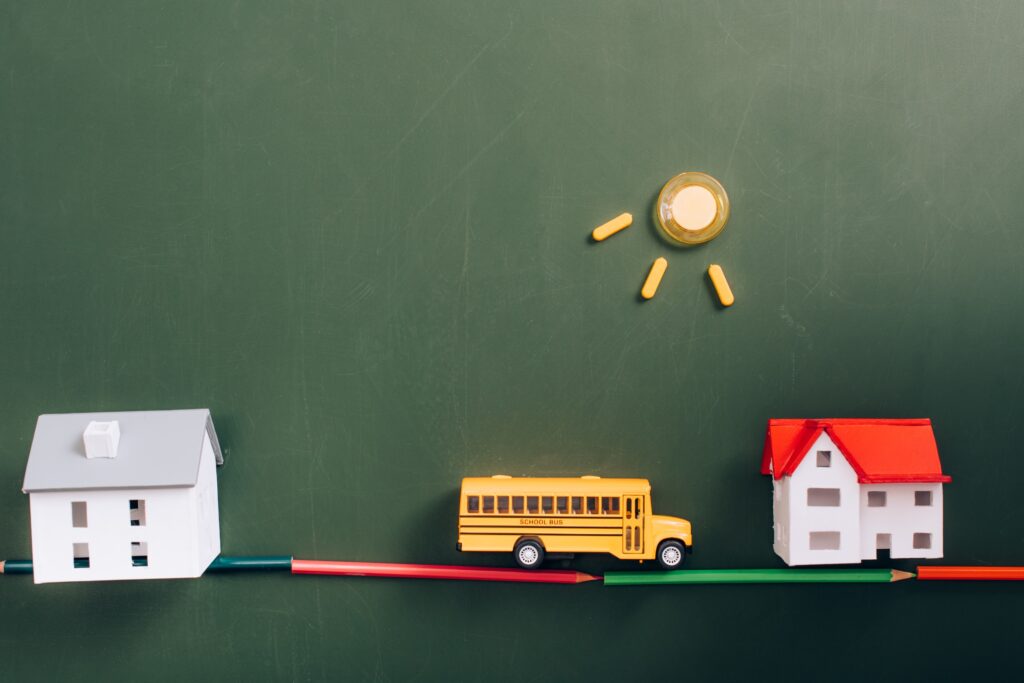La compliance nella Pubblica Amministrazione Compliance nella Pubblica Amministrazione: cos'è, a cosa serve, principio di legalità e controlli, riferimenti normativi
Cos’è la compliance
La compliance è quell’attività complessa che individua e riferisce in merito alla presenza del rischio di sanzioni e del peggioramento della reputazione a causa del mancato rispetto di leggi e regolamenti, ma anche di codici di condotta e buone pratiche.
Compliance e Pubblica Amministrazione
Parlare di compliance in relazione alla Pubblica Amministrazione potrebbe sembrare un contro senso. Del resto, l’attività della PA dovrebbe essere sempre essere conforme alla legge. La realtà però è ben diversa. Le PA sono soggette, al pari dei privati, a rischi che derivano dall’ applicazione delle norme che ne regolano l’attività.
Per questo il concetto di “compliance”, inteso come la conformità a norme, regole, standard, codici di condotta e principi etici, ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel funzionamento della Pubblica Amministrazione (PA) italiana. Non più limitata alla mera osservanza formale della legge, la compliance nella PA si configura oggi come un approccio proattivo volto a prevenire illeciti, ottimizzare i processi, migliorare l’efficienza e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il principio di legalità
La compliance si può tradurre con il termine “conformità”, concetto che a sua volta evoca il principio di legalità sancito dall’articolo 97 della Costituzione, a cui deve uniformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione.
La norma su questo punto è molto chiara:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
Appare subito evidente la stretta correlazione tra legge e pubblica amministrazione. Del resto il principio di legalità è finalizzato anche al perseguimento dei principi di buon andamento e imparzialità.
Controlli e valutazione
Proprio per assicurare il rispetto del buona andamento nel corso degli anni sono stati introdotti sempre maggiori controlli orientati inizialmente alla verifica del rispetto della legittimità degli atti, per passare poi a un controllo finalizzato alla valutazione del rapporto intercorrente tra costi e risultati (controllo di gestione) e a quello tra obiettivi e risultati (controllo strategico).
Ad oggi i controlli preventivi sono superati, quelli successivi però presentano lo svantaggio di non impedire condotte illegittime. La compliance ha il pregio di prevenire le irregolarità grazie alla progettazione e alla verifica di procedure interne adeguate.
Compliance nella PA: normativa di riferimento
La compliance nella PA italiana trova il suo fondamento in un corpus normativo complesso e stratificato, che ha visto negli ultimi anni interventi significativi. I pilastri principali includono:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione): rappresenta la normativa cardine in materia di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità nella PA. Sebbene datata, la Legge 190/2012 continua a essere il riferimento principale per le strategie di compliance anticorruzione.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Decreto Trasparenza): ha riordinato la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è riconosciuta come un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ponendo le basi per una “amministrazione aperta” e controllabile dai cittadini.
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Inconferibilità e Incompatibilità): disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Contribuisce a prevenire situazioni di conflitto di interessi e a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation): il GDPR ha imposto standard elevati per la protezione dei dati personali, con un impatto significativo sui processi interni della PA che trattano informazioni sensibili. La compliance al GDPR richiede un’attenta valutazione dei rischi, la nomina di un Data Protection Officer (DPO) e l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.
- Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36): ha introdotto importanti novità in materia di appalti e concessioni. La compliance in quest’ambito è cruciale per prevenire fenomeni corruttivi, garantire la libera concorrenza e assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La semplificazione e la digitalizzazione dei processi di gara, pur mirando a snellire le procedure, richiedono al contempo un rafforzamento dei controlli e della trasparenza.
- Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e normativa correlata: l’attuazione del PNRR ha comportato l’introduzione di specifiche disposizioni volte a garantire la regolarità, l’efficienza e la trasparenza nella gestione dei fondi europei. La compliance ai requisiti del PNRR è fondamentale per l’accesso e l’utilizzo delle risorse, con un forte accento sulla rendicontazione e sul monitoraggio.
- Normativa sulla transizione digitale e l’innovazione tecnologica: Le direttive e i provvedimenti volti alla digitalizzazione della PA (ad esempio, il Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) impongono nuove sfide in termini di compliance, legate alla sicurezza informatica, all’interoperabilità dei sistemi e all’accessibilità dei servizi digitali.
Leggi anche gli altri articoli di diritto amministrativo