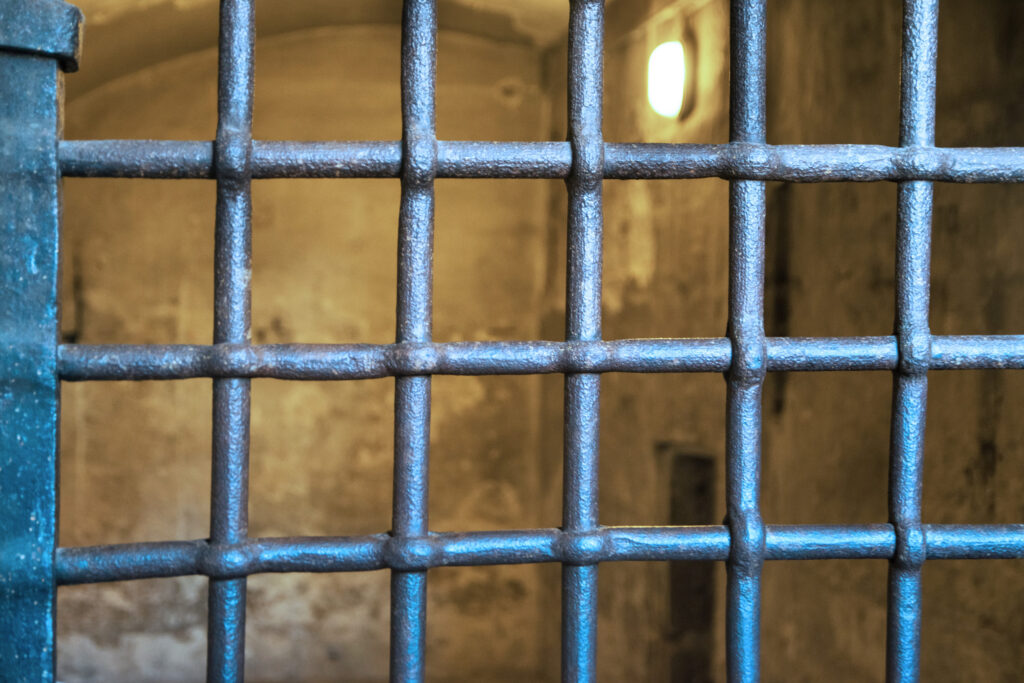Proporzionalità della pena nel sequestro estorsivo
Sequestro a scopo di estorsione: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della pena prevista per il delitto di sequestro di persona a scopo estorsivo, ritenendo che il giudice disponga già di strumenti interpretativi e applicativi idonei a garantire il rispetto del principio di proporzionalità della pena, sancito dall’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Il caso concreto esaminato dalla Consulta
La pronuncia è intervenuta su rinvio della Corte d’assise di Torino, che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale in un procedimento penale nei confronti di tre imputati accusati di avere privato, per breve tempo, alcune vittime della libertà personale, allo scopo di ottenere pagamenti compresi tra 100 e 320 euro come corrispettivo per prestazioni sessuali, che le persone offese ritenevano gratuite. Il fatto era stato qualificato come sequestro estorsivo, reato punito, ai sensi dell’art. 630 c.p., con la reclusione da venticinque a trent’anni.
La pena per il sequestro estorsivo: origine e ratio
La Corte ha richiamato il contesto storico della norma, evidenziando come la previsione di una pena di eccezionale severità fosse stata introdotta in risposta ai sequestri di persona verificatisi negli anni Settanta, caratterizzati da una lunga durata della privazione della libertà personale, riscatti elevatissimi e pericolo per la vita degli ostaggi. In tale contesto, l’inasprimento sanzionatorio era giustificato.
Il correttivo introdotto nel 2012 e gli strumenti oggi disponibili
Già con la sentenza n. 68 del 2012, la Corte costituzionale aveva giudicato manifestamente sproporzionata la pena minima di venticinque anni nei casi di sequestro di minore gravità, introducendo la possibilità di riduzione fino a un terzo della pena (minimo di sedici anni e otto mesi di reclusione).
Con la nuova pronuncia, la Corte ribadisce che, anche qualora la pena ridotta appaia ancora eccessiva, il giudice può fare applicazione del principio di proporzionalità, utilizzandolo come criterio interpretativo della norma penale, per escludere l’applicabilità dell’art. 630 c.p. ai fatti che non raggiungano la soglia di gravità voluta dal legislatore.
L’obbligo del giudice di una valutazione conforme al principio di proporzione
La Consulta afferma che il giudice deve valutare attentamente la qualificazione giuridica del fatto, verificando se esso configuri effettivamente un sequestro a scopo di estorsione, oppure se sia più correttamente riconducibile a reati diversi, come il sequestro di persona semplice (art. 605 c.p.), l’estorsione (art. 629 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.).
Tali reati, pur essendo gravi, prevedono pene più proporzionate alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato, evitando così l’irrogazione di una sanzione eccessiva rispetto alla concreta entità del fatto.
La compatibilità con il principio di legalità
Infine, la Corte precisa che questa interpretazione non viola il principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.). Tale principio, infatti, impedisce l’applicazione analogica in malam partem, ma non esclude una interpretazione restrittiva della norma incriminatrice, qualora il fatto concreto sia estraneo ai fenomeni criminosi che il legislatore ha inteso colpire con una sanzione di particolare rigore.