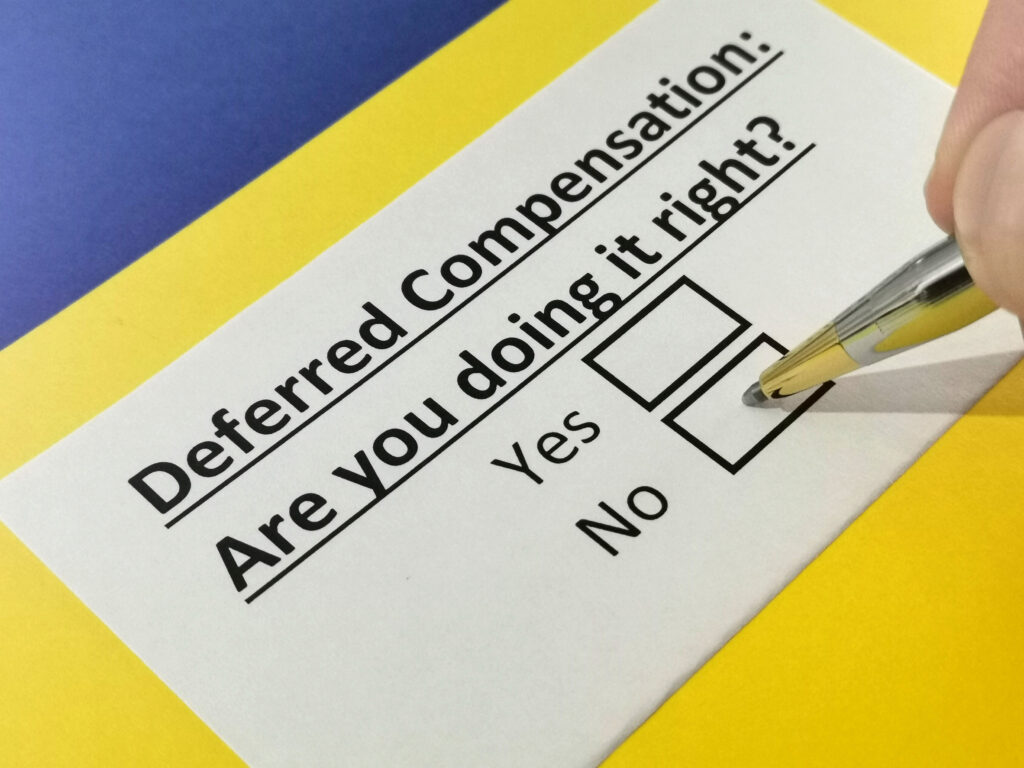Quesito con risposta a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo
Il mutuo che utilizza l’Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse è nullo se tale indice risulta alterato da un cartello bancario, configurandosi il contratto come “negozio a valle” rispetto a un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE? Inoltre, la manipolazione del parametro Euribor può riflettersi sulla validità del contratto anche in assenza di una partecipazione o consapevolezza del mutuante?
In relazione alle questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola per la determinazione del tasso di interesse parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni), poiché la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale 287/1990), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza», occorre rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso per ulteriori approfondimenti (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2025, n. 6943 (determinazione del tasso di interesse).
Con ordinanza interlocutoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rinviato a nuovo ruolo la trattazione della causa, ritenendo opportuno attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea su una questione interpretativa già sollevata con rinvio pregiudiziale dalla Corte d’Appello di Cagliari, sez. civ., ord. 25 gennaio 2025 di rilevanza sistemica.
La vicenda origina dal ricorso proposto da alcuni mutuatari i quali contestano la validità della clausola contrattuale che indicizza il tasso d’interesse all’Euribor, sostenendo che il parametro sarebbe stato oggetto di manipolazione da parte di un cartello bancario sanzionato dalla Commissione Europea con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016. I ricorrenti invocano l’illiceità della clausola sotto il profilo della nullità per violazione di norme imperative (art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990), nonché per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (artt. 1284, 1346, 1418 e 1825 1346 c.c.), in quanto fondato su un parametro falsato.
Il quesito giuridico di fondo è duplice: i) sotto il profilo antitrust, si pone il dubbio se i contratti bancari che recepiscono un parametro frutto di un’intesa illecita, seppur in mercati diversi da quello originariamente colpito (il mercato dei derivati), possano essere considerati nulli ex art. 101, comma 2, TFUE in quanto sbocco funzionale dell’intesa vietata, anche in difetto di partecipazione o consapevolezza da parte del mutuante o se – al contrario – in difetto di un collegamento funzionale tra l’accordo illecito e il singolo contratto bancario, debba escludersi la nullità di quest’ultimo, circoscrivendo gli effetti dell’intesa vietata al solo mercato dei derivati, indipendentemente dalla partecipazione o consapevolezza del mutuante di siffatta intesa anticoncorrenziale; ii) sotto il profilo civilistico, si discute se la manipolazione del parametro Euribor qualora accertata, incida sulla struttura causale del contratto e sulla determinabilità dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.), rendendo nulla la clausola di determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., producendo effetti anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alla condotta anticoncorrenziale, oppure se tale alterazione possa essere considerata rilevante solo nel processo di formazione della volontà negoziale delle parti, laddove abbia determinato nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto generatore di un danno risarcibile.
Le Sezioni Unite, in considerazione della complessità e della rilevanza sistemica della questione, nonché dell’esistenza del rinvio pregiudiziale già pendente dinanzi alla CGUE ad opera della Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza del 25 gennaio 2025, hanno optato per la sospensione del giudizio, in attesa dei chiarimenti della Corte europea.
È rilevante evidenziare che la Corte d’Appello ha investito la Corte del compito di chiarire se l’art. 101 TFUE implichi anche l’invalidità delle clausole dei contratti di mutuo, di finanziamento e in generale di qualunque rapporto giuridico che abbia recepito l’Euribor alterato oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza, pur operando in mercati formalmente distinti da quello dei derivati. Ha altresì sollevato il dubbio interpretativo circa l’efficacia vincolante delle decisioni della Commissione europea in merito alla manipolazione dell’indice, ai sensi dell’art. 16, par. 1, Reg. CE 1/2003.
La Corte d’Appello nell’ordinanza di rimessione ha condotto un’analitica ricognizione dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno alla Corte di Cassazione, evidenziandone la coerenza o la divergenza rispetto alla questione oggetto di rinvio.
Una linea giurisprudenziale conforme riconosce l’incidenza dell’intesa restrittiva della concorrenza anche sui contratti bancari a valle, pur se formalmente esterni al mercato dei derivati originariamente colpito, valorizzando le decisioni della Commissione Europea quale prova privilegiata e vincolante per i giudici nazionali circa l’esistenza di una intesa illecita. Anche in assenza di una partecipazione diretta del mutuante, la clausola contrattuale che recepisce un parametro alterato come l’Euribor manipolato nel periodo oggetto dell’intesa risulta nulla, poiché rappresenta lo sbocco funzionale dell’intesa vietata (Cass., sez. III, 13 dicembre 2023, n. 34889).
In particolare, una volta accertata la manipolazione del parametro di riferimento, la clausola che vi rinvia viene ritenuta viziata nella sua struttura causale. L’alterazione comporta una sopravvenuta inidoneità del parametro a riflettere la volontà negoziale delle parti, causando l’indeterminabilità dell’oggetto contrattuale e, conseguentemente, la nullità della clausola ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., anche se l’alterazione è imputabile a terzi e le parti ne erano ignare (Cass., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007).
Sebbene riferita ad una differente tipologia contrattuale, anche la pronuncia in tema di fideiussioni conformi al modello ABI ha sancito il principio secondo cui la nullità dell’intesa a monte si estende necessariamente ai contratti a valle, quando questi costituiscano l’attuazione degli effetti distorsivi sul mercato. Tale impostazione è ritenuta dalla Corte d’Appello di Cagliari perfettamente applicabile anche ai contratti di mutuo che incorporano il parametro Euribor manipolato (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
In termini ancor più generali, è stato riconosciuto che il consumatore, ancorché estraneo all’intesa, può agire per far valere la nullità della medesima e dei contratti derivati, in quanto strumenti con cui si realizza l’elusione della libertà concorrenziale e si limita la sua possibilità di scelta consapevole tra alternative di mercato (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207).
Accanto a queste pronunce, la Corte d’Appello di Cagliari segnala l’esistenza di un rilevante orientamento difforme, espresso dalla Cassazione (Cass., sez. I, 18 giugno 2024, n. 19900), secondo cui l’accordo illecito accertato dalla Commissione Europea avrebbe inciso unicamente sul mercato degli strumenti derivati (EIRD), senza estendersi ad altri settori, come quello dei mutui a tasso variabile. Di conseguenza, non vi sarebbe il collegamento funzionale necessario per ritenere che il contratto bancario costituisca lo sbocco dell’intesa vietata ai sensi dell’art. 101, comma 2 TFUE. La stessa pronuncia, inoltre, ridimensiona il valore probatorio delle decisioni della Commissione, escludendo che esse possano fungere da “prova privilegiata” nei giudizi nazionali, pur riconoscendo loro carattere vincolante sul piano giuridico.
(*Contributo in tema di “Mutuo con Euribor come parametro per la determinazione del tasso di interesse: il caso del cartello bancario che altera l’indice ”, a cura di Sara Frattura, Raffaella Lofrano e Maria Lavinia Violo, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)