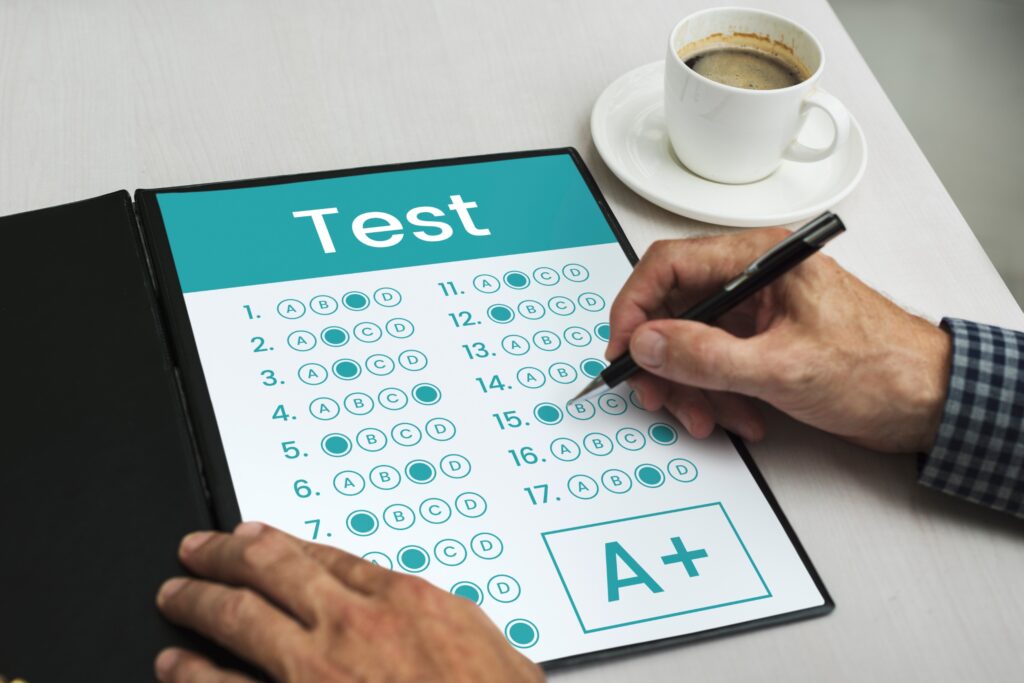Telefonate ai figli: niente stretta per i reati ostativi La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la stretta sulle telefonate ai figli minori a carico dei condannati per reati di criminalità organizzata che abbiano accesso ai benefici
Telefonate figli e regime restrittivo
“Se un detenuto è stato condannato per un reato compreso nell’elenco dell’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, ma ha in concreto accesso a tutti i benefici penitenziari, è irragionevole sottoporlo a un regime più restrittivo rispetto a quello ordinario solo per quanto riguarda le telefonate con i propri figli minori”. E’ quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 85-2024, con la quale ha ritenuto fondata una questione sottopostale da un magistrato di sorveglianza di Padova.
Condanna per reati ostativi
La Corte ha ricordato che chi è condannato per uno dei reati elencati nel primo comma dell’art. 4-bis (i cosiddetti “reati ostativi”) è ordinariamente escluso dai benefici penitenziari, in forza della generale presunzione per cui i collegamenti con l’organizzazione criminale non vengono meno con l’ingresso in carcere del condannato, con conseguente persistere della sua pericolosità sociale.
Questi detenuti hanno accesso ai benefici, di regola, soltanto quando collaborino con la giustizia, perché proprio la loro collaborazione costituisce “una sorta di prova legale della rottura del vincolo associativo rispetto al singolo detenuto, che a sua volta segnala l’inizio del suo percorso rieducativo”.
Ammissione benefici penitenziari
Tuttavia, come chiarito da sentenze recenti della stessa Consulta, “la presunzione di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata deve sempre poter essere vinta da una prova contraria, valutabile caso per caso dal tribunale di sorveglianza”. E in effetti la legge prevede oggi varie ipotesi in cui i condannati per reati “ostativi” possono in concreto essere ammessi ai benefici penitenziari, pur in mancanza di una loro collaborazione con la giustizia.
Tra queste ipotesi c’è quella di chi – come il detenuto oggetto del procedimento principale, che sta scontando una condanna a trent’anni di reclusione – abbia accesso ai benefici perché la sua collaborazione è stata ritenuta impossibile, e non risultino elementi che attestino un suo collegamento attuale con la criminalità organizzata. Nel caso concreto, il detenuto aveva in effetti già goduto di permessi premio, concessi sulla base dei suoi progressi nel trattamento rieducativo attestati dall’amministrazione penitenziaria. Inoltre, in forza della normativa speciale adottata durante il periodo della pandemia, aveva fruito di una telefonata al giorno con i propri familiari, come tutti gli altri detenuti.
La decisione della Consulta
A questo punto la Corte ha ritenuto irragionevole sottoporre in queste situazioni il condannato – ammesso ai benefici in quanto ritenuto non più socialmente pericoloso – a una disciplina più sfavorevole rispetto a quella applicabile alla generalità dei detenuti. In proposito, la Corte ha osservato che ogni disciplina – come l’art. 4-bis – che, a parità di pena inflitta, deroga in senso peggiorativo al regime penitenziario ordinario “può trovare legittimazione sul piano costituzionale – al cospetto della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. – soltanto in quanto sia necessaria e proporzionata rispetto al contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato”; e non invece “in chiave di ulteriore punizione in ragione della speciale gravità del reato commesso. È, infatti, la misura della pena che nel nostro ordinamento deve riflettere la gravità del reato, non già la severità del regime sanzionatorio”.