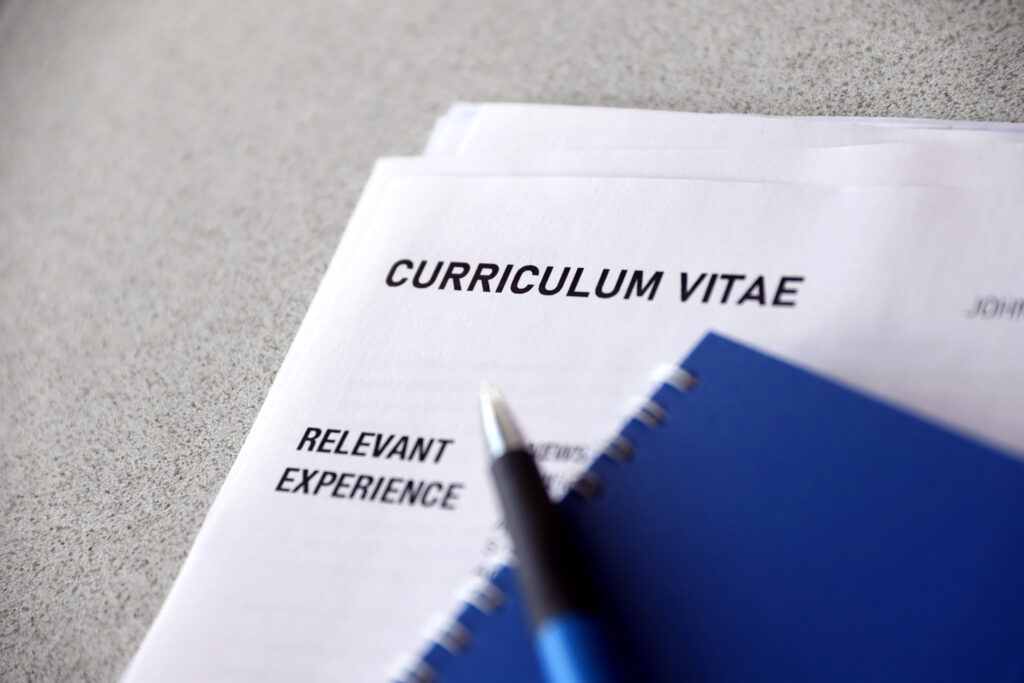Annullamento con rinvio erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso Deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza del giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse?
Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante
Si, deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 2025, n. 3009).
I Giudici di Palazzo Spada evidenziano che deve disporsi l’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. della sentenza del giudice di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. In tale contesto, rileva quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 novembre 2024, n. 16, secondo la quale le pronunce di inammissibilità che omettono l’esame del merito danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente. Tale orientamento è coerente con quanto già affermato dalle sent. 10 e 11/2018 dell’Adunanza Plenaria, le quali hanno sottolineato come anche un errore di rito manifestamente erroneo, che impedisca l’esame dei motivi di ricorso, integri i presupposti per l’annullamento con rinvio. In particolare, l’Adunanza ha chiarito che la ricostruzione del quadro normativo consente di rendere coerenti tra loro le disciplinate dall’art. 105 c.p.a., in quanto sia in caso di nullità della sentenza (per palese errore di giudizio sulle condizioni dell’azione) che in quelli di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea estinzione o perenzione, viene in rilievo non qualsiasi errore di giudizio, ma quell’errore di giudizio che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.
Questa interpretazione consente di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 2, c.p.a., che impongono l’annullamento con rinvio, e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma1, c.p.a., non espressamente richiamati dall’art. 105 c.p.a. Non appare, infatti, ragionevole trattare in modo differente il ricorrente colpito da un’erronea dichiarazione di inammissibilità rispetto a quello destinatario di una corretta dichiarazione di estinzione del giudizio.
Il principio di diritto che si è consolidato prevede, dunque, che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado qualora dichiari la nullità della sentenza, anche nei casi in cui quest’ultima abbia erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo in modo palese la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
Nel caso di specie, il T.A.R ha erroneamente ritenuto insussistente l’interesse a ricorrere sulla base del solo rilievo del vincolo derivante dalla cauzione, omettendo tuttavia di considerare le argomentazioni della ricorrente in ordine al proprio interesse a conseguire il bene della vita oggetto delle domande azionate. Pertanto, la sentenza appellata deve essere annullata con rinvio al medesimo T.A.R. ex art. 105 c.p.a., in ragione dell’accertata erroneità della pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse.