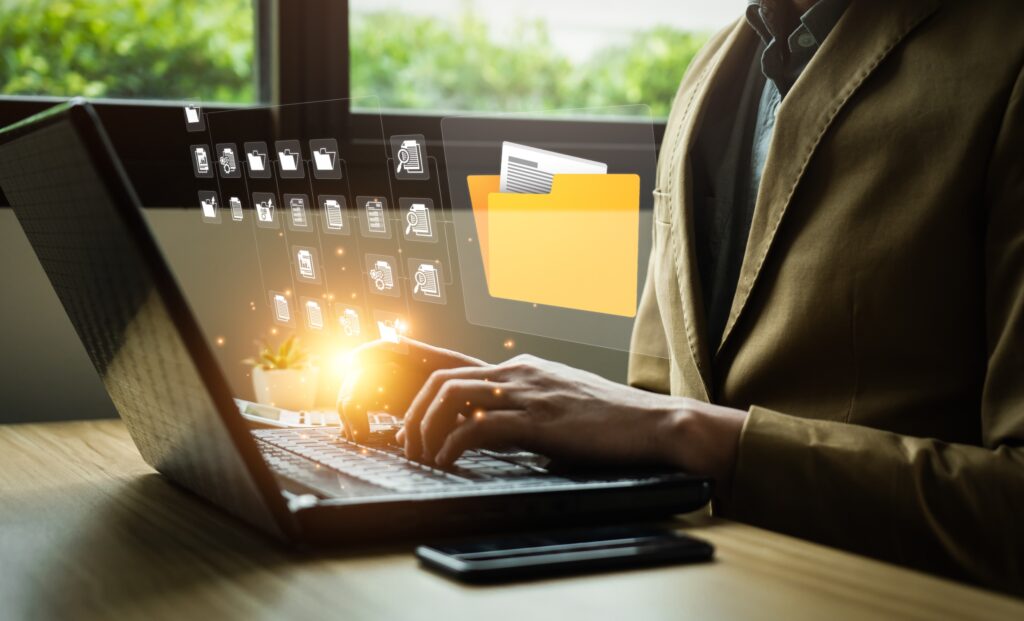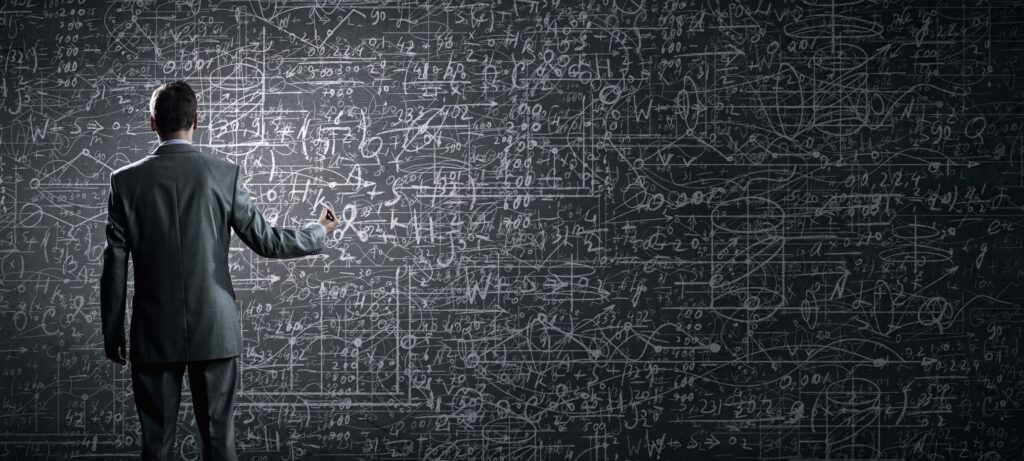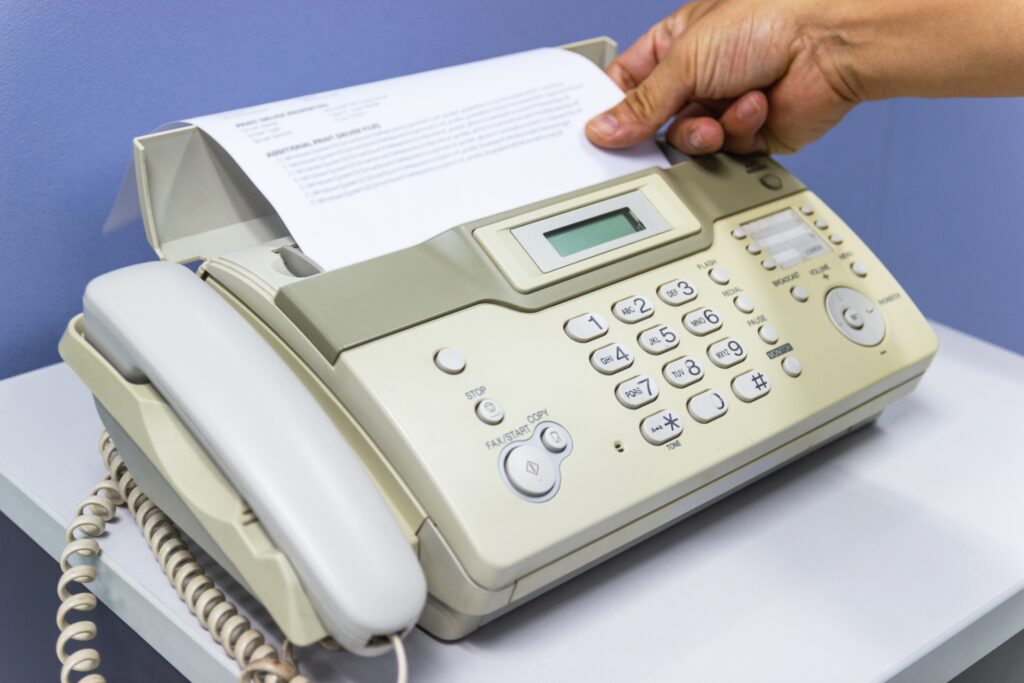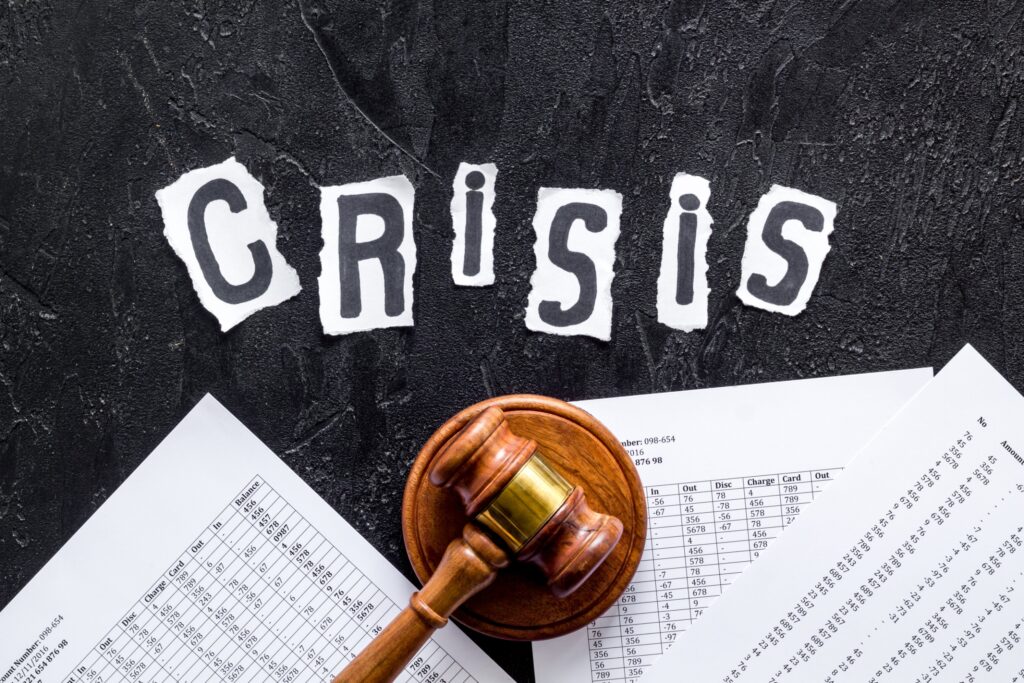Depositi automatizzati PCT: il cancelliere che fine fa? Depositi automatizzati: limitati i poteri della cancelleria nella procedura di deposito degli atti. Quale sarà il destino dei cancellieri?
Depositi automatizzati: specifiche tecniche PCT
I depositi automatizzati nel processo civile e penale telematico diventano la regola. Lo prevedono le specifiche tecniche in vigore dal 30 settembre 2024 e pubblicate il 4 agosto 2024 sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.
Depositi automatizzati: come funzionano
In base alle nuove specifiche tecniche del processo telematico, l’atto che rientra tra quelli soggetti ad accettazione automatica, una volta ricevuto dal sistema viene verificato e accettato senza che sia necessario l’intervento umano, come evidenziato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano in un documento dedicato alle specifiche tecniche. L’atto viene registrato automaticamente nello storico del fascicolo e il deposito viene posto in uno stato dedicato che mette in evidenza l’accettazione automatica. Il mittente riceve in automatico le pec che lo informano dello stato del deposito e dell’accettazione.
Deposito automatizzato: il flusso
Gli atti soggetti al deposito e all’accettazione automatica seguono i seguenti passaggi:
- l’avvocato deposita l’atto tramite i redattori e la pec;
- il sistema riceve l’atto in deposito ed effettua le verifiche preliminari;
- il sistema verifica se l’atto rientra tra quelli per i quali è previsto il deposito automatico;
- se l’atto è idoneo il sistema lo associa all’evento che corrisponde al fascicolo e procede con l’accettazione automatica;
- invio delle pec di accettazione, di avvenuta consegna; contenente l’esito dei controlli automatici; contenente l’esito dell’accettazione del deposito.
Deposito automatizzato: per quali atti?
Numerosi gli atti per i quali le specifiche tecniche prevedono il deposito automatizzato.
- Memoria 171 ter 1, replica 171 ter 2, contro-repliche 171 ter 3;
- Istanza di accoglimento domanda 183 ter e di rigetto domanda 183 quater;
- Memoria istruttoria 183 e di replica; memoria di replica 183 uc;
- Deposito dei documenti autorizzati in udienza; di note scritte in sostituzione udienza;
- Note scritte processo civile;
- Note conclusionali; comparsa conclusionale e di replica 190;
- Memoria 473 bis17c1, c2 e c3;
- istanza ex art 186 bis, ter, quater;
- istanza fissazione termine note sost. udienza;
- opposizione termine note sost. udienza;
- deposito note sostitutive udienza;
- deposito memorie.
A questi atti del processo civile si sommano quelli specifici delle esecuzioni concorsuali, delle esecuzioni individuali e della Cassazione.
Intervento della cancelleria in caso di problemi
Il processo di accettazione automatica subisce interruzioni solo se si verificano problemi tecnici e operativi. Solo in questo caso la cancelleria è chiamata ad intervenire, se invece il processo di deposito si realizza senza problemi la figura del cancelliere non è necessaria.
L’art. 17 delle specifiche tecniche
Lo prevedono i commi 9, 10 e 11 dell’art. 17 delle specifiche tecniche, che così dispongono:
“9. A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l’intervento degli operatori di cancelleria.
- In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dell’accettazione dell’atto.
- In caso di accettazione dell’atto, anche dopo l’intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.”
Leggi anche: Processo civile telematico: nuove regole dal 30 settembre