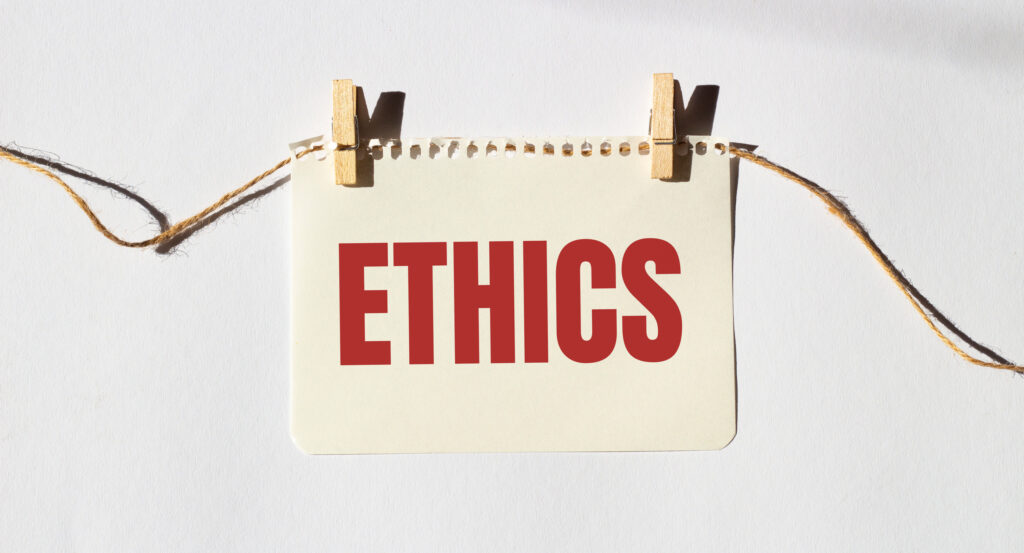Social Card: chi ne ha diritto e come ottenerla Cos'è la carta “Dedicata a te”, a cosa serve, chi ne ha diritto e cosa fare per ottenere la Social Card 2024 per le famiglie in difficoltà
Social Card: cos’è
La Social Card o Carta Dedicata a te misura confermata dalle ultime due leggi di bilancio (2023 per il 2024 e 2024 per il 2025) mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, erogando un contributo sotto forma di carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento di alcune utenze.
I fondi e il decreto ministeriale
Per il 2024 sono stati stanziati 600 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alle risorse inutilizzate del 2023.
Il decreto del ministero dell’agricoltura, di concerto con il Mimit, recante le disposizioni attuative e applicative per la carta “Dedicata a te” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024 e definisce in 12 articoli l’intervento che consente a più di un milione di famiglie di acquistare beni di prima necessità.
La Manovra di bilancio 2025 ha confermato la carta Dedicata a te stanziando 500 milioni di euro, 100 milioni in meno rispetto al 2024.
Il Dipartimento per il programma di Governo ha comunicato l’adozione, da parte del Ministro del decreto dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del decreto con cui sono stati individuati i beneficiari e i requisiti per avere diritto alla Carta. Non appena il decreto avrà concluso l’iter dei controlli sarà pubblicato sulla GU. Da segnalare che il primo pagamento avverrà entro il 16 dicembre 2025 con l’obbligo di disporre dell’importo della Carta entro il 28 febbraio 2026.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Per avere diritto alla social card “Dedicata a te” è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolari di un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro annui;
- avere la residenza in Italia;
- avere la cittadinanza italiana o UE;
- non essere titolari di altre forme di aiuto;
- avere un figlio a carico.
Tutti i componenti del nucleo familiare (almeno 3 i componenti) devono essere, inoltre iscritti nell’anagrafe comunale e l’importo complessivo del contributo per ogni nucleo ammonta a 500 euro.
Il contributo non spetta ai nuclei che siano percettori di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza o altre misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà, Naspi e forme di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
Come richiedere la carta Dedicata a te
A differenza di altre misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, la social card “Dedicata a te”non deve essere richiesta. Essa viene assegnata d’ufficio direttamente dai Comuni ai cittadini che ne hanno diritto, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Viene erogata tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione presso gli uffici postali abilitati.
Le carte sono operative con accredito del contributo a partire da settembre 2024 con primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, mentre l’intera somma va utilizzata entro il 28 febbraio 2025.
Per avere informazioni sulla spettanza della misura è necessario rivolgersi quindi al proprio Comune, consultare il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https://www.lavoro.gov.it/ o il sito dell’INPS https://www.inps.it/it/it.html
A cosa serve
La social card è una carta elettronica che consente al titolare di acquistare beni di prima necessità e di sostenere alcune spese necessarie ossia:
- generi alimentari;
- prodotti per l’igiene personale e la casa;
- farmaci;
- bollette di luce, gas e acqua;
- ricariche/abbonamenti servizi di trasporto pubblico;
- canoni di locazione;
- assegni di frequenza per studenti.
Importo e modalità di utilizzo
L’importo della Social Card, come anticipato, è di 500 euro per nucleo familiare. La carta viene erogata in un’unica soluzione, salvo diverse disposizioni da parte dei Comuni. È possibile prelevare contanti presso gli sportelli ATM o effettuare pagamenti elettronici presso i negozi e le attività convenzionate.