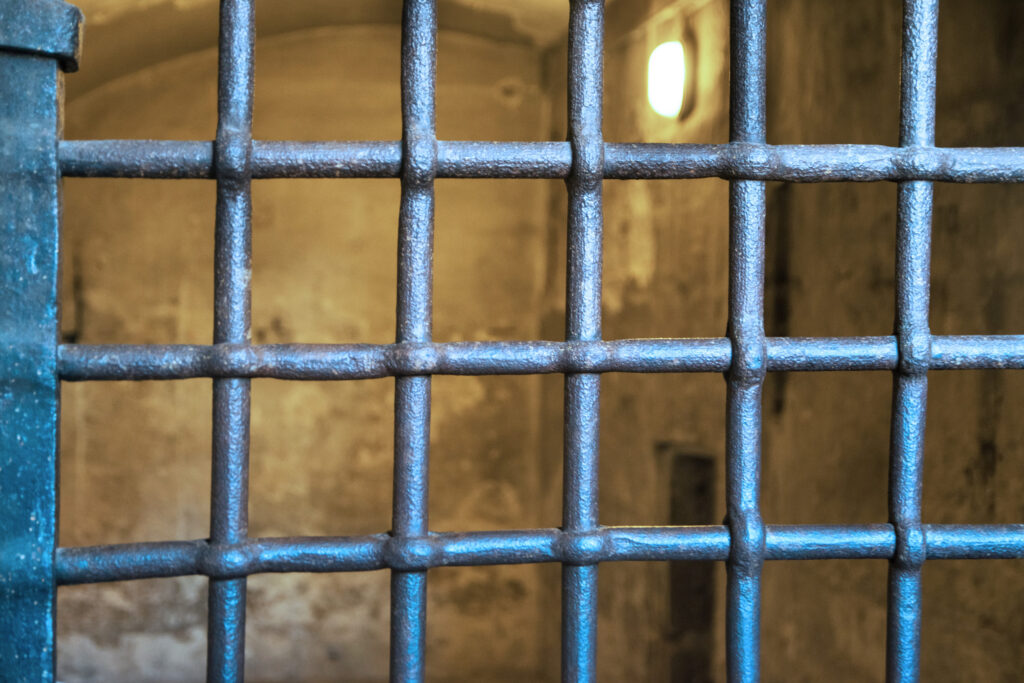Maltrattamenti in presenza o a danno di minori e sospensione della responsabilità genitoriale È legittima la comminazione obbligatoria della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per il delitto di maltrattamenti commesso in presenza ovvero a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale?
Quesito con risposta a cura di Daniela Cazzetta e Alessandra Fantauzzi
Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2 c.p. nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, comma 2, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. – Corte cost. 22 aprile 2025, n. 55 (sospensione della responsabilità genitoriale).
Il Tribunale di Siena sollevava questione di legittimità del reato succitato in quanto chiamato a giudicare sulla responsabilità penale di due genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia «perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalità educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori conviventi». Una volta riconosciuta quest’ultima, lo stesso riteneva ultronea nell’an e nel quantum l’applicazione della pena accessoria della sospensione dalla responsabilità genitoriale. La motivazione risiedeva nel lungo lasso temporale intercorso tra i fatti e il procedimento, nel corso del quale vi era stata una ricomposizione del nucleo familiare. In particolare, il giudice remittente contestava tanto l’obbligatorietà della sanzione conseguentemente alla pena per maltrattamenti quanto il suo lasso temporale (il doppio rispetto alla pena per maltrattamenti).
L’excursus del giudice di merito partiva da un richiamo alla precedente sentenza della Consulta 222/2018; essa descriveva la discrezionalità del giudice nel determinare la pena in concreto, in quanto naturale prosecuzione dei principi costituzionali. Applicando tali principi, il giudice a quo evidenziava come in questo caso le risposte sanzionatorie rischino di rivelarsi manifestatamente sproporzionate rispetto a casi meno gravi [1] e, di conseguenza, incompatibili con il principio di individualizzazione della pena ex artt. 3 e 27 Cost. Al contempo, viene richiamata l’ulteriore sent. 102/2020 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della pena accessoria obbligatoria della sospensione con riferimento al reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574bis, comma 3 c.p.).
I Giudici della Consulta illustravano preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo di doglianza, il quale era stato parametrato alla Convenzione dei Diritti del fanciullo. Quest’ultima veniva, infatti, evocata come riferimento immediato e non come norma interposta ai sensi dell’art. 117 Cost.
L’iter argomentativo proseguiva suddividendo la valutazione del quesito in due filoni: da una parte, la valutazione dell’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione (con riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.) e, dall’altra, la valutazione sul quantum.
Tre le sentenze della Corte costituzionale che si annoverano sul tema per motivare il primo quesito. Punto di partenza è costituito dalla sent. 31/2012. Con tale pronuncia la Corte si è espressa sul reato di alterazione di stato, in base al combinato disposto degli artt. 569 e 567, comma 2 c.p. In particolare, si evidenziava come ad essere coinvolto fosse l’interesse del figlio minore “a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione” (Corte cost. 31/2012). Il concetto è stato poi rimarcato dalla successiva sent. 7/2013, dichiarante l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p. e concluso con la sent. 102/2020 sull’illegittimità del delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero.
In particolare, l’interesse del minore ex artt. 30 Cost. e 147 c.c. è inevitabilmente coinvolto dalla decisione del Giudice della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Lo stesso si manifesta nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo che garantisca loro benessere, salute e crescita fisica e spirituali, sulla base delle condizioni socioeconomiche dei genitori. Solo il venir meno di tali obblighi, pertanto, giustifica la decadenza del genitore dal suo ruolo e sempre e unicamente per salvaguardare le esigenze educative e affettive del minore. In virtù del complesso equilibrio di diritti e doveri così delineato, “è irragionevole precludere «al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l’interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell’episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell’interesse»” (Corte cost. 22 aprile 2025, n. 55). La commissione del reato da parte del genitore, infatti, può costituire un indice delle mancanze provocate e non una irragionevole presunzione assoluta di inidoneità al ruolo. Diversamente, anche il minore si ritroverebbe ad essere direttamente colpito dalla sanzione e dalla conseguente perdita di diritti, poteri e obblighi che il genitore possiede nei suoi riguardi. Inoltre, tale circostanza risulta irragionevole anche alla luce del momento di comminazione, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza che spesso viene in essere molto dopo lo svolgimento dei fatti, con il rischio di interrompere percorsi di riparazione del rapporto affettivo, così come avvenuto nel caso di specie. A conclusione, la Corte indicava come assorbite le questioni ex artt. 27 e 29 Cost. e invitava il legislatore a meglio delineare la competenza in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale tra il giudice per i minorenni o ordinario.
A conclusione, la Corte dichiarava l’inammissibilità della questione inerente al quantum della pena per contraddittorietà della motivazione a quo.
[1] La «rigidità applicativa» che esse richiedono, infatti, determinerebbe risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso «rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi», non consentirebbe di tenere in considerazione l’interesse del minore alla preservazione del nucleo familiare e si rivelerebbe distonica rispetto al principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con violazione degli artt. 3 e 27 Cost.