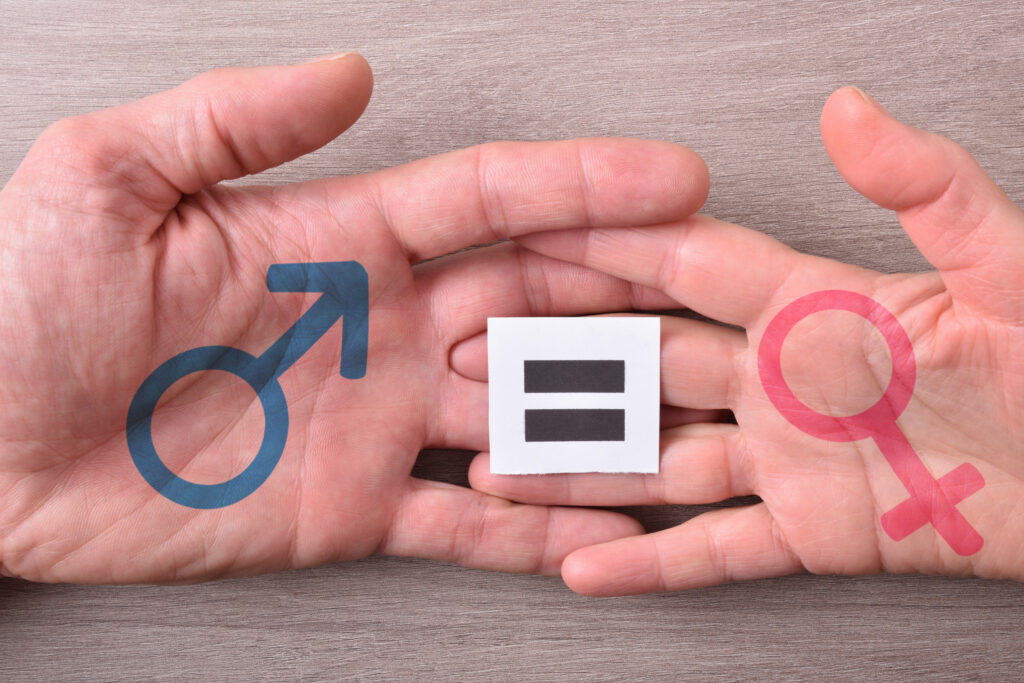Rottamazione quinquies: la nuova sanatoria 2025 Rottamazione quinquies: come funziona la sanatoria che nel 2025 consentirà ai contribuenti di pagare i debiti arretrati con il fisco
Rottamazione quinquies: le novità del ddl
E’ stato già soprannominato “rottamazione quinques” il disegno di legge 1375 che dal 25 febbraio è in corso di esame presso la Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato.
Il disegno di legge composto di due corposi articoli prevede significativi elementi di novità.
- Il contribuente avrà la possibilità di suddividere il debito con il fisco in 120 rate mensili (la prima con scadenza 31 luglio 2025) per la durata complessiva di 10 anni, un tempo mai previsto dalle precedenti rottamazioni.
- Il contribuente, diversamente da quanto previsto da alcune definizioni agevolate precedenti, non dovrà versare rate iniziali di importo elevato.
- Il contribuente andrà incontro alla perdita del diritto alla rateizzazione solo se non riuscirà a pagare otto rate mensili del piano di rientro, che possono essere anche non consecutive. Un approccio meno rigido quindi, in linea con la volontà di andare incontro alle difficoltà economiche che possono colpire chiunque nel corso della vita e che rendono più difficile fare fronte agli impegni economici.
Debiti fiscali rientranti nella rottamazione
Al momento il testo prevede l’estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023, senza dover corrispondere sanzioni, interessi, interessi di mora, aggi e somme ulteriori. Il contribuente si libera dal debito pagando solo il capitale e rimborsando le spese di notifica della cartella di pagamento e quelle per le procedure esecutive avviate.
Estensione rottamazione quinquies a regioni ed enti
L’articolo 2 del disegno di legge prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge anche gli enti territoriali potranno prevedere definizioni agevolate per il recupero delle somme non corrisposte dai contribuenti. Entro 30 giorni decorrenti dall’adozione del provvedimento per la definizione agevolata ne devono dare notizia mediante pubblicazione sul propri sito istituzione.
Come fare per aderire
Il disegno di legge prevede diversi passaggi per la rottamazione quinquies.
- L’agente della riscossione nell’area riservata indica al contribuente i carichi che possono essere definiti.
- Il debitore, entro il 30 aprile 2025 manifesta (o integra con i dati mancanti) la volontà di definire la propria posizione debitoria, compilando apposita dichiarazione in cui dichiara anche di rinunciare ai giudizi eventualmente pendenti. La presentazione della dichiarazione produce tutta una serie di effetti come la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive, la sospensione degli obblighi che derivano da dilazioni precedenti, l’impossibilità di procedere all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche.
- Entro il 30 giugno 2025 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno fatto richiesta l’importo totale delle somme dovute per la definizione agevolata.
- Il pagamento delle rate può essere effettuato con domiciliazione bancaria, con modelli di pagamento precompilati o presso l’agente della riscossione.
- Concluso il pagamento delle somme agevolate l’agente è discaricato dal residuo e comunica entro il 31 dicembre 2030 a ciascun ente interessato, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per consentire ai creditori l’aggiornamento delle scritture.
Ratio della rottamazione quinquies
La gestione del contenzioso tributario e il recupero crediti dell’Agenzia delle Entrate sono fondamentali per il bilancio pubblico e il rapporto con i contribuenti. Le definizioni agevolate, soprattutto la rottamazione quater, hanno favorito la regolarizzazione dei debiti fiscali, aumentando le entrate straordinarie e riducendo i procedimenti pendenti.
Occorre tenere presente che molti cittadini e imprese non evadono volutamente, ma affrontano difficoltà economiche aggravate da crisi e inflazione. L’accumulo di interessi e sanzioni rende il debito insostenibile, penalizzando chi vuole pagare, scoraggiando la regolarizzazione, e danneggiando i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.
La previsione di una nuova rottamazione rappresenta un passo ulteriore dell’opera riformatrice finalizzata a creare un clima di collaborazione tra ente impositore e contribuente. I dati rivelano il successo delle precedenti rottamazioni, che hanno consentito a imprese e cittadini di ripianare i debiti fiscali beneficiando delle agevolazioni previste di volta in volta.
L’approccio che intende seguire lo Stato è quello fondato sulla solidarietà, l’equità e una visione a lungo termine per costruire un rapporto basato sulla trasparenza e sulla fiducia.
Leggi anche Milleproroghe 2025: tutte le misure