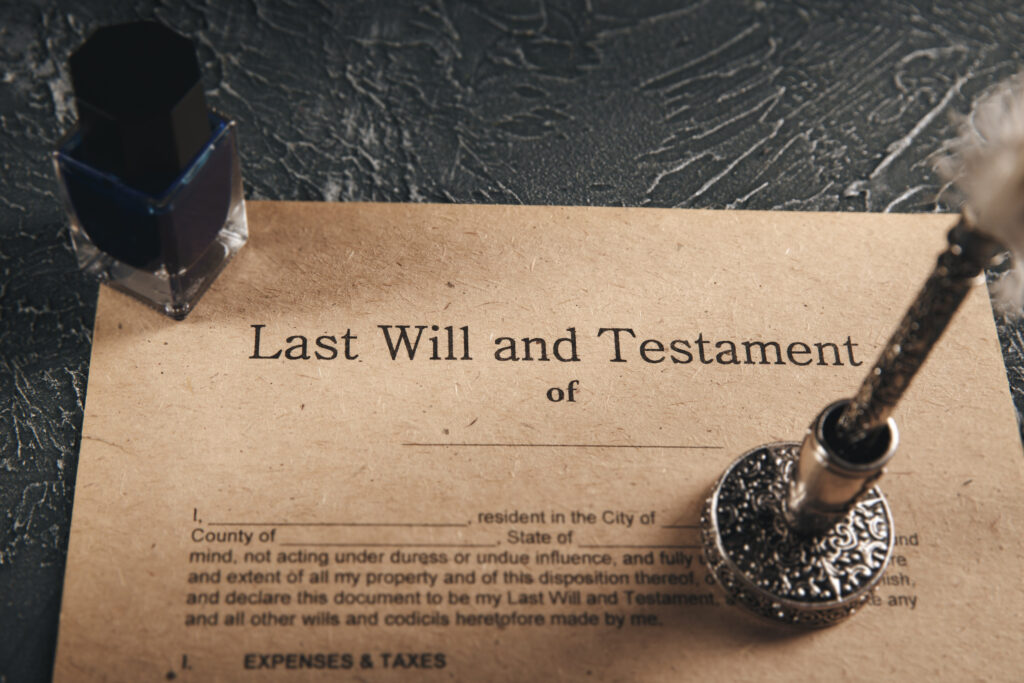Quesito con risposta a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima, Anna Libraro, Michela Pignatelli
L’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2024, n. 16 (casi di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a).
Nel decidere sul quesito formulato con l’ordinanza di rimessione, l’Adunanza Plenaria ritiene di dover confermare, nella sostanza, la soluzione seguita dalla Plenaria nel 2018, sia pure sulla base di un percorso argomentativo parzialmente diverso e con una integrazione, quanto alla individuazione delle ipotesi di ‘nullità della sentenza’.
Più precisamente, l’Adunanza Plenaria, ad integrazione di quanto statuito con le sentenze sopra citate del 2018, enuncia il seguente principio di diritto in ordine alle ipotesi di “nullità della sentenza”: “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
Il Collegio muove dalla conformazione costituzionale del processo amministrativo e dalla individuazione dei limiti entro cui le disposizioni del c.p.c. possono essere ad esso applicate precisando che, sotto il primo profilo, per il processo amministrativo il doppio grado di giudizio ha valore di regola costituzionale (art. 125 Cost.; Corte cost. 12 marzo 1975, n. 61, e 1° febbraio 1982, n. 8; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1983, n. 7409), e i casi di giurisdizione in unico grado davanti al Consiglio di Stato devono ritenersi eccezionali e basarsi su una espressa previsione normativa, anche dopo la pronuncia della Corte cost. 395/1988.
Rimarcano i Giudici che, il principio costituzionale del doppio grado del giudizio va interpretato alla luce, da un lato, dei principi del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo (artt. 111, comma 1, Cost.; 13 CEDU; 1 c.p.a.), e, dall’altro lato, della previsione costituzionale del limitato sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo, circoscritto “ai soli motivi inerenti alla giurisdizione” (art. 111, comma 8, Cost.) e più ristretto del sindacato di legittimità che la Corte di Cassazione esercita sulle sentenze del giudice civile per “violazione di legge” (art. 111, comma 7, Cost. e art. 360 c.p.c.).
Il principio del doppio grado di giudizio non implica che la parte abbia diritto a un pieno esame della causa nel merito in due gradi (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 giugno 1978, n. 18). Esso comporta, da un lato che, una volta che la causa sia stata decisa dal TAR, sia previsto il rimedio dell’appello, e, dall’altro lato, che la causa debba essere esaminata nel merito in primo grado, in presenza dei relativi presupposti e sulla base dei principi del giusto processo e di effettività della tutela.
Una pronuncia di merito in primo grado potrebbe dal soccombente essere ritenuta persuasiva senza necessità di appello, così evitando i costi di un secondo giudizio e contribuendo alla ragionevole durata del processo.
Le erronee sentenze di primo grado di mero rito, evidenziano i Giudici, non sono solo sentenze “ingiuste” e come tali appellabili, ma – nella misura in cui l’ordinamento non consentisse mai una regressione del giudizio – recherebbero anche un vulnus al principio del giusto processo.
La decisione in unico grado di merito innanzi al Consiglio di Stato, le cui sentenze non sono impugnabili per violazione di legge, non costituisce il modello del giudizio amministrativo disciplinato dagli artt. 111 e 125 Cost. e dal c.p.a., laddove hanno previsto il giusto processo e il doppio grado per i casi in cui il giudizio sia definito dall’organo di giustizia amministrativa di primo grado.
La mediazione tra il modello del ‘doppio grado di merito pieno’ – in cui tutti i motivi e tutte le questioni sono esaminati in due gradi – e l’evenienza pratica di un primo grado di mero rito, seguito da un unico grado di merito pieno in fase di appello, è lasciata al legislatore ordinario, chiamato a operare un ragionevole bilanciamento tra le esigenze del giusto processo e della sua ragionevole durata, e ad individuare, per il caso di erronee pronunce in rito, un modello intermedio tra un appello sempre cassatorio e un appello con effetto devolutivo pieno.
A tale bilanciamento il legislatore ordinario ha provveduto in modo differenziato nei diversi processi, con diversa ampiezza dei casi di regressione del giudizio in presenza di erronee pronunce in rito. L’art. 105 c.p.a. prevede un novero di ipotesi di regressione del processo ben più ampio di quello contemplato dall’art. 354 c.p.c.
Quanto ai limiti entro cui le disposizioni del c.p.c. possono essere applicate nel processo amministrativo, l’art. 39, comma 1, c.p.a. stabilisce che: “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
Orbene, sostiene il Collegio che la circostanza che una disposizione del processo civile sia espressione di un principio generale non giustifica di per sé sola l’estensione del principio processualcivilistico al processo amministrativo o il suo utilizzo come criterio ermeneutico.
Invero, la regolamentazione di una fattispecie concreta mediante i principi generali piuttosto che mediante disposizioni puntuali, è consentita dall’ordinamento positivo solo i) quando i principi siano gerarchicamente sovraordinati e siano pertanto prevalenti a prescindere da una lacuna dell’ordinamento (ad es. i principi eurounitari), ii) o quando vi sia una lacuna normativa da colmare (analogia iuris ex art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.), iii) o quando una legge stabilisca espressamente che i principi da essa enunciati prevalgono sulle sue regole puntuali o ne costituiscono criterio esegetico (v. ad es. art. 1, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
I Giudici affermano che nessuna di queste tre ipotesi è ravvisabile nel caso specifico, in quanto: i) il c.p.c. non è una fonte del diritto sovraordinata al c.p.a., ii) l’art. 105 c.p.a. non presenta alcuna lacuna, iii) nessuna disposizione del c.p.a. affida ai principi del processo civile una valenza di canone esegetico del c.p.a.
In particolare, il c.p.a. non contiene alcuna lacuna, quanto ai casi di regressione del giudizio e al c.d. effetto devolutivo, recando un’autonoma e compiuta disciplina di tali profili nel combinato disposto dell’art. 101, comma 2, e dell’art. 105 c.p.a., che non necessita di alcuna integrazione o esegesi sistematica, sicché di per sé non rileva per il processo amministrativo l’art. 354 c.p.c.
Si legge nella sentenza che è vero che l’art. 44, comma 1, L. 69/2009 individua tra le finalità del riassetto delle norme del processo amministrativo quella “di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali”, ma tale criterio della legge delega ha richiesto al legislatore delegato di effettuare una ricognizione e una trasposizione dei principi generali del processo all’interno del processo amministrativo, anche alla luce della pregressa prassi giurisprudenziale utilizzata al fine di colmare lacune della legge processuale amministrativa, e quindi individuando i principi generali del processo civile già ritenuti applicabili al processo amministrativo prima dell’entrata in vigore del c.p.a.
“Coordinamento” del c.p.a. con il c.p.c., si evidenzia nella decisione, non significa necessariamente pedissequa trasposizione, bensì adattamento alle peculiarità di un processo che risponde a diverse esigenze e ha una diversa struttura secondo la Costituzione.
In ogni caso, una volta esercitata la delega, i principi del processo civile possono regolare quello amministrativo solo alle condizioni stabilite dall’art. 39 c.p.a., ossia in presenza di una lacuna.
Il c.d. “effetto devolutivo” dell’appello dunque, quale lo si desume, a guisa di principio generale, dall’art. 354 c.p.c. non può essere ricostruito, per il processo amministrativo, in modo identico a come viene ricostruito in quello civile, perché differiscono sia la cornice costituzionale (‘doppio grado di merito’ costituzionalizzato nel primo e non nel secondo, caratterizzato dalla ricorribilità in Cassazione), sia le disposizioni applicabili (rispettivamente gli artt. 101 e 105 c.p.a. e l’art. 354 c.p.c.).
Ad avviso della Plenaria, ogni questione esegetica circa l’ambito applicativo dell’art. 105 c.p.a. va dunque risolta considerando il solo articolo suindicato, nella cornice del c.p.a. e dei principi costituzionali richiamati.
Sul piano dell’interpretazione letterale, logica e sistematica dell’art. 105, cit., il Collegio ritiene di dover analizzare e coordinare in modo armonico i seguenti “segmenti normativi”:
- a) “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se”;
- b) “è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza”;
- c) “o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio”.
Il primo segmento normativo, con l’espressione “soltanto se”, comporta che l’elenco dei casi di rimessione al primo giudice è tassativo e pertanto insuscettibile di interpretazione analogica. Quanto al secondo e al terzo segmento normativo, il Collegio evidenzia che i casi di rimessione al primo giudice sono individuati con una tecnica legislativa non omogenea.
Invero, il secondo segmento normativo si riferisce a tre vizi – afferenti al processo e alla decisione – individuati mediante tre ‘categorie generali’ che non corrispondono a tre “singoli vizi”, ma a tre “serie di vizi”, sicché le tre categorie vanno riempite di contenuto attraverso una ricognizione delle ipotesi normative e delle fattispecie concrete riconducibili nelle categorie generali.
Invece, il terzo segmento normativo si riferisce a quattro ipotesi puntuali di decisioni di rito erronee, univocamente corrispondenti a fattispecie previste da disposizioni processuali (erronea declinatoria della giurisdizione; erronea declinatoria della competenza; erronea estinzione del giudizio; erronea perenzione).
I Giudici ribadiscono quanto affermato dalle sentenze del 2018 dell’Adunanza Plenaria, sulla tassatività delle ipotesi previste dall’art. 105 e dunque sulla sua insuscettibilità di interpretazione analogica.
Tuttavia, ritiene l’Adunanza Plenaria, dato che la previsione contempla tre “categorie generali” di vizi del procedimento o del giudizio di primo grado, l’interprete deve riempirle di contenuto.
Si legge nella sentenza che, nell’individuazione delle fattispecie generali, occorre muovere dal rilievo che l’art. 105 non solo contempla distintamente le ipotesi in cui “è mancato il contraddittorio”, quella in cui “è stato leso il diritto di difesa di una delle parti”, e quella della “nullità della sentenza”, ma soprattutto contiene una formulazione ben più ampia di quella dell’art. 354 c.p.c., in cui la rimessione al primo giudice è prevista nei casi di mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte e nullità della sentenza nel solo caso di cui all’art. 161, comma 2, c.p.c.
Più precisamente, l’art. 354 c.p.c. menziona due sole fattispecie specifiche di mancanza del contraddittorio, non fa riferimento alcuno alla lesione del diritto di difesa e individua la nullità della sentenza con rinvio all’art. 161, comma 2, c.p.c., così circoscrivendola al solo difetto di sottoscrizione.
Invece, l’art. 105 c.p.a. si riferisce alla nullità della sentenza tout court, includendovi, oltre che il vizio formale di sottoscrizione, anche errori di giudizio, come hanno già rilevato dalle sent. 10, 11 e 15/2018 dell’Adunanza Plenaria.
Del resto, sostengono i Giudici, non può ritenersi che l’art. 105 abbia inteso riprodurre solo la previgente disciplina basata sulla distinzione tra gli “errores in procedendo” e gli “errores in iudicando”.
Nelle fattispecie, sia generali che puntuali, ivi previste, molte ipotesi sono di “errores in iudicando”, così la ‘nullità della sentenza, l’erronea declinatoria della giurisdizione o della competenza, l’erronea dichiarazione di estinzione o di perenzione del giudizio.
Il Collegio ricorda che già nel 1987, l’Adunanza Plenaria rilevò che – pur se si poteva ammettere un’approssimativa coincidenza fra l’ipotesi generica (“difetto di procedura”) dell’art. 35 L. 1034/1971, e le ipotesi specifiche elencate nell’art. 354 c.p.c. – il legislatore aveva utilizzato tecniche normative diverse: nel c.p.c., quella “dell’elencazione tassativa” che non può essere che di stretta interpretazione, e, nell’art. 35 della L. 1034/1971, quella della “formula generica”, la quale, se pur sostanzialmente coincidente, lasciava all’interprete la possibilità di aggiungere ulteriori ipotesi non previste dall’art. 354 c.p.c. (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 ottobre 1987, n. 24).
Inoltre, come già ricordato, la sentenza dell’Ad. Plen. 23/1996 ammise un’interpretazione estensiva, se non analogica, dell’art. 35 L. 1034/1971, includendo nell’erronea dichiarazione di difetto di competenza anche l’erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione.
L’approccio seguito dall’Adunanza Plenaria nel 1987 e nel 1993 viene ribadito nella sentenza, anche alla luce di quanto sopra osservato circa l’autonoma portata normativa dell’art. 105 c.p.a. rispetto all’art. 354 c.p.c.
Così come già l’art. 35 della L. 1034/1971 aveva utilizzato la tecnica delle “categorie generali”, anche il vigente art. 105 c.p.a. ha indicato, da un lato, ipotesi specifiche di annullamento con rinvio, e, dall’altro lato, tre ‘categorie generali’.
Inoltre, mentre il medesimo art. 35 menzionava espressamente il “difetto di procedura” tra i casi di annullamento con rinvio, tale locuzione non compare nell’art. 105.
Le stesse pronunce dell’Adunanza Plenaria del 2018, rimarcano i Giudici, con riferimento alla categoria della “nullità della sentenza”, vi hanno attribuito un contenuto “misto” tale da includere sia errori procedurali, quale il difetto di sottoscrizione, sia errori di giudizio, quale quello della motivazione mancante o apparente.
Orbene, venendo al caso oggetto dell’ordinanza di rimessione, l’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione dell’azione – con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi di ricorso – ben può, ad avviso del Collegio, integrare la ‘nullità della sentenza’, in armonia con i principi enunciati dalle sentenze dell’Ad. Plen. 10 e 11/2018, §47 e ss., e 15/2018, §7.3, sia pure con alcune precisazioni.
Per le citate sent. 10 e 11/2018, la ‘nullità della sentenza’ è ravvisabile non solo nel caso di motivazione “radicalmente assente”, ma anche nel caso di motivazione “meramente apparente”, che si ha quando essa è “palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta”, o “tautologica o assertiva, espressa attraverso mere formule di stile” o “richiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenuto”. “Più in generale, la motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del minimo costituzionale che si ricava dall’art. 111, comma 5 Cost. […] tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile […]. La motivazione apparente non è sindacabile dal giudice, in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato e dunque non è nemmeno integrabile, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture, ma una sentenza “congetturale” è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale – o, se si preferisce e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio – e, quindi, un atto di abdicazione alla potestas iudicandi […]. La nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione riguarda non solo le sentenze di rito (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità), ma anche quelle che recano un dispositivo di merito […] non sorretto da una reale motivazione”. […] “Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalità rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all’interno di esso”.
Sostiene il Collegio che, quando l’esclusione della legittimazione o dell’interesse a ricorrere è frutto di un palese errore, per effetto del quale è mancato l’esame della totalità dei motivi di ricorso, si determina per il ricorrente una situazione più grave rispetto all’erroneo diniego di giurisdizione o di competenza o all’errore in procedendo, posto che nelle prime due ipotesi non è negata la tutela giurisdizionale della posizione giuridica soggettiva e la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice indicato come avente giurisdizione o competenza, così conservando i due gradi di merito, e nel caso di errore in procedendo la sentenza esamina i motivi di ricorso, mentre nel caso di erronea declaratoria del difetto di legittimazione o di interesse è più radicalmente negata la sussistenza di una posizione tutelabile (e dunque non vi è alcun esame del merito, né la possibilità di ottenerlo riassumendo il giudizio davanti ad altro giudice di primo grado).
Il ricorrente, se vuole ottenere il riconoscimento della sussistenza di una posizione giuridica tutelabile in sede giurisdizionale (e dunque ottenere una pronuncia di merito), è pertanto onerato di proporre appello, con i relativi costi e tempi.
Ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la sentenza che nega la sussistenza della legittimazione o dell’interesse al ricorso – e dunque ravvisa l’assenza di una posizione giuridica tutelabile, malgrado vi sia stata l’impugnazione di un provvedimento autoritativo incontestabilmente devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo – deve basarsi su una motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa e delle censure dedotte in relazione alla lesione prospettata, e deve consentire di far comprendere in modo chiaro in fatto e in diritto l’effettiva sussistenza della ragione giuridica, posta a base della declaratoria di inammissibilità.
Per individuare il ‘chi’ possa impugnare il provvedimento autoritativo, la motivazione della sentenza deve tenere adeguatamente tenere conto della potenziale lesività dell’atto (ad esempio, sul patrimonio, sulla salute o anche sugli aspetti morali del ricorrente) e non è dunque sufficiente una riproduzione pedissequa dei fatti di causa e dei motivi di ricorso prospettati dalla parte, priva di vaglio critico da parte del giudice, né è sufficiente riportare gli orientamenti della giurisprudenza sulle condizioni dell’azione, ingiustificatamente negando la sussistenza di una posizione soggettiva tutelabile.
Occorre dunque per i Giudici una motivazione puntuale sulla specifica posizione dedotta in giudizio dalla parte ricorrente tenendo conto della situazione fattuale.
Ne consegue che, qualora la statuizione di inammissibilità si basi su una motivazione tautologica o sia frutto di un errore palese, in fatto o in diritto, che abbia per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso, si concreta il vizio di ‘nullità della sentenza’, che, secondo quanto statuito dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nel 2018, “deve essere valutato e apprezzato con riferimento alla sentenza nella sua globalità rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso”.
È appunto il confronto tra una motivazione di puro rito frutto di un errore palese e il ricorso proposto unitariamente inteso che rende evidente il grave difetto argomentativo di una tale motivazione rispetto al ricorso.
L’Adunanza Plenaria rileva che della nozione di “merito processuale” possono darsi diverse accezioni, come “fatti processuali” o come “motivi di ricorso”, esaminati nella sostanza, in contrapposizione ad una pronuncia di “rito” che non esamina il “merito”.
Le decisioni in rito di inammissibilità di un ricorso di primo grado, possono atteggiarsi in vario modo. Viene in considerazione la seguente principale casistica:
- a) decisioni di inammissibilità, che hanno omesso l’esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale (ad es., nelle controversie in materia edilizia, la concreta ubicazione del bene di proprietà del ricorrente ai fini della verifica della vicinitas, della legittimazione e dell’interesse al ricorso, le concrete caratteristiche dell’immobile costruendo);
- b) decisioni di inammissibilità, che non esaminano il merito inteso come motivi di ricorso;
- c) decisioni con doppia motivazione, in rito e in merito, che, pur dichiarando inammissibile un ricorso, esaminano “comunque” i motivi di ricorso;
- d) decisioni di inammissibilità in cui la declaratoria di inammissibilità è il risultato di una disamina di tutti o di alcuni motivi di ricorso.
Ad avviso dell’Adunanza Plenaria, la prima e la seconda ipotesi sopra delineate danno luogo ad una pronuncia di annullamento con rinvio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente, come già rilevato dalle sentenze del 2018 dell’Adunanza Plenaria, o in ragione di un errore palese di rito che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.
Nella terza e quarta ipotesi sopra delineate, vi è stato comunque un esame dei motivi di ricorso, che, anche se solo parziale, non giustifica un annullamento con rinvio, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, come si desume anche dall’art. 101, comma 2, c.p.a.
Ritiene il Collegio che tale ricostruzione del quadro normativo consente di rendere coerenti tra loro le fattispecie disciplinate dall’art. 105 c.p.a., in quanto sia nel caso della ‘nullità della sentenza’ (per palese errore di giudizio sulle condizioni dell’azione) che in quelli di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea estinzione o perenzione, viene in rilievo non qualsivoglia errore di giudizio, ma quell’errore di giudizio che ha per conseguenza il mancato esame della totalità dei motivi di ricorso.
Inoltre, siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 2, c.p.a. (che impongono l’annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall’art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.
L’Adunanza Plenaria non condivide gli argomenti addotti a sostegno dell’interpretazione che nega la regressione del giudizio quando il TAR abbia errato nell’individuare il ‘chi’ possa impugnare l’atto autoritativo ed abbia quindi errato nell’escludere una delle condizioni dell’azione.
Ad avviso del Collegio non risulta persuasivo l’argomento secondo cui il giudice di primo grado avrebbe esercitato e consumato comunque il suo potere, anche con la semplice pronunzia di rito, posto che questo si verifica anche nei casi di “nullità della sentenza” (già considerati dalle sentenze del 2018 dell’Adunanza Plenaria), di erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, erronea dichiarazione di estinzione del processo o di perenzione: in tutti tali casi, ciò che giustifica la regressione del processo è il mancato esame di qualsivoglia motivo di ricorso.
Quanto all’obiezione che l’interessato ha comunque avuto la possibilità di esperire entrambi i gradi di giudizio, rileva quanto sopra esposto su quale sia la effettiva portata del principio del doppio grado del giudizio amministrativo.
Quanto all’obiezione che il carattere devolutivo dell’appello imporrebbe un’interpretazione restrittiva della normativa sui casi di rimessione al TAR, rileva quanto sopra esposto sulla portata dell’effetto devolutivo dell’appello amministrativo e al significato della “tassatività” delle fattispecie previste dall’art. 105.
Non risulta persuasivo ad avviso dell’Adunanza Plenaria nemmeno l’argomento secondo cui l’estensione delle ipotesi di rimessione al primo giudice pregiudicherebbe la ragionevole durata del processo,
L’art. 105, comma 2, e l’art. 85, comma 3, c.p.a. disciplinano il rito camerale, più celere di quello ordinario, per gli appelli contro le sentenze dei TAR che hanno declinato la giurisdizione o la competenza e contro le ordinanze rese sull’opposizione a decreti di estinzione o improcedibilità. Tuttavia, un appello avverso una pronuncia di inammissibilità, in cui si lamenti la ‘nullità della sentenza’ nei sensi sopra visti, si può comporre con un solo motivo (volto a far rilevare l’ammissibilità del ricorso) ed è destinato o al rigetto o all’accoglimento con annullamento con rinvio, senza esame del merito da parte del giudice di appello.
Trovano pertanto applicazione gli artt. 72 e 72bis c.p.a. sulla fissazione con priorità dell’udienza pubblica, trattandosi di un ricorso vertente su un’unica questione, e sulla trattazione in camera di consiglio con i termini propri del rito cautelare, trattandosi di un appello suscettibile di immediata definizione.
La parte appellante, evidenzia il Collegio, ha inoltre la possibilità di chiedere l’abbreviazione dei termini, sicché l’appello contro la statuizione di inammissibilità può essere definito rapidamente, senza nocumento per la ragionevole durata del processo.
(*Contributo in tema di “L’adunanza plenaria torna sui casi di rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a”, a cura di Claudia Buonsante, Giusy Casamassima, Anna Libraro, Michela Pignatelli, estratto da Obiettivo Magistrato n. 85 / Maggio 2025 – La guida per affrontare il concorso – Dike Giuridica)